Misurare il cambiamento: femminismo, libertà e responsabilità nel 2026
Maria Cristina Ianiro
Parlare di femminismo nel 2026 significa chiedersi quanto davvero sia cambiato il mondo per le donne, non solo dentro le nostre vite ma nelle strutture che le determinano. Ogni fine d’anno riapre la stessa domanda: quanto è avanzata la parità di genere nei fatti, non nelle intenzioni? La retorica del successo personale spinge a contare traguardi individuali, ma il progresso femminista si misura nei diritti garantiti, nella giustizia sociale, nelle politiche di uguaglianza che cambiano la vita collettiva.
Questa agenda femminista per il 2026 non è un elenco di giornate simboliche ma una mappa di sei propositi concreti per costruire una società più equa. Ogni proposito è legato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e affronta le sfide reali di un cambiamento strutturale: educazione, salute, lavoro, ambiente, rappresentanza, linguaggio.
Perché la parità non è un traguardo astratto, ma un cantiere aperto: e la libertà delle donne resta la misura più onesta del progresso di tutti.
1. Sapere e libertà: educazione come infrastruttura dell’emancipazione
2. Il corpo politico: diritti sessuali e salute come giustizia sociale
3. Ridistribuire il valore: lavoro, cura ed economia della parità
4. Istituzioni che curano: politica, potere e prevenzione
5. La politica della vita: ambiente, cura e intersezioni
6. Scrivere un altro lessico del potere: linguaggi, algoritmi, responsabilità
7. Verso un nuovo patto femminista
8. Fonti
1. Sapere e libertà: educazione come infrastruttura dell’emancipazione
Nel mondo, 133 milioni di ragazze non frequentano la scuola: un dato che l’UNESCO continua a definire “una delle emergenze più sottovalutate del nostro tempo”. Dietro quel numero, si nascondono soprattutto delle nazioni dove studiare è un atto politico: le aule diventano spazi di resistenza e il sapere è l’unico mezzo per sottrarsi a un destino già scritto. L’UNICEF ricorda che ogni anno di istruzione in più riduce fino al 10% il rischio di matrimonio precoce e aumenta le possibilità di indipendenza economica nella vita adulta. Ma l’educazione non è solo accesso materiale: è la capacità di pensare se stesse al di fuori dello sguardo dominante.
Per questo il sapere non è un bene neutro, ma un luogo di potere. In molti Paesi, le disuguaglianze educative sono amplificate da crisi multiple: guerre, cambiamento climatico, povertà digitale, che colpiscono le ragazze con più forza di chiunque altro. Così, la scuola diventa lo specchio di un mondo che ancora non garantisce pari dignità alla conoscenza femminile. Il sapere, dunque, è infrastruttura di ogni altro diritto. investire nell’educazione delle ragazze non è un atto di filantropia, ma un atto di giustizia strutturale, una scelta che incide sulle economie, sulla salute pubblica, sulla tenuta democratica delle società.
2. Il corpo politico: diritti sessuali e salute come giustizia sociale
La questione educativa non può essere separata dal corpo e dai diritti che lo attraversano: se la conoscenza forma coscienza, è proprio attraverso la libertà di scelta, fisica, simbolica e sessuale, che l’educazione si traduce in emancipazione.
Quando si parla del corpo, infatti, non si può pensare che sia un capitolo personale relegabile alla sfera privata. Il corpo è nodo politico, giuridico e culturale che definisce libertà, sicurezza e cittadinanza. Oggi oltre 200–230 milioni di donne e ragazze nel mondo hanno subito mutilazioni genitali e milioni sono ancora a rischio, una cifra che racconta come pratiche tradizionali e gerarchie di genere si traducano in violazione dei diritti umani. Allo stesso tempo, le politiche sui diritti riproduttivi restano frammentarie e contese in molte giurisdizioni, rimettendo in gioco l’autonomia delle donne in termini concreti.

Ma il corpo non è solo biologia: è il primo territorio politico della libertà. Difendere i diritti sessuali e riproduttivi significa lavorare sulle norme che regolano consenso e coercizione, ma anche sostenere le voci locali che contestano pratiche dannose e costruire reti di alleanza tra istituzioni, ONG e comunità.
La salute riproduttiva non è un capitolo sanitario a sé: implica accesso, informazione, leggi, ma anche legittimazione sociale di scelte spesso osteggiate. In molti contesti l’assenza di servizi, l’impoverimento dei sistemi sanitari e le pressioni normative limitano l’autodeterminazione delle donne e delle ragazze. D’altra parte, dati e studi mostrano come investire nella salute riproduttiva migliori indicatori di sviluppo e autonomie reali.
L’autodeterminazione è una questione di giustizia sociale. Difendere il corpo femminile significa costruire politiche pubbliche che trasformino la vulnerabilità in diritto, e ricordare che nessuna libertà è davvero tale se non passa anche per la libertà del corpo.
3. Ridistribuire il valore: lavoro, cura ed economia della parità
La libertà di pensiero e la sovranità sul corpo restano fragili se non si traducono in autonomia economica. La dimensione materiale del femminismo si misura ancora nella possibilità concreta di vivere del proprio lavoro, di scegliere se e come partecipare a un sistema che spesso esclude o svaluta.
I rapporti internazionali segnalano che la chiusura del divario di genere procede a passi lenti e diseguali: il Global Gender Gap mostra progressi ma mantiene una disparità strutturale su lavoro, retribuzione e opportunità. Parlare di inclusione senza confrontare il tema del lavoro di cura, della segregazione occupazionale e della trasparenza salariale significa accettare una parità nominale che lascia intatti i rapporti di potere economici.
Ma il lavoro non è solo reddito: è il cuore della cura. Le stime indicano che centinaia di milioni di donne sono escluse dalla forza lavoro retribuita proprio per responsabilità di cura non pagata. Questo lavoro, necessario alle economie e al benessere, resta invisibile nelle misure del valore e nella contabilità pubblica.
Riconoscere, redistribuire e rappresentare la cura significa trasformare la società.
La vita di molte donne è organizzata attorno a un’invisibilità che limita scelta e mobilità. Un progetto femminista credibile chiede di ripensare il welfare: congedi paritari, servizi di cura accessibili, sistemi fiscali equi e riconoscimento economico del lavoro domestico.
L’economia della parità non è beneficenza, ma redistribuzione di potere e tempo. Senza una riforma strutturale della cura, la parità resta un’illusione.
4. Istituzioni che curano: politica, potere e prevenzione
I dati mostrano un aumento lento ma reale della presenza femminile nei parlamenti a livello globale, tuttavia la rappresentanza resta spesso marginale nei ruoli decisionali chiave: numeri che migliorano non bastano se non mutano le pratiche del potere. La questione politica, dal municipalismo alle stanze del governo, è prima di tutto culturale: chi prende decisioni determina priorità di spesa, agende sociali, visioni di welfare.

La rappresentanza è un fatto di linguaggio e di potere. Un femminismo di sostanza non può limitarsi a contare seggi, ma deve chiedersi come la presenza femminile altera processi e pratiche: quali temi entrano in agenda quando le donne sono attive e sostenute? Come si trasformano i linguaggi istituzionali?
Dove il potere non ascolta e la salute non protegge, la violenza diventa struttura: il fallimento istituzionale si traduce in ferite fisiche e simboliche, nella vita e nel linguaggio. Le stime internazionali sono drammatiche: circa una donna su tre subisce, nel corso della vita, violenza fisica o sessuale.
Costruire delle istituzioni che curano, significa ripensare la prevenzione come funzione pubblica. Non solo intervenire quando la violenza è già accaduta, ma agire sulle cause: disuguaglianza economica, norme patriarcali, retoriche che legittimano il controllo.
Una sanità che riconosca la libertà riproduttiva, una giustizia che protegga senza colpevolizzare, una rappresentanza che rispecchi la complessità del vivere femminile: queste non sono concessioni, ma elementi di cittadinanza piena. Il potere che non cura non governa: domina.
5. La politica della vita: ambiente, cura e intersezioni
La crisi climatica non è neutra dal punto di vista del genere: nelle situazioni di povertà e nelle catastrofi ambientali le donne sono le prime a subire gli impatti più gravi perché spesso hanno appunto responsabilità di cura e meno accesso a risorse e potere decisionale.
Ma il tema non è solo la vulnerabilità. Le donne sono agenti di resilienza e custodi di pratiche sostenibili nelle comunità. Un’agenda femminista critica mette la transizione ecologica in stretta relazione con la giustizia di genere: significa progettare politiche climatiche che promuovano partecipazione femminile, riconoscano conoscenze locali e ripensino l’economia in chiave di cura della vita, non di profitto.
Qui l’intersezionalità diventa essenziale. Le crisi non colpiscono tutte nello stesso modo: il genere si intreccia con razza, classe, disabilità, provenienza. Parlare di giustizia climatica o sociale senza parlare di intersezionalità significa guardare il mondo da un solo punto di vista e chiamarlo universale.
Una politica della vita è una politica dell’ascolto e della differenza. Riconoscere oppressioni multiple, disegnare soluzioni proporzionate, costruire alleanze tra movimenti ecologisti, femministi e decoloniali significa pensare la giustizia come equilibrio, non come dominio.
6. Scrivere un altro lessico del potere: linguaggi, algoritmi, responsabilità
Se l’intersezionalità svela come le oppressioni si moltiplicano, il digitale mostra come si automatizzano. I bias di genere negli algoritmi riproducono su scala globale ciò che la società non ha mai smesso di codificare: chi parla, chi tace e chi viene creduto.
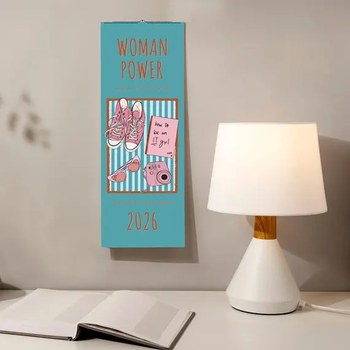
Il digitale è il nuovo spazio pubblico: chi lo abita determina visibilità, partecipazione e potere. Tuttavia, studi e report evidenziano come le donne siano sottorappresentate nelle professioni tech, esposte a violenze online e vittime di algoritmi che riproducono pregiudizi: una combinazione che erode la libertà politica e culturale delle donne nella contemporaneità.
Il linguaggio è il primo algoritmo sociale: ogni discorso plasma realtà. Quando i media, le piattaforme e la retorica politica normalizzano la violenza simbolica, il passo verso quella fisica si accorcia. Propaganda, disinformazione e linguaggio d’odio non sono fenomeni paralleli ma carburante della violenza di genere.
Un femminismo critico oggi deve reclamare trasparenza, sicurezza e responsabilità digitale.
Ciò significa anche ripensare l’educazione mediatica e la governance tecnologica come spazi di democrazia.
La responsabilità, allora, è la forma più alta di relazione: non solo monitoraggio e indicatori, ma etica della parola. Le storie che raccontiamo, e quelle che non raccontiamo, sono la misura del cambiamento.
7. Verso un nuovo patto femminista
Le sei direttrici di questa agenda - sapere, corpo, lavoro, istituzioni, ambiente, linguaggio - non sono capitoli separati, ma una mappa interdipendente della libertà. Dalla scuola al corpo, dal lavoro alla tecnologia, ogni ambito mostra che la libertà non è introspezione, ma redistribuzione di tempo, potere, risorse e parole.
Il femminismo del 2026 non si limita a denunciare, ma costruisce: istituzioni che curano; economie che non sfruttano; tecnologie che non discriminano; linguaggi che non feriscono.
Se la modernità ha edificato la libertà sull’indipendenza, il femminismo la riscrive sull’interdipendenza: riconosce la vulnerabilità come condizione comune e la trasforma in etica collettiva.
“Non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali tra disuguali”, così don Milani si esprimeva in Lettera ad una professoressa (1967): il futuro femminista non è una meta, ma una pratica per non lasciare indietro nessuno.
Costruire una società equa significa cambiare la misura del progresso: non la crescita, ma la cura; non l’accumulo, ma la giustizia; non la forza, ma la relazione.
8. Fonti
Desk, E. (2025, October 21). “Over 133 million girls worldwide still not enrolled in school: UNESCO”. EdexLive.
“Female genital mutilation”. (n.d.). United Nations Population Fund. Ultima data di consultazione 5/11/25,
“Gender gap report 2025”. (n.d.). World Economic Forum. ltima data di consultazione 7/11/25
Ianiro, M. C. (2021). “Urgenza climatica: “Ok, boomer” non basta”. CanadaUsa.
Ianiro, M. C. (2025). “Dalle piazze globali alle bolle digitali: Social media, attivismo e crisi di autorevolezza”. CanadaUsa.
Ianiro, M. C., & Regoli, G. (2022). “Double Standard: Cosa è e perché combatterlo”. CanadaUsa.
“IPU report: Parliamentary gender gap narrowed over the past 30 years but progress stalled in 2024”. (2024). Inter-Parliamentary Union. Ultima data di consultazione 5/11/25
“ONU Italia La nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”. (2019, March 14). ONU Italia.
“Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2025”. (2025.). UN Women – Headquarters. Ultima data di consultazione 5/11/25
“The state of the global education crisis”. (n.d.). UNICEF.
“Unpaid care work prevents 708 million women from participating in the labour market.” (2024, October 29). International Labour Organization.
”What you need to know about how UNESCO advances education and gender.” (2025, June 10).
“Devastatingly pervasive: 1 in 3 women globally experience violence”. 2021, March 9. World Health Organization: WHO.
“WHO addresses violence against women as a gender equality and health priority.” 2023, July 17. World Health Organization: WHO.
“Ilo Care Brief”.June 2025. International Labour Organization