A Single Man, uno scomodo uomo qualunque
Claudio Ciccotti
Siamo nel dicembre del 1952 e Isherwood comincia a scrivere The Day’s Journey, la prima bozza di una sceneggiatura destinata a un film omonimo. Da qui parte il viaggio che lo porterà alla pubblicazione nel 1964 di quello che poi avrebbe definito il suo capolavoro: il romanzo A Single Man.
1. A Single Man tra influenze e impasse
2. George, il protagonista scomodo
3. George in equilibrio tra il nichilismo e la resistenza
4. L’altro e l’odio
5. Conclusione
6. Bibliografia
7. Sitografia
1. A Single Man tra influenze e impasse
Dismessa la volontà di creare un copione per il grande schermo, Isherwood si dedica alla stesura di un romanzo.
L’opera avrebbe avuto per protagonista una donna inglese da seguire nell’arco di un’intera giornata. L’intento di Isherwood faceva eco senza troppi misteri a Mrs Dalloway (1925) di Virginia Woolf, testo che aveva apprezzato molto.
Qualcosa, però, lo metteva in difficoltà. Non si trattava solo del fatto che nella sua mente imperasse come termine di paragone una delle opere più belle che avesse mai letto (romanzo, poema in prosa o qualunque altra opera unica nel suo genere la Woolf avesse creato, dando alle stampe quel titolo).
Deus ex machina, il suo compagno Don Bachardy fa un commento salvifico per l’impasse narrativo (e non solo) in cui si trova Isherwood: gli sarebbe bastato cambiare il soggetto del romanzo, dimenticandosi del personaggio femminile, per passare, invece, a un uomo inglese. Così The Englishwoman poteva diventare The Englishman, basato su un nuovo protagonista in grado di essere al contempo specchio e chiave di lettura dell’animo dell’autore.
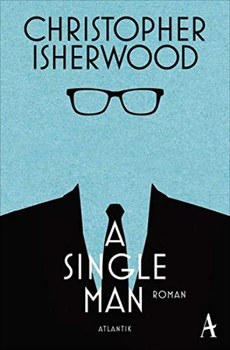
Il protagonista avrebbe dovuto riflettere a pieno l’animo di Isherwood tra gli anni ‘50 e ‘60, per come lo troviamo descritto anche nelle pagine dei suoi diari personali. Sono pagine che presentano Isherwood alle prese con lo scorrere del tempo e dell’età che avanza; pagine segnate dalla lotta alla sopravvivenza e dallo spettro minaccioso di una guerra atomica pronta a duplicare all’improvviso la strage giapponese del ventennio precedente; pagine che soffocano sotto il peso dei canoni sessuali che da lì a poco sarebbero stati messi in discussione con i moti di Stonewall.
Sono anche gli anni della ri-definizione di tutti e tutto, partendo dal piccolo degli spazi fisici personali, per arrivare poi a percepirsi come parte di un contesto più ampio, segnato dalle crisi internazionali.
The Englishman era così pronto a diventare A Single Man.
2. George, il protagonista scomodo
Il libro si apre con il risveglio di George Falconer nel suo letto. George è un uomo britannico di 58 anni espatriato a Santa Monica, insegnante di letteratura inglese all’università di Los Angeles. Vive da solo in una casa che fino a poco tempo prima condivideva con Jim, il suo compagno, morto in un incidente stradale in Ohio.
Approfittando del fatto che la notizia non sia ancora giunta in California, George decide di non rivelare a tutti la verità (soprattutto ai suoi vicini omofobi e ficcanaso), fingendo piuttosto che Jim (che non viene mai chiamato “partner” o in altri modi affini) sia tornato a stare a casa dei suoi, portando con sé anche tutti i loro animali.
Pagina dopo pagina, a metà strada tra un flusso di coscienza e un piano sequenza cinematografico, l’occhio del narratore non si scolla da George e ci accompagna lungo la sua giornata.
Così, ci vengono descritte quelle che, all’apparenza, sembrano una serie di attività di routine e senza alcun tipo di eccezionalità: alzarsi; fare colazione; andare in bagno; leggere; lamentarsi e discutere con i vicini di casa; andare a lavoro, in palestra, a fare la spesa e a far visita a una vecchia amica in ospedale; ubriacarsi con un’altra sua amica; continuare a bere al bar con uno studente in balia di un flirt platonico e malamente velato; fare il bagno nell’oceano in piena notte; tornare a casa e mettersi a letto.

In realtà, è proprio dietro questa semplicità che si cela l’equilibrio tra il nichilismo e la resistenza di George che sorreggono tutto il romanzo. Un equilibrio però precario, affidato a una figura scomoda per il lettore americano medio degli anni ‘60.
Scomoda - perché la solitudine di George, dapprima imposta come un brutto scherzo del destino, diventa poi una sua scelta consapevole. Questa scelta è rappresentata simbolicamente da quella maschera che indossa ogni mattina per presentarsi a tutti nell’esatto modo in cui si aspettano di trovarlo. La sua maschera, però, non è uno scudo invincibile.
Scomoda - perché la narrazione al tempo presente, piatta, asciutta e cruda, ci costringe a un compromesso subdolo: noi siamo dei semplici spettatori della vita di George; possiamo assistere a tutto quello che fa, vederlo naufragare e riemergere nel mare dei suoi pensieri, ma non possiamo intervenire.
Quel tempo presente rafforza il nostro coinvolgimento emotivo ma segna un netto distacco dei ruoli, tra lui e noi. Quel narratore onnisciente e onnipresente ci costringe a seguire George in balia di un dolore che non viene mai riconosciuto, accettato e chiamato per quel che è. Tra salti nel passato e ritorni al presente, flussi di coscienza, scatti d’ira e pulsioni alla vita, deve essere il lettore a farlo.
Ed è qui che arriva la scomodità più grossa. Il lettore deve fare i conti con sensazioni comuni a tutti - abbandono, solitudine, interrogativi sul proprio destino e dubbi su chi gli sta attorno - con cui è impossibile non empatizzare. Ma quanti, agli inizi degli anni ‘60 negli Stati Uniti, avrebbero davvero empatizzato con un omosessuale, scelto come uomo qualunque?
Quanti avrebbero davvero alzato le braccia in segno di resa, ammettendo che di fronte a queste sensazioni siamo tutti uguali, riconoscendo a George la loro stessa dignità di esseri umani?
3. George in equilibrio tra il nichilismo e la resistenza
Sulla bilancia, appena sveglio, George si chiede a che scopo continui ad andare in palestra se i risultati non si vedono. Basta qualche manciata di secondi perché si guardi allo specchio, veda i suoi occhi stanchi e scatti alla volta di una nuova giornata. Ed eccoci qui a familiarizzare già nelle primissime pagine del romanzo con la costante altalena tra nichilismo e resistenza.
Queste due condizioni si susseguono rapide nella narrazione, quasi come se Isherwood voglia sottolineare che i due concetti antagonisti sono separati, in realtà, da una linea molto sottile, sconfinata ora dall’uno, ora dall’altro.
E ci sembra di vederlo, George, mentre percorre quella linea. Lo fa con la stessa velocità a cui guida la sua macchina lungo l’autostrada che lo porta a lavoro, lasciandosi alle spalle la solitudine della sua casa.
Proprio queste due ambientazioni (il luogo di lavoro e la casa) sono il teatro della resistenza e del nichilismo del protagonista.
A scuola, George vorrebbe urlare qualcosa agli studenti che vogliono iscriversi all’università e che sono numericamente superiori ai posti disponibili nei corsi. Assistiamo spesso a slanci come questo ma i pensieri non sono mai seguiti da gesta concrete. È come se la gran parte delle azioni prendessero vita solo nella testa di George (p. 38).
Proprio come i pensieri sulle folle alle macchinette o sui ragazzi che giocano a tennis e che risvegliano la sua eccitazione ormai sopita (p. 43). Quando George invece passa all’azione, lo fa spesso senza che questa sia preceduta da vere riflessioni oppure come risposta a una pressione ormai giunta al capolinea. Durante questi episodi capiamo che c’è ancora spazio per la sua resistenza.
Lo fa a pranzo coi colleghi e lo fa, ancor di più, in classe coi suoi studenti: la discussione sul romanzo After Many a Summer (1939) di Aldous Huxley di fronte a un pubblico di studenti passivi porta il professore a riflettere con ardore su temi quali l’emarginazione e l’esclusione - due condizioni che vorrebbe che i suoi studenti imparassero a riconoscere e a ribaltare. Lui stesso la mattina, poche ore prima, apriva e chiudeva i libri inquieto, alla ricerca di risposte che aveva smesso di cercare, rassegnato.

Come contraltare, invece, possiamo immaginare la casa del protagonista come un vero e proprio prolungamento sensoriale e fisico di George. Isherwood la descrive “piccola, concepita stretta. Spesso si sente protetto da questa piccolezza; non c’è abbastanza spazio per sentirsi soli” (p. 11) proprio come il corpo del professore alto un metro e settanta, che sembra pieno di tanti George concentrici via via più piccoli, posti a protezione di un io più nascosto.
Proprio a quel piccolo George torna il protagonista nei suoi momenti di nostalgia - dopo gli spasimi che fanno male; dopo aver ucciso le formiche impotenti sotto il suo colpo; quando pensa alla tata che gli cantava la filastrocca per fargli mangiare le uova a colazione.
La sua casa però non è davvero isolata: messa di traverso rispetto alla strada, sembra volersene stare in disparte, mantenendo comunque sempre un occhio vigile verso il cortile dei vicini - un mondo che la esclude e da cui si apparta a sua volta; che la turba, ma che lei stessa inquieta già solo con la sua presenza.
Mentre lui è seduto in bagno, gli altri possono vedere solo una parte di lui dalla finestra, non sanno cosa faccia davvero: lui avrà sempre modo di mascherarsi e presentare il George che vuole, proprio come quando al telefono risponde e mente sul suo stato d’animo (p. 14).
Nonostante questo, però, esistono dei ponti che connettono rapidamente al resto, come quello che unisce casa sua al quartiere. È così che lui può andare via e che i suoi vicini possono raggiungerlo. La casa, con queste funzioni e questa fattezza, è una proiezione in scala maggiore del suo approccio al mondo, sempre in bilico tra scatti di forza e impotenza, di esclusione e separazione.
La resistenza e il nichilismo assumono un contorno ancora più marcato sullo sfondo delle vicende internazionali che trapelano tra una riga e l’altra del romanzo. Castro ha trasformato Cuba in un teatro del terrore a cielo aperto, mettendo la Baia dei Porci al centro dello scacchiere internazionale. Castro è l’emblema della paura, dell’odio verso ogni alterità (dal politico al religioso, dall’etnico al sessuale).
L’altro è una minaccia costante per la quieta borghesia californiana - quella nuova city upon a hill, temprata dai drink, dall’odore del barbecue, dai prati da golf, dalla televisione e dalle spese folli ai nuovi supermarket.
4. L’altro e l’odio
Su questo sfondo si staglia George, l’altro. Lui è quello di cui avere paura e da combattere. Lui è quello che descrive la festa dei vicini come una telecamera nascosta (che strizza l’occhio a I am a Camera, scritto da Isherwood qualche anno prima).
George registra le risate e gli spostamenti di tutti, come se a lui quella felicità non solo non fosse concessa qui e ora, ma non gli fosse permessa in generale. A lui è affidato il ruolo del personaggio di disturbo per quell’aria gioviale, quel brusio di sottofondo alla quiete del party.
A tenere lontano George dalla quiete ci pensano anche le figure poste ai cancelli di guardia del benessere famigliare: quei padri rozzi e quelle madri preoccupate per i loro figli, che vogliono fare le brave vicine di casa e usare i loro manuali mondani di pedagogia come cartine al tornasole per tutte le dinamiche umane.
Tutto è recitato secondo un sapiente gioco di maschere indossate sulla porta di casa, con inviti proposti e accolti, ma mai trasformati in realtà, lamentele sui rumori nel cortile o un finto interesse verso Jim, un assente mai riconosciuto per il suo vero ruolo.

George è uno straniero (p. 45) e, nel suo essere estraneo al mondo, ha una sua dimensione e gli sta comoda. Questo gli permette di recitare un gioco crudele che solo in parte ha delle regole condivise con altri giocatori. Per questo, forte della sua posizione di privilegio, ghigna soddisfatto ed eccitato. Cosa accade però quando inizia a dubitare che in questo gioco anche altri in realtà potrebbero riservare degli assi nella manica?
Eccolo sospettare degli studenti: in classe, ridono perché stanno pensando a come prendersi beffa di lui e dell’intero sistema educativo? Gli studenti rappresentano in piccolo la società multiforme a cui appartengono: sono incuriositi da ciò che non conoscono ma non così tanto da sentirsi stimolati a uscire dalla loro comfort zone; fanno quindi il minimo indispensabile, tanto in un modo o nell’altro ce la faranno sempre a passarla liscia, un po’ come quando George li perdona per non aver letto un libro o per il fatto che non conoscano un autore: recupereranno tutto per la prossima lezione.
Tutto questo pesa sulla sua condizione di uomo ai margini, facendo sì che a ogni minimo rumore, a ogni più piccolo episodio, la sua maschera si trasformi nel coperchio di una pentola a pressione.
I rumori sono tanti: lo sparo della pistola giocattolo dei bambini dei vicini è così fastidioso che le interiora della bilancia rotta tra i rifiuti sono paragonate a quelle di George in preda al colon irritato; i suoi denti stridono; il telefono squilla; il martello picchia; qualcuno bussa alla sua porta; grandi e bambini gridano durante le feste in cortile; i lavori per la realizzazione del nuovo edificio universitario disturbano le lezioni.
Tutto questo aumenta la pressione. L’ebollizione si fa spazio spigolosamente riga dopo riga: i gomiti di George sbattono sempre più di frequente mentre scende le scale della casa; le finestre da cui osservare ed essere osservato sono sempre molto squadrate; i paesaggi per giungere in città sono tutti segnati da colline decapitate per far posto a nuove costruzioni.
È sullo sfondo del viaggio in auto che la pressione comincia a sentirsi in una forma inedita anche nella narrazione. George sfreccia per le strade in auto, guidando veloce tra i pedoni, diretto all’università. Lo seguiamo con una narrazione velocissima: un capoverso di poche frasi, molto lunghe, piene di incisi e parentesi. Trafelati, seguiamo il filo dei pensieri di George che si chiede come fare a vendicarsi dell’odio di una società intrisa di mascolinità tossica.
La sua mente viaggia altrettanto veloce passando in rassegna varie immagini a cui mette fine con un secco "no": non può lasciare che la società se la cavi con così poco. Le immagini diventano sempre più cruente, accompagnate da un paesaggio sempre più squadrato e duro. Un attimo - George rallenta preso dal panico: lui è davvero così cattivo? Oppure sta vivendo di riflesso la pressione della maschera che ha messo sul volto per sopravvivere in una società da cui è escluso (e si esclude)?
Un profumo di fratellanza si impadronisce di qualche riga del racconto: George si avvicina ai quartieri dove vivono altri emarginati (messicani e neri). Qui le case diventano colorate e allegre, tinte di quella retorica dell’apparenza che tranquillizza gli altri cittadini e i visitatori della città. Se George vivesse lì, nemmeno i figli di questi messicani o dei neri sarebbero suoi nemici: "loro (se lo accettassero) sarebbero suoi alleati e lui, per l’occasione, sarebbe Zio George" (p.33).

Basta poi una manciata di pagine, per vedere riaffiorare la violenza e l’odio, per quanto sempre relegati a pensieri fantastici e mai tramutati in gesti concreti. D'altronde, potendo scegliere tra un temperino rosso e uno blu offerti da uno studente, opta per il secondo, il colore dello spirito, della pace e della tranquillità, non il rosso, simbolo della lussuria e dell'ira, del potere e della violenza, del pericolo (p.65).
Una scelta che agli occhi del suo studente Kenny porta stupore: forse le maschere, sui disattenti, funzionano. Rapidamente infila una nuova maschera e riprende coscienza mentre guida: si avvicina alla sua meta (p. 28-32).
Per una sentenza sull’odio dobbiamo attendere che George arrivi in aula a parlare del libro di Huxley che i suoi studenti non hanno letto. Durante la lezione, George prova a scagionare lo scrittore inglese dalle accuse di antisemitismo: “nessuno odia mai senza ragione” (p. 55).
Quindi anche il suo odio ha una ragion d’essere? Qual è? Si tratta, per caso, del fatto che lui non può vivere il suo dolore come vorrebbe perché sa che non è considerato al pari di altri? Perché non è conforme ai costumi della maggioranza machista ed eteronormata?
Forse George crede proprio questo. Riconoscendosi come una minoranza, impartisce una lezione proprio sul riscatto dei marginati. Questo riscatto non ha solo bisogno di un riconoscimento: alle parole deve corrispondere un vero scatto, ma è lui stesso a impedirselo. Per sua stessa ammissione, se avesse fatto un confronto tra due studenti etnicamente diversi, avrebbe potuto far scattare il regno dei cieli proprio in quell’aula, “ma no” (p.56).
Ed è per questo che può limitarsi solo a una sentenza e questa arriva veloce, quasi incomprensibile a tutti:
“Ogni minoranza a suo modo è aggressiva. Provoca la maggioranza ad attaccarla. La odia - a ragion veduta, d’accordo. Ma odia anche le altre minoranze, perché le minoranze, tra loro, sono competitive; ciascuna afferma che le sue sofferenze sono le peggiori, e i torti che subisce i più infami. E più odiano, più vengono perseguitate, più si incattiviscono. [...] Quando vi perseguitano, odiate ciò che vi sta capitando, odiate chi lo fa capitare; vivete in un mondo di odio” (p. 57).
Parole scoccate come una frusta su tutti i presenti, a maggior ragione su chi rappresenta davvero la minoranza. Ed è lì che l’occhio del lettore si ferma, come quello di George - su Estelle, Wally o Myron - diventando lui stesso uno di loro.
5. Conclusione
“Ho sempre immaginato che in realtà si chiedesse come sarebbero andate le cose tra di noi se ci fossimo lasciati in quel periodo”
Con questa dichiarazione durante un’intervista del 1984, Don Bachardy apre uno squarcio sul contesto biografico che ha fatto da supporto all’opera. Negli anni della stesura di A Single Man, la relazione tra lo scrittore e il giovane artista stava attraversando acque turbolente. Per la sua crescita artistica, Don Bachardy si trasferì a Londra, seguito da Isherwood.
Nonostante il successo artistico, Bachardy sentiva di non riuscire a essere indipendente dal compagno sia nelle amicizie sia artisticamente. Per rivaleggiare con le relazioni passate di Isherwood, ebbe a sua volta delle storie che misero in crisi lo scrittore.
Nel 1963, tra gelosie e difficoltà, Isherwood volle quasi metter fine alla relazione, lasciando la loro casa di Santa Monica e riversando le sue inquietudini nei diari personali, pronte a diventare tangibili, poi, nel romanzo A Single Man.
A Isherwood va il plauso di aver permesso a un uomo omosessuale di essere preso come uomo qualunque con cui far empatizzare il lettore medio statunitense in un momento storico che, solo qualche anno più tardi, sarebbe stato sconvolto dai moti di Stonewall.
A Single Man vuole difendere a tutti i costi i diritti umani di un uomo che sceglie di essere solo, vuole che il lettore lo capisca e lo faccia a sua volta. Sentendo vivamente l’assenza di Jim, non possiamo che concordare con le parole dei protagonisti che puntellano il romanzo di una verità universale: Jim non sostituiva nessun figlio, fratellino, moglie per George, nessuno avrebbe potuto sostituire lui (p. 24) perché "una camera di motel americano non è una camera qualsiasi in un albergo qualsiasi, è la camera, punto. Ce n'è una sola." (p. 72)
6. Bibliografia
Isherwood, Christopher, A Single Man, 1964.
7. Sitografia
“A Single Man”, by Christopher Isherwood, apageinthesun.com (ultima consultazione: 31-07-2021).
“A Single Man”, by Christopher Isherwood, indipendent.co.uk (ultima consultazione: 31-07-2021).
“A Single Man”: on the writer Christopher Isherwood, telegraph.co.uk (ultima consultazione: 31-07-2021).
Christopher Isherwood: A Single Man, theasylum.wordpress.com (ultima consultazione: 31-07-2021).
The 100 best novels: “A Single Man” by Christopher Isherwood (1964), theguardians.com (ultima consultazione:31-07-2021).
8. Fonti immagini
A Single Man, giuntialpunto.it (ultima consultazione 28/08/2021).
A Single Man, il film col professore più elegante del cinema, esquire.com (ultima consultazione 28/08/2021).
A Single Man: l’alta moda mette in scena eleganza e rimpianti, themacguffin.it (ultima consultazione 28/08/2021).