Letteratura per l’infanzia a colori: sette consigli di lettura per introdurre i bambini al diverso
Elena Scaggiante
La letteratura per l’infanzia ha il potere di veicolare messaggi importanti attraverso un linguaggio accattivante e accessibile ai più piccoli. Nel corso dei decenni, diversi autori hanno sfruttato questo potente mezzo per introdurre le nuove generazioni di lettori –e di futuri adulti– all’accettazione dell’altro. L’omogenitorialità e l’identità di genere sono ancora considerati temi problematici da introdurre nelle scuole. Di conseguenza, diversi insegnanti e genitori sono reticenti nel presentare ai bambini libri al riguardo. Alcuni di questi testi, creati da scrittori e illustratori nordamericani, dimostrano come, con semplicità e delicatezza, si possano presentare le storie di personaggi queer per quello che sono: uguali a tutti gli altri.
1. Leo Lionni
2. Libri per famiglie a colori
3. Libri per bambini a colori
4. Fonti
1. Leo Lionni
Leo Lionni (1910–99), nato e celebrato negli Stati Uniti per la creazione di decine di albi illustrati per l’infanzia, ha prestato spesso la sua penna per la scrittura di favole. Da artista autodidatta, Lionni inizia a lavorare nel mondo della pubblicità per la Ford Motor Company a Philadelphia. Prosegue la carriera e diviene direttore artistico prima per il magazine Fortune nel 1947 e, in seguito, per il magazine Print. Dopo il successo ottenuto in patria, l’ormai 50enne Lionni si sposta in Italia, dove aveva già vissuto da più giovane, dividendo da lì in poi il suo tempo fra i due paesi. Muore nella sua casa vicino a Radda, in Italia, l’11 ottobre 1999. Lionni realizza il suo primo libro per bambini un po’ per caso. Mentre si trovava a bordo di un treno diretto a New York con i suoi nipotini Pippo e Annie, inscenò una storia su due cerchi colorati ricavati dalle pagine di un numero della rivista Life. Questa storia sarebbe poi stata pubblicata nel 1959, diventando il suo libro più celebre: Piccolo blu e piccolo giallo.
Il racconto si incentra su due palline colorate: piccolo blu e piccolo giallo. I due sono amici e giocano sempre insieme. Un giorno si abbracciano così forte che diventano un’unica pallina verde. La cosa sembra divertirli molto ma, purtroppo, quando tornano dai rispettivi genitori questi non li riconoscono più come loro figli ora che sono cambiati. Il dispiacere di piccolo blu e piccolo giallo è così grande che i due si disintegrano in lacrime e si ricompongono nei loro colori originali. Così, tornano dai rispettivi genitori che finalmente capiscono cosa era successo e che dietro a quella pallina verde c’erano i loro figli di sempre. Alla fine tutti festeggiano e anche i genitori di blu e giallo si divertono ad abbracciarsi e a diventare verdi. Questa storia ci insegna che, nonostante le esperienze di vita e il conoscere altre persone possano renderci diversi, specialmente agli occhi dei nostri genitori, nel profondo rimaniamo le persone che hanno sempre conosciuto e amato. Anzi, le differenze che portiamo alla loro attenzione possono arricchire anche coloro che ci vogliono bene.
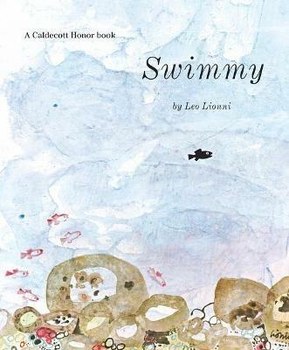
Fra gli altri suoi lavori più celebri figurano Guizzino (1963) e Pezzettino (1975). Il primo è stato addirittura elogiato dal celebre autore Eric Carle come uno dei “libri illustrati senza cui potrei vivere”, sia per la morale che porta sia per le illustrazioni da lui definite cinematografiche (Swimmy, 1963:1). Guizzino racconta la storia di un omonimo pesciolino, l’unico completamente nero tra un banco di piccoli pesci rossi. Un giorno un tonno arriva e attacca il gruppo. Guizzino è l’unico che riesce a sfuggirgli e si ritrova a vagare solo per il mare. Lì, incontra animali di ogni colore e forma. Tra questi, un altro gruppo di piccoli pesci rossi, proprio come il suo banco di origine. Questi rimangono nascosti perché spaventati da un grande pesce che minaccia di mangiarli. Per aiutarli, Guizzino escogita un piano: nuoteranno tutti assieme come se fossero il più grande pesce rosso del mare e Guizzino, rappresenterà l’occhio nero. Così facendo, i pesci riescono a spaventare il grande pesce e a nuotare liberi. Come Carle ci suggerisce nella prefazione, il tonno e il grande pesce rappresentano i bulli che minacciano i più piccoli. Guizzino riesce a dimostrare non solo che l’unione fa la forza ma, forte della sua diversità, riesce a supportare gli sforzi dei pesci rossi e sconfiggere il nemico più grande.
Il libro Pezzettino, invece, accende i riflettori sulla tematica dell’accettazione di sé, attraverso l’avventura di un piccolo cubetto che dà il nome alla storia. Pezzettino è circondato da creature formate da tanti piccoli cubetti, mentre lui è composto da un solo pezzo. Si convince quindi di essere un pezzo di una creatura più grande e inizia la sua ricerca. Quelli che incontra gli dicono che sono già completi: come farebbero a essere ciò che sono se non lo fossero? A questo punto Pezzettino segue il consiglio di una creatura saggia e va sull’isola di Bum. Lì, inizia a vagare, finché rotola giù da una montagna e si rompe, scoprendo di essere lui stesso formato da tanti piccoli pezzi. Felicissimo, Pezzettino torna a casa e annuncia a tutte le creature di aver finalmente scoperto chi è: “Io sono me stesso!”
Le storie di Leo Lionni, con la loro genuina semplicità, ci mostrano l’importanza dell’accettazione di sé e degli altri: non importa quanto diversi possiamo sembrare.
2. Libri per famiglie a colori
Non sono mancati (e non mancano tutt’ora) le pubblicazioni per la letteratura dell’infanzia che presentano tematiche LGBT+ con estrema naturalezza. Tra questi albi illustrati ce ne sono alcuni che presentano le tanto osteggiate famiglie omogenitoriali. Il primo, E con Tango siamo in tre, è un libro del 2005, scritto da Peter Parnell e Justin Richardson, con i disegni di Henry Cole. Basato su una storia vera, questo narra la storia di due pinguini maschi dello zoo di Central Park, Roy e Silo. I due si innamorano e decidono di avere un cucciolo insieme. Non riuscendo, però, a produrre un uovo come le coppie di pinguini etero, vengono assistiti dal loro custode umano, il Signor Gramzay, che decide di affidare loro un uovo orfano.
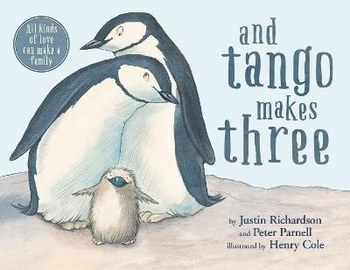
Roy e Silo covano l’uovo con grande cura, finché un bel giorno ne esce una graziosa cucciola che decidono di chiamare Tango, proprio come il ballo argentino che, in principio, era ballato da coppie di uomini. La storia si conclude con Roy, Silo e Tango che diventano una famiglia amata da tutto lo zoo, proprio come come le altre, a dimostrazione che “Ogni tipo di amore può creare una famiglia” come recita la frase che troviamo in copertina.
Il libro delle famiglie di Todd Parr ci presenta vari tipi di famiglie: alcune sono dello stesso colore; altre di colori diversi; alcune hanno un genitore invece di due; altre hanno due mamme o due papà. Ma, ci racconta il narratore, tutte le famiglie si abbracciano e tutte soffrono la perdita di un caro. Il libro si conclude con il seguente messaggio: “There are lots of different ways to be a family. Your family is special no matter what kind it is” (“Ci sono molti modi diversi di essere una famiglia. La tua famiglia è speciale non importa di che tipo sia”, ndt.).
Questi due libri sono solo due esempi tra tanti testi che potremmo leggere, in grado dimostrare come le famiglie omogenitoriali non siano poi così inassimilabili a quelle di stampo più tradizionale, come molti vogliono far credere perché anche alla base della loro unione c’è lo stesso amore che anima le altre famiglie, con o senza figli.
3. Libri per bambini a colori
Tutti conoscono Il brutto anatroccolo (1835) di Hans Christian Andersen, ma non tutti conoscono Il bell'anatroccolo (2002), albo scritto dall’attivista per i diritti LGBT+ Fierstein Harvey e illustrato dal premiato Henry Cole. Ispirandosi ad Andersen, i due autori narrano la storia di un anatroccolo, Elmer.
Come nella fiaba originale, Elmer è discriminato dai suoi simili ma, in questo caso, non per il suo aspetto. Elmer ama cucinare e dipingere, mentre gli altri anatroccoli maschi trascorrono il tempo a giocare a box o a baseball. Il padre di Elmer cerca di convincere il figlio che non troverà mai il suo posto nel mondo se non impara a giocare con gli altri anatroccoli maschi e cerca di insegnargli a battere a baseball. Elmer, però, non è proprio portato per lo sport - e nemmeno gli interessa. Una sera, Elmer sente i suoi genitori discutere: suo padre urla lamentandosi che tutti chiamano suo figlio “sissy” (“femminuccia”, ndt.) e di essere diventato lui stesso lo zimbello dello stormo. Sentendo le parole del padre, Elmer chiede a sua madre il significato di quella parola e sua madre gli spiega che è un modo crudele per definire chi non si comporta come gli altri si attendono che faccia perché la diversità li spaventa. La madre gli spiega che lui non è come tutti gli altri e che lui è speciale. Ma le parole della madre non bastano a tranquillizzarlo. Elmer non vuole essere speciale; viene bullizzato a scuola dai suoi compagni; suo padre, invece di difenderlo, vedendo la sua diversità come una debolezza, finisce per ripudiarlo come figlio. A quel punto Elmer non vede altra soluzione se non fuggire di casa e trovare riparo nella foresta.
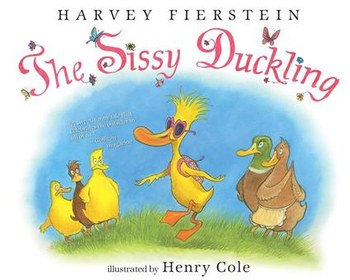
Qui Elmer trova rifugio in un albero cavo e, grazie alle sue abilità, riesce a creare una casa perfetta. Un giorno, mentre si trova al lago non lontano dalla sua nuova casa, nascosto alla vista delle altre anatre, Elmer sente gli spari dei cacciatori e tutti gli uccelli fuggono via. Dopo il trambusto generale, Elmer sente tra i fili d’erba un mormorio sommesso e scopre che si tratta di suo padre, che è rimasto ferito. Vedendolo, il padre gli ordina di abbandonarlo e fuggire, come fanno di consueto le anatre. Ma Elmer decide di fare ciò che ritiene giusto e non quello che è convenzionale. Così, porta suo padre a casa sua per prendersene cura. Nonostante le proteste, suo padre desiste perché ormai è arrivato l’inverno e non può tornare indietro. Si vede costretto a rimanere con Elmer, da soli, per tutta la stagione. Durante la permanenza a casa del figlio, il padre impara ad apprezzarne le qualità, che gli hanno permesso non solo di salvarlo, ma di far superare l’inverno a entrambi.
Tornata la primavera, le altre anatre tornano e scoprono che Elmer e suo padre sono sopravvissuti grazie al piccolo anatroccolo. Riconosciuto il coraggio e l’ingegno di Elmer, tutto lo stormo lo acclama e lo accoglie di nuovo con loro. Elmer torna dal gruppo, con un’importante lezione appresa: essere fiero di sè.
L’accettazione di sé è al centro anche del libro per l’infazia Beniamino (2008), scritto da Lynne Rickards e illustrato da Margaret Chamberlain. La storia narra di un giovane pinguino di nome Patrick, che un mattino si risveglia completamente rosa. Nessuno riesce a capirne la causa né a trovare una cura. La cosa irrita molto Patrick: “But I’m a BOY! [...] And BOYS CAN’T BE PINK!” (“Ma io sono un ragazzo! [...] E i ragazzi non possono essere rosa!”, ndt.). Suo padre prende subito in mano la situazione, dimostrandogli che anche i maschi possono essere rosa e gli mostra le immagini dei fenicotteri.
Tuttavia, a scuola Patrick viene deriso dagli altri pinguini per la sua condizione. Non vive bene il suo essere diverso e decide quindi di partire per l’Africa alla ricerca dei fenicotteri. Lì, Patrick li incontra, ma è comunque diverso da loro: non può pescare allungando il collo e non può migrare in volo al tramonto. Patrick decide quindi di tornare a casa. Scopre di essere mancato a suoi genitori e ai suoi compagni di scuola e capisce che i pinguini appartengono al Polo Sud, anche se rosa.
Personaggi come Guizzino, Tango e Beniamino ci mostrano come le persone e le famiglie diverse da noi in apparenza, racchiudono in sé lo stesso amore e gli stessi valori a cui tutti ambiamo: gentilezza e fratellanza. Questi libri dimostrano che la diversità è un tema che non solo è possibile presentare ai bambini, ma più che necessario.
4. Fonti
Harvey, Fierstein e Henry Cole. The Sissy Duckling, 2002.
“Leo Lionni”, Encyclopaedia Britannica, kids.britannica.com (data ultima consultazione 5/3/2025).
“Libri salvati – edizione 2022”, Associazione Italiana Biblioteche, 2022, aib.it (data ultima consultazione 4/3/2025).
Lionni, Leo. Little blue and little yellow, 1959.
Lionni, Leo. Pezzettino, 1975.
Lionni, Leo. Swimmy, 1963.
Parnell, Peter and Justin Richardson. And Tango makes three, 2005.
Parr, Todd. The Family Book, 2003.
Rickards, Lynne e Margaret Chamberlain. Pink!, 2008.
Foto
Foto 1 da lafeltrinelli.it (data ultima consultazione 10/3/2025).
Foto 2 da lafeltrinelli.it (data ultima consultazione 10/3/2025).
Foto 3 da lafeltrinelli.it (data ultima consultazione 10/3/2025).