L’incubo americano secondo Stephen King: l’horror come specchio della società
Alberto Luppino
Da oltre cinquant’anni, Stephen King, il Re dell’horror, non si limita a spaventarci: ci accusa. Le sue storie sono uno specchio impietoso dell’America, un paese diviso, ferito e ossessionato dai propri incubi. I suoi mostri non emergono solo dalle fogne, ma si annidano nelle case, nei traumi familiari, nella nostra stessa memoria.
Le sue opere parlano del mondo che ci circonda, perché King è molto più di un autore di brividi: è un narratore politico e provocatorio. Attraverso le sue pagine dà voce a donne fragili ma indistruttibili, a ragazzini segnati dalla colpa e a intere comunità sull’orlo dell’autodistruzione. Le sue storie ci costringono a guardare dritto nell’abisso e a riconoscerci in esso.
I suoi romanzi hanno dato vita a film e serie TV che hanno lasciato un segno indelebile nella cultura pop: dalla scena della doccia di sangue in Carrie o quella dell’ascia in Shining, con il volto allucinato di Jack Nicholson che sfonda la porta.
1. Vivere ai margini: quando la realtà supera l’incubo
2. Il male come sistema: l’America che si guarda allo specchio
3. Distopie americane: trauma, controllo e ribellione
4. Perché leggere Stephen King è ancora necessario
5. Fonti
1. Vivere ai margini: quando la realtà supera l’incubo
Stephen King non ha dovuto inventare tutti i suoi incubi: molti li ha vissuti sulla sua pelle. Prima delle oltre 400 milioni di copie vendute e delle innumerevoli trasposizioni cinematografiche, la sua vita è stata un lungo viaggio attraverso paure fin troppo reali, esperienze che hanno lasciato il segno nella carne, nella mente e nella scrittura.
La sua infanzia fu segnata da un abbandono precoce: il padre lasciò la famiglia quando Stephen aveva appena due anni. La madre si ritrovò a crescere due figli da sola e con pochissimi mezzi, costretta a spostarsi di continuo in cerca di lavori malpagati. Il piccolo Stephen King crebbe tra traslochi, precarietà e silenzi. Anni dopo, descriverà i suoi ricordi come “alberi isolati in un paesaggio nebbioso, pronti a ghermirti e divorarti” (King, 2000: 3).

Nemmeno l’età adulta fu più clemente. Anche dopo il matrimonio con Tabitha – pilastro della sua vita – la stabilità economica restava un miraggio. King lavorava in una lavanderia, insegnava in un liceo e scriveva di notte in un angolo del loro umile alloggio, mentre con la moglie cercava di mantenere due figli piccoli (il terzo sarebbe nato qualche anno più tardi). Quando iniziò a scrivere Carrie (1974), lo abbandonò presto. A credere nel manoscritto fu proprio Tabitha, che recuperò le prime pagine dalla spazzatura e lo spinse a non mollare. King la ascoltò e completò il romanzo che avrebbe cambiato tutto.
Poi vennero i demoni interiori. Già negli anni Settanta, l’alcol aveva fatto irruzione nella sua vita, ma fu negli Ottanta, proprio mentre il successo cresceva, che il buio si fece più fitto: alcol, cocaina, farmaci, notti di cui ancora oggi conserva solo frammenti. Ammise persino di non ricordare la stesura di Cujo (1981) (King, 2000: 90). Per anni, l’uomo che raccontava gli incubi altrui lottò con i propri. Solo nel 1987, grazie all’intervento di Tabitha, affrontò la disintossicazione e intraprese la strada della sobrietà. Nel 1999, un altro trauma: una monovolume lo investì durante una passeggiata, e sopravvisse per miracolo. Anche quella ferita, come le altre, sarebbe diventata materiale per i suoi scritti.
È in tutto questo vissuto che risiede la forza della sua narrativa. King riesce come pochi a dare voce agli outsider, ai marginali, agli esclusi. Da Carrie White a Mike Hanlon, da Dolores Claiborne a John Coffey, i suoi personaggi sono segnati dal dolore, spesso stigmatizzati, ma portatori di un’umanità potente, fatta di rabbia, dignità e resilienza.
L’orrore nei romanzi di King non è fatto solo di mostri o case infestate: è la realtà che si deforma, la lotta quotidiana per sopravvivere in un mondo che non fa sconti. Proprio per questo riesce ancora a parlarci, a farci paura e, al tempo stesso, a farci sentire compresi. Dallo sfondo di un’America disordinata e fragile, piena di promesse infrante e minacce invisibili, nasce lo sguardo di Stephen King. Uno sguardo che non si limita a intrattenere, ma accusa, perché l’orrore, nei suoi romanzi, è spesso un atto politico, un grido travestito da incubo.
2. Il male come sistema: l’America che si guarda allo specchio
Per anni, la critica ha bollato Stephen King come un semplice intrattenitore, un autore commerciale privo di profondità. Tuttavia, dietro mostri e fantasmi si nasconde qualcosa di ben più inquietante.
Nei suoi romanzi, il male non è solo una presenza esterna o soprannaturale: è un riflesso deformato, ma riconoscibile, della società statunitense. Nasce dentro le comunità, cresce nei silenzi, si alimenta di paura e indifferenza. È una comunità che si corrompe, un sistema che opprime, una società che divora i suoi membri più deboli. In molte delle opere di King, è l’America stessa a diventare l’incubo.

Nel romanzo It (1986), il mostro con il volto da clown non è l’unico orrore. La vera minaccia è Derry, la città che dimentica, nasconde, volta lo sguardo altrove. È la complicità collettiva, l’omertà, la passività di fronte al male. Gli adulti ignorano abusi, razzismi, segnali d’allarme, e i bambini, una volta cresciuti, rimuovono ogni ricordo, come se la città li costringesse a dimenticare. Ma il trauma non sparisce: ritorna ciclicamente ogni 27 anni. È un ciclo che riflette il movimento stesso del romanzo, sospeso tra memoria e rimozione del dolore. It racconta un dolore intergenerazionale alimentato dal silenzio e dalla negazione. Pennywise è il volto del male, ma Derry è la sua casa, il sistema che lo protegge e lo nutre.
In The Dome (2009), King mette in scena una comunità allo sbando. Qui il male assume i tratti del potere autoritario, della religione tossica, del patriarcato violento. Il vero orrore non è la cupola che isola la cittadina, ma la comunità che, isolata, mostra il suo vero volto. Le strutture sociali si disgregano, la paura legittima la tirannia, la violenza diventa linguaggio quotidiano. Non a caso, King ha dichiarato di essersi ispirato alla politica americana post-11 settembre. Infatti, ritrae Big Jim Rennie come una figura che richiama certi abusi di potere più che il semplice fanatismo: rappresenta una leadership corrotta, protetta dall’incompetenza di chi avrebbe dovuto fare da argine.
Per King, l’America non è il sogno, ma una trappola. Soffoca l’individuo, lo isola, lo spezza. Le istituzioni, invece di proteggere, rinchiudono. E le piccole comunità – spesso dipinte come baluardi di valori – diventano incubatrici di conformismo, ipocrisia e sospetto (Magistrale, 2010). In questo senso, i racconti di King non possono essere relegati a semplice letteratura fantastica: sono veri e propri atti d’accusa contro l’America profonda, quella che si proclama virtuosa mentre, in silenzio, coltiva il risentimento.

In The Mist (1980) troviamo un altro esempio della critica sociale di King. Nel romanzo breve, un gruppo di cittadini si rifugia in un supermercato mentre fuori una fitta nebbia nasconde creature sconosciute. Ma il pericolo più grande non è all’esterno: nasce dalla paura stessa, che trasforma l’ordine in caos. Alcuni si rifugiano in una fede fanatica, come dimostra l’ascesa di Mrs. Carmody, che mobilita la folla verso una giustizia biblica e spietata, eco sinistra dei processi di Salem e del fondamentalismo religioso. Altri giustificano la violenza preventiva, convinti che eliminare i deboli o i dissidenti sia l’unico modo per sopravvivere. La microcomunità implode travolta da un’ondata di irrazionalità collettiva. The Mist si configura così come una parabola sulla fragilità della democrazia e sulla rapidità con cui una società civile può degenerare sotto la pressione del panico. Il vero orrore non sono i mostri. Il vero orrore siamo noi, quando smettiamo di riconoscerci come umani.
Con queste narrazioni, King ci mostra un’America che ha paura di se stessa, che costruisce il proprio incubo giorno dopo giorno. L’horror diventa critica sociale: la cittadina perfetta del Maine si rivela una gabbia, la chiesa un tribunale, la scuola un campo di battaglia. E dietro ogni creatura, ogni maledizione, ogni “cattivo”, si cela un sistema che ha fallito.
3. Distopie americane: trauma, controllo e ribellione
Nei romanzi più distopici di Stephen King emerge una visione inquietante di un’America che implode sotto il peso delle proprie contraddizioni. Non è più soltanto una cittadina del Maine a nascondere il marcio: qui è l’intero sistema a crollare. Oggi queste contraddizioni appaiono stranamente familiari.
In La lunga marcia (1979), pubblicato sotto lo pseudonimo di Richard Bachman, la distopia si gioca sul controllo del corpo e della volontà. Un gruppo di adolescenti è costretto a camminare fino allo sfinimento e solo uno sopravvivrà. La marcia è uno spettacolo, una carneficina in diretta nazionale. La violenza non è più nascosta, ma un rito normalizzato, consumato da un pubblico che asseconda il rito con inquietante complicità. Il potere esercita la propria forza attraverso la sorveglianza continua e il culto di una resistenza passiva, disumana, priva di senso. È difficile non leggere in questa dinamica una critica alla spettacolarizzazione del dolore, alla retorica della resilienza imposta e alla logica del sacrificio patriottico. L’assenza di un vero perché alla base della marcia, l’adesione cieca dei partecipanti e il trauma del sopravvissuto evocano l’assurdità della guerra e l’alienazione prodotta da un’autorità che manipola consenso e obbedienza.
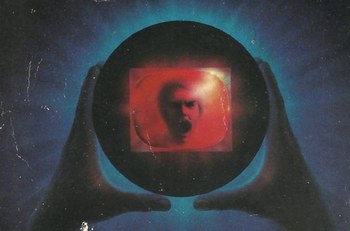
L’uomo in fuga (1982), sempre firmato Bachman, sposta il focus sui media. Qui la TV diventa uno strumento di sadismo istituzionalizzato che trasmette la caccia all’uomo per l’intrattenimento della massa. Nel frattempo, la disoccupazione è strumentalizzata per garantire il controllo sociale. Lo Stato si trasforma in azienda, la polizia nel braccio armato del profitto. Una distopia che oggi riecheggia in un’epoca di reality show estremi, precarietà sistemica e algoritmi che monitorano ogni nostro gesto.
Lo pseudonimo “Bachman” non è solo un travestimento: è un esperimento. King voleva capire se fosse il nome o il contenuto a decretare il successo. Ma è anche un’operazione critica, un modo per scrivere storie troppo cupe, politiche, scomode per il marchio King. I quattro romanzi che formano la raccolta The Bachman Books sono più asciutti, crudi e spietati. In molti casi anticipano un immaginario distopico che oggi conosciamo bene, da Black Mirror a Hunger Games, fino alle narrazioni sul tardo capitalismo.
Nel romanzo La zona morta (1979), il trauma si fa personale: Johnny Smith si risveglia dal coma con il dono – o la maledizione – di poter prevedere il futuro. Quel futuro è nefasto: un populista carismatico, Greg Stillson, è destinato a scatenare l’apocalisse. Johnny si trova di fronte a una scelta tragica, solitaria, ma inevitabile, che suona come un ammonimento attualissimo, in un’epoca segnata dall’ascesa di nuovi leader divisivi e populisti.

In L’ombra dello scorpione (1978), una pandemia decima la popolazione. I sopravvissuti si dividono in due poli: un regime teocratico e violento da una parte, un tentativo di rinascita democratica dall’altra. Anche in questo scenario post-apocalittico, King semina dubbi profondi: il nuovo mondo rischia di ripetere gli stessi errori. La lotta fra le due fazioni non rappresenta soltanto il classico scontro tra bene e male, ma un’allegoria della fragilità delle istituzioni, costantemente minacciate da autoritarismo, fanatismo e sete di potere. Il trauma collettivo non basta a cambiare le cose. Anche quando il mondo è ridotto in macerie, la tentazione del dominio e della violenza riaffiora, a dimostrazione della ciclicità del male nella storia. Una riflessione dal retrogusto amaro.
In tutte queste opere, King racconta un’America che si ferisce da sola. Il trauma non è un evento isolato, ma un ciclo senza fine. Il potere non è solo oppressione: è sistema. La ribellione è possibile, ma fragile, solitaria e spesso destinata al fallimento. Eppure resta l’unica risposta umana al collasso morale di un’intera civiltà. Una risposta che oggi, forse più che mai, è urgente e imprescindibile.
4. Perché leggere Stephen King è ancora necessario
Stephen King è popolare perché parla a tutti, ma non lusinga nessuno. I suoi mostri sono specchi che riflettono il fallimento del sogno americano. È un autore dell’orrore, ma di un orrore reale, collettivo, quotidiano, politico.

Negli ultimi anni ha assunto posizioni pubbliche molto nette. Ha criticato apertamente Donald Trump, per poi abbandonare Twitter/X a causa di un’atmosfera tossica. Nel saggio Guns (2013) ha sostenuto il bando delle armi d’assalto, devolvendo i ricavi alla Brady Campaign. Insieme alla moglie Tabitha, ha donato 3 milioni di dollari alla Biblioteca Pubblica di Bangor, nel Maine. Da sempre è impegnato su temi civili come i diritti delle donne, l’ambiente, la sicurezza pubblica e la libertà d’espressione.
Perché leggerlo oggi è necessario? Perché King è un intellettuale che racconta il dolore, il trauma e la speranza. I suoi testi e le sue interviste confermano la capacità di analizzare la società ben oltre il puro intrattenimento. The Economist sostiene che il successo dei suoi romanzi deriva proprio dalla loro attualità, dalla forza con cui riflettono le paure e le contraddizioni del presente.
Eppure, tra sangue e terrore, King conserva una fiducia incrollabile nell'umanità. Nonostante tutto, esiste sempre un fondo di bontà e coraggio capace di resistere al male. Rileggerlo oggi significa riconoscere che il vero terrore non è nei mostri, ma nella realtà che scegliamo di non vedere e che affrontarla è l’unico modo per non soccombere.
5. Fonti
D’Elia, Jenifer Michelle, “Standing Up With The King: A Critical Look At Stephen King’s Epic”, USF, 2007, su Digital Commons University of South Florida (data di ultima consultazione: 07/08/2025).
King, Stephen. It, Sperling & Kupfer, 2019.
— L'ombra dello scorpione, Bompiani, 2021.
— L’uomo in fuga, Sperling & Kupfer, 2013.
— La lunga marcia, Sperling & Kupfer, 2014.
— La zona morta, Sperling & Kupfer, 2013.
— On Writing. Autobiografia di un mestiere, Sperling & Kupfer, 2017.
— The Dome, Sperling & Kupfer, 2013.
— The Mist, Sperling & Kupfer, 2018.
Magistrale, Tony. Stephen King: America’s Storyteller, ABC-Clio, 2010.
Mercer, Erin. Stephen King and the Uncanny Imaginary, Routledge, 2024.
“An American Gothic Nightmare: Stephen King’s The Mist”, su Sheffield Gothic (data di ultima consultazione: 18/07/2025).
“It and Intergenerational Trauma”, su Rewriting The Rules (data di ultima consultazione: 13/07/2025).
“Rereading Stephen King: week seven – The Long Walk”, su The Guardian (data di ultima consultazione: 17/07/2025).
“Stephen King and his wife pledge $3m to Maine library”, su The Guardian (data di ultima consultazione: 18/07/2025).
“Stephen King and Tabitha King: All About Their Decades-Long Romance”, su People (data di ultima consultazione: 13/07/2025).
“Stephen King leaves X, describing atmosphere as ‘too toxic’”, su The Guardian (data di ultima consultazione: 18/07/2025).
“Stephen King has spent half a century scaring us, but his legacy is so much more than horror”, su Vox (data di ultima consultazione: 21/07/2025).
“Stephen King on why he has no recollection of writing 'Cujo'”, su Far Out (data di ultima consultazione: 13/07/2025).
Stephen King | The Author, su Stephen King (data di ultima consultazione: 21/07/2025).
“The Great Stephen King Reread: It”, su Reactor (data di ultima consultazione: 17/07/2025).
“The King Chroniclers and the Reimagining of an Icon of American Letters”, su The Ringer (data di ultima consultazione: 13/07/2025).
“Under the Dome | Stephen King on His 10 Longest Novels”, su TIME (data di ultima consultazione: 17/07/2025).
“Why Stephen King’s novels still resonate”, su The Economist (data di ultima consultazione: 20/07/2025).
Foto 1 da People (data di ultima consultazione: 07/08/2025)
Foto 3 da RetroZap (data di ultima consultazione: 07/08/2025)
Foto 4 da ScreenGeek (data di ultima consultazione: 07/08/2025)
Foto 5 da LifeJournal (data di ultima consultazione: 07/08/2025)
Foto in copertina da The Walk of Fame (data di ultima consultazione: 07/08/2025)