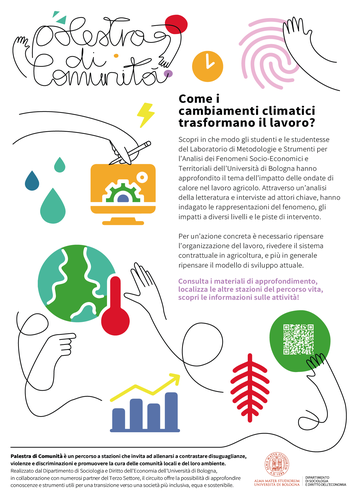I cambiamenti climatici stanno influenzando molti degli estremi meteorologici e climatici, tra cui ondate di calore, siccità, cicloni tropicali e precipitazioni intense e si rafforzano le prove che tali variazioni degli estremi siano di origine antropica (IPCC, AR6, 2023). Le narrazioni sui cambiamenti climatici li rappresentano spesso come a fenomeni di livello macro che impatteranno le generazioni future, invece gli effetti sono sempre più evidenti e di breve periodo. Oltre agli effetti visibili nei nostri territori e nelle nostre città, con fiumi in piena, inondazioni e smottamenti i cambiamenti climatici toccano direttamente le nostre vite anche nel lavoro di molte cittadine e cittadini.
Analizzando la letteratura su questo specifico fenomeno emerge comegran parte degli studi sulle ondate di calore, ad oggi, si concentrino e su come le vivono in generale le popolazioni, ad esempio gli anziani (Condemi et al., 2015). In particolare, molta attenzione è rivolta all’ambito urbano e quindi alle isole di calore urbano e alle ricadute sulla salute pubblica. Questo fenomeno si sviluppa nelle città europee dalla prima metà degli anni 2000 e recentemente non ha fatto che acuirsi (Bagliani et al., 2022).
Secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), senza una diminuzione dell’emissione di gas-serra l’aumento delle temperature porterà ad una modifica ulteriore delle condizioni metereologiche.ISPRA riporta i danni che questi fenomeni procurano alla salute e in particolare alle popolazioni più “fragili”, così identificate in base a età, genere, condizioni di salute e disagio sociale. Inoltre, lo stesso istituto riporta come già un decennio fa due terzi dei comuni italiani abbiano conosciuto eventi naturali estremi e come in particolare, sempre due terzi della popolazione italiana affermava di aver riscontrato ondate di calore all’interno del proprio territorio (ISPRA, 2014).
Ondate di calore: un problema anche definitorio
La definizione del fenomeno non è univoca, né dal punto di vista epidemiologico (l’OMS non ne fornisce una specifica); né dal punto di vista normativo. Il Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica Ambientale per lo sviluppo sostenibile (LaMMA) riporta due approcci per definire le ondate di calore, uno epidemiologico e un altro climatologico (LaMMA, 2012).
L’Organizzazione Mondiale della Sanità parla in questo modo del fenomeno “Le ondate di calore, ovvero il caldo e l'afa che possono durare diversi giorni, possono avere un impatto significativo sulla società, compreso un aumento dei decessi legati al caldo. Le ondate di calore sono tra i rischi naturali più pericolosi, ma raramente ricevono un'attenzione adeguata perché il loro numero di morti e la loro distruzione non sono sempre immediatamente evidenti" (OMS, nd, trad. nostra).
Secondo la WMO (World Metorological Organization) “Un'ondata di calore può essere definita come un periodo in cui si accumula un eccesso di calore locale in una sequenza di giorni e notti insolitamente caldi” (WMO, nd).
Per quanto riguarda l’Italia e come le istituzioni definiscono ed affrontano il fenomeno, l’ultimo intervento risale al Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, che definisce le “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento” e in cui è rilevabile il tono emergenziale ed eccezionale del fenomeno che secondo le nostre ipotesi di ricerca definisce quasi sempre le azioni e gli interventi in materia e da parte dei diversi attori coinvolti. Il decreto infatti continua nella descrizione delle azioni: «Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attivita' lavorativa [...]».
Se da una parte, come abbiamo osservato definire il fenomeno è tutt’altro che semplice ed immediato, ci sono metodologie e tecniche che cercano di sistematizzare il tutto ad esempio tramite la creazione e l’analisi di indici che possano raccogliere la complessità dei fenomeni e monitorarli. Ad esempio, l’Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI) del “CCL/CLIVAR Working Group on Climate Change Detection” ha definito un insieme di 27 indici idonei a descrivere gli estremi di temperatura e precipitazione in termini di frequenza, intensità e durata (Peterson et al.; 2001, Toreti e Desiato, 2008 in ISPRA, 2013). In particolare, sul territorio italiano sono stati individuati 13 indici di temperatura e 6 indici di precipitazione, specifici per il nostro clima. In studi anche successivi sempre ISPRA riporta tra gli indici che più spesso vengono utilizzati per identificare le ondate di calore: Humidex, Discomfort Index, temperatura massima apparente, giorni tropicali (T max>30°C) e notti tropicali (T min>20°C) (ISPRA, 2014).
Contestualizzazione del rapporto tra ondate di calore e mondo del lavoro
“Recentemente adottata dall’ILO, la Strategia globale sulla salute e la sicurezza sul lavoro per il periodo 2024–2030 sottolinea che le preoccupazioni in materia di SSL legate ai cambiamenti climatici dovrebbero essere in cima all’agenda sulle politiche internazionali e nazionali, con la creazione di partenariati strategici a livello nazionale e internazionale.” [pg.4, Report ILO 2024]
In letteratura il rapporto tra ondate di calore e mondo del lavoro è definito su due fronti: i rischi per la salute dei lavoratori (infortuni e malattie) e l’aumento dei costi per le aziende dovuti da un lato dalle spese che aziende e istituzioni specifiche devono sostenere a causa dei frequenti infortuni, e dall’altro dalla perdita di produttività che tiene conto dell’aumento degli infortuni, ma anche delle implicazioni sullo stato psico-fisico dei lavoratori.
Nella loro analisi della letteratura sul tema, Varghese et.al. (2018) citano uno studio di Osborn et.al. (1922) che fu il primo a mettere in relazione l’esposizione al caldo con l’occorrenza di infortuni: i ricercatori osservarono che gli infortuni in fabbrica aumentavano quando le temperature erano superiori o minori ai 19-20°C. Da quel momento numerosi passi avanti sono stati fatti per capire quale relazione ci fosse tra ondate di calore e aumento degli infortuni sul lavoro. Varghese et.al. (2018) con un’esaustiva rassegna della letteratura riportano di studi condotti in Australia (Xiang et.al. 2014, McInnes et al., 2017), Canada (Adam-Poupart et al., 2015), India (Nag and Nag,2001), oltre che in Italia (Morabito et al., 2006). Tutte queste ricerche sottolineano una correlazione positiva tra l’aumentare della temperatura massima (Tmax) e l’aumentare degli infortuni, seppur in forme diverse e senza considerare le differenze tra settori professionali. Sheng et.al. (2018) in uno studio riguardante i lavoratori in diversi settori lavorativi nella città di Guangzhou, Cina hanno provato come l’aumento di un °C delle temperature massime (Tmax) è associato a un aumento dell’1.4% degli infortuni. La popolazione più soggetta a rischi è quella composta da uomini e lavoratori di mezza età che lavorano in piccole medie-imprese. Mentre all’aumentare di un °C delle temperature minime (Tmin) è associato a un aumento dell’1.7% degli infortuni e la popolazione più soggetta a rischi è quella composta da donne e da lavoratori di mezza età che lavorano in grandi aziende o nel settore dei trasporti o nell’edilizia.
Focalizzandoci brevemente sulla ricerca di Morabito et.al (2006) in Toscana, una delle poche svolte sul contesto italiano, è emerso come i giorni con una temperatura media tra 24.8-27.5°C siano i più a rischio di incidenti sul lavoro. Rispetto ad altre ricerche sul tema, Morabito et.al (2006) hanno rilevato come gli infortuni sul lavoro abbiano più probabilità di accadere in giornate calde rispetto a giornatedi caldo estremo, poiché in quelle situazioni sono state messe in atte più velocemente pratiche e accorgimenti per tutelare i lavoratori.
I profili dei lavoratori non sono ugualmente esposti ai rischi. La popolazione più vulnerabile sembra essere quella dei lavoratori maschi giovani, tra i 15-24 anni, che svolgono lavori sia all’aperto che al chiuso (Xiang et al., 2014; Adam-Poupart et al., 2015; McInnes et al., 2017; Spector et al., 2016 in Varghese et.al 2018); i settori più a rischio sono edilizia, elettricisti, logistica, agricoltura, pesca (Xiang et al., 2014; Adam-Poupart et al., 2015). Gli infortuni più frequenti dovuti al caldo sono ferite profonde, bruciature, cadute, tagli, fratture (Tawatsupa et al., 2013; Xiang et al., 2014). Altri dati sono disponibili nel report ILO del 2024. Secondo l’ILO (2024) circa “2,41 miliardi di lavoratori sono esposti ogni anno al caldo eccessivo sul lavoro” (pg.6). I principali impatti sulla salute sono: stress da calore, colpo di calore, fatica dovuta al calore, rabdomiolisi, sincope da calore, crampi da calore, eruzioni cutanee da calore, malattie cardiovascolari, danno renale acuto, malattia renale cronica, lesioni fisiche. Mentre per gli impatti sulla salute legato al lavoro l’ILO (2024) stima che a causa del caldo eccessivo “ogni anno si registrano 22,85 milioni di infortuni sul lavoro, 18.970 decessi legati al lavoro e 2,09 milioni di anni di vita corretti per la disabilità (DALY)” (pg.6).
Per quanto riguarda la prevenzione invece, tra le pratiche per prevenire gli effetti delle ondate di caloreVarghese et.al. (2018) riportano: aumentare la ventilazione, avere un abbigliamento tecnico, avere schermi/scudi protettivi dal caldo (Parsons, 2013; The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2012; Corleto et al., 2013; NIOSH, 2016). Insieme a queste, si propongono una serie di regole di buon senso come bere tanta acqua, fare intervalli di lavoro frequenti, ma anche ripensare l’organizzazione lavorativa e corsi di formazione per educare i lavoratori ai rischi dell’esposizione al caldo (Parsons, 2013; The American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), 2012; Corleto et al., 2013; NIOSH, 2016).
Il tema dell’aumento dei costi per aziende e istituzioni a causa degli effetti delle ondate di calore sui lavoratori sono l’altro tema su cui si è scritto molto in letteratura. Lo studio di Orlov et.al (2019) propone di misurare la perdita di produttività nel settore agricolo e nel settore edile in Europa, divisa per singolo lavoratore, differenziando tra valori medi e valori per singoli paesi. La perdita di produttività viene dunque intesa come una “perdita economica diretta” (Orlov et.al. 2019, p.199) per le aziende. Orlov et.al. (2019) sottolineano che la capacità dell’azienda di essere flessibile e di adattarsi alle eventuali situazioni climatiche estreme risulta fondamentale; come, ad esempio, la possibilità di lavorare la notte, o in orari meno caldi, per compensare la perdita di produttività che si avrebbe durante gli orari di lavoro consueti. I risultati sono stati prodotti su arco temporale piuttosto ampio: sono state prese in considerazione le ondate di calore in Europa del 2003, del 2010 e del 2015. I valori medi di perdita economica diretta per l’Europa nel settore agricolo sono stati misurati tra i 59-90$ per lavoratore, ma ci sono profonde differenze tra Paese: infatti, in Italia la perdita economica è stata misurata oltre i 1100$ per lavoratore (Orlov et.al, 2019).
Se la ricerca di Orlov et.al (2019) si concentra soprattutto sui costi delle aziende, l’analisi di Ma et.al (2019) mette in risalto anche il peso economico sulle istituzioni andando a quantificare le richieste di risarcimento danni e il pagamento da parte dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La ricerca di Ma et.al (2018) risulta interessante anche oltre ai risultati individuati; infatti, viene sottolineato come le persone con un basso livello di scolarizzazione sono più a rischio di soffrire da infortuni o malattie legate alle alte temperature, rispetto alle persone con medio alto livello di educazione, questo avviene perché chi ha un basso livello di educazione, più frequentemente svolge lavori manuali, all’aperto e magari anche in condizioni non sempre ottimali.
Altre ricerche che indagano il peso sulle istituzioni e sul sistema sanitario sono state fatte da Xiang et.al (2018) nel sud dell’Australia e da Martinez-Solanas et.al (2018) in Spagna. Nello studio di Ma et.al (2018) sono state rilevate richieste di risarcimento per danni attribuibili a esposizione da caldo superiori del 4.8% del valore medio in Spagna, ma simile ai dati delle regioni spagnole del sud, le quali hanno un clima più simile a quello di Guangzhou. La ricerca di Xiang et.al (2018) ha rilevato che l’aumento di 1°C oltre la Tmax di 33°C riporta un aumento del 41.6% dei costi sanitari e un aumento del 74.8% di giorni di non lavoro a causa di malattie da caldo legate all’occupazione.
Infine, è utile capire l’evoluzione e l’aumento dell’intensità del fenomeno come sottolinea l’Organizzazione Internazionale del Lavoro :
“L’aumento delle temperature su scala mondiale che è dovuto al cambiamento climatico si tradurrà in ondate di calore più frequenti e gravi, causando un aumento della mortalità, una riduzione della produttività e danni alle infrastrutture (Mora et al. 2017). L’impatto del caldo eccessivo varia da un settore all’altro, ma quelli più a rischio includono quelli nei quali il lavoro fisicamente impegnativo si svolge all’aperto e al chiuso in ambienti di lavoro scarsamente ventilati in cui la temperatura non è controllata. I rischi legati al calore sono influenzati dalle condizioni ambientali, dallo sforzo fisico, e dall’abbigliamento o dalle attrezzature.” [ ILO 2024, p.6]
“Il dialogo sociale tra governi e parti sociali è necessario anche per lo sviluppo di politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, poiché i lavoratori e i datori di lavoro sono nella posizione migliore per intraprendere iniziative nei luoghi di lavoro che siano adeguate.” [Report ILO 2024, p.10]
A partire da questi risultati, che hanno ricavato attraverso un attento e puntuale studio della letteratura scientifica esistente, gli studenti e le studentesse del Laboratorio di metodologie e strumenti per l’analisi dei fenomeni socio-economici e territoriali del corso di laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale hanno approfondito il tema dell’impatto delle ondate di calorie nel lavoro agricolo.
La domanda di ricerca principale è la seguente : quali sono le narrazioni che gli attori coinvolti danno delle ondate di calore sul lavoro agricolo e quali rapporti intercorrono tra loro? Inoltre, come vengono progettate, recepite e applicate le politiche per le ondate di calore, in questo specifico settore?
Metodologia: interviste in profondità ad attori chiave (INAIL, Work Klimat, Confederazione Italiana Agricoltori.