Gabriel García Márquez e Don DeLillo: punti d’incontro tra realismo magico e postmodernismo americano
Elena Scaggiante
Se leggiamo Cent’anni di solitudine (1967) di Gabriel García Márquez, capostipite del realismo magico, e proviamo ad accostarlo a Underworld (1997) di Don DeLillo, esponente del postmodernismo della letteratura statunitense, noteremo echi del primo nel secondo. Infatti, il realismo presentato dai due romanzi mostrano diversi punti in comune, in particolare nella rappresentazione del quotidiano e della contemporaneità.
1. La contemporaneità del non-contemporaneo
2. La straordinarietà del reale
3. Il tempo del presente
4. Fonti
1. La contemporaneità del non-contemporaneo
Nel saggio Opere mondo (1994), Franco Moretti definisce il romanzo di Gabriel García Márquez una “narrazione epica” e ne evidenzia due aspetti che lo portano a tale considerazione: la “contemporaneità del non-contemporaneo” e la “retorica dell’innocenza” (Moretti: 1994:225-228), che si possono rintracciare anche nell’opera di DeLillo.
Il concetto di “contemporaneità del non-contemporaneo” fa riferimento alla struttura narrativa del romanzo di García Márquez. Difatti, Moretti si appoggia all’analisi di Vargas Llosa per far notare come, nelle vicende della famiglia protagonista, i Buendía, passato, presente e futuro si fondono, attraverso uso di flashback e anticipazioni (Moretti, 1994:225-231). Non a caso, Vargas Llosa riporta diversi esempi a riprova di questa circolarità nella struttura, non solo a livello macroscopico, ma anche nei singoli eventi che animano la storia dei Buendía (Vargas Llosa, 1971).
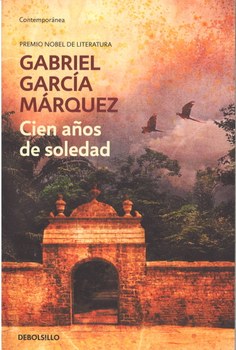
Ed è proprio la circolarità l’elemento su cui si sofferma un altro esperto, Stefano Ercolino, quando accosta l’opera di García Márquez ai romanzi del postmodernismo statunitense. Il romanzo di DeLillo, Underworld, comincia con un prologo ambientato nell’autunno 1951 e prosegue con una prima parte che si svolge nel 1992. Un intermezzo torna al 1951 per poi lasciare spazio a una seconda parte del romanzo a cavallo fra gli anni ‘80 e ‘90, e una terza nel 1978. Un secondo intermezzo ambientato di nuovo nel 1951 interrompe per poco la narrazione per poi cedere il passo a una quarta parte ambientata nel 1974 e una quinta che si svolge negli anni ‘50 e ‘60. Il terzo e ultimo intermezzo del 1951 prepara il terreno per una sesta parte ambientata tra il 1951 e il ‘52. Infine, un prologo chiude gli eventi ricongiungendo la narrazione agli eventi della prima parte ambientati nel 1992. Passare in rassegna il sommario dell’autore a incipit del romanzo pone l’attenzione sul fattore tempo: le vicende riguardanti il protagonista, raccontate nelle sei parti e nel prologo, partono dal presente (cioè dal 1992), scorrono a ritroso dagli anni ‘90 agli anni ‘50 e si concludono nell’epilogo, che ritorna al 1992 suggellando a tutti gli effetti una narrazione circolare. Tuttavia, questa circolarità è interrotta, non solo dal prologo e gli intermezzi, ma anche dai ricordi e le riflessioni che tormentano i personaggi. Come per i personaggi di García Márquez, questo espediente rende elementi del passato dell’autore una parte attiva del suo futuro, e viceversa.
2. La straordinarietà del reale
Nella sua analisi di Cent’anni di solitudine, Moretti evidenzia il concetto della “retorica dell’innocenza”, quella voglia di reincanto nella società contemporanea (Moretti, 1994:234). In un’epoca dominata dalla tecnica e dal materialismo, García Márquez riesce a riportare la “magia” nella realtà capitalista.
L’autore rappresenta il mondo latinoamericano contemporaneo mescolando fatti e finzioni, realtà e magia. Non è un caso che il romanzo sia considerato un capostipite del cosiddetto realismo magico, teorizzato per la prima volta da Arturo Uslar Pietri in due suoi saggi: Letras y hombres de Venezuela (1948) e Godos, insurgentes y visionarios (1986). In entrambi i testi, Uslar Pietri critica le rappresentazioni dell’America Latina prodotte da europei come Cristoforo Colombo ed Hernán Cortés, perché manipolavano la rappresentazione di quei territori a scopo politico ed economico. La stessa accusa fu scagliata da García Márquez nel suo discorso di accettazione del Premio Nobel. Tutto ciò, silenziando la violenza portata dal colonialismo in America Latina, tema che ritorna nel titolo del suo capolavoro. Di contro, Uslar Pietri eleva le produzioni originali di autori latinoamericani, tra cui Cent’anni di solitudine, che portano alla ribalta una rappresentazione autentica di quella realtà che definì, appunto, “realismo magico” (Uslar Pietri, 1948:287; 1986:139).
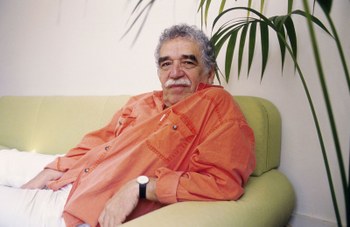
Nel riportare la loro esperienza diretta dell’America Latina, questi autori presentavano una realtà più fedele di quanto avessero mai fatto gli storici e i saggisti del passato (Uslar Pietri, 1986). Questa realtà teneva in sé aspetti in apparenza contraddittori e inconciliabili, e per questo risultava unica e diversa da qualsiasi cosa mai vista altrove, dunque magica. Per Uslar Pietri il realismo magico non è un realismo meno fedele alla realtà di quello ottocentesco. Difatti, questo presenta quella quotidianità fino ad allora ignorata e, perciò, straordinaria.
Un collegamento tra il romanzo epico di García Márquez e il realismo delle grandi narrazioni contemporanee ci viene offerto da Stefano Ercolino, il quale in Il romanzo massimalista descrive l’omonimo genere e menziona proprio Underworld come esempio. All’inizio del saggio ammette lui stesso l’esistenza di un legame tra la forma epica di Moretti e la forma massimalista (Ercolino, 2015:11-12). Ercolino identifica un decalogo di caratteristiche che permettono di definire un romanzo come massimalista: lunghezza, mondo enciclopedico, coralità dissonante, esuberanza diegetica, compiutezza, onniscienza narratoriale, immaginazione paranoica, intersemioticità, impegno etico e realismo ibrido. L’aspetto forse più interessante è il cosiddetto realismo ibrido, che si slega dal logocentrismo del realismo tradizionale e si lascia “ibridare” dalle “contaminazioni sistematiche dei media nella sfera estetica postmoderna” (Ercolino 249-252). In Underworld troviamo una storia non impossibile, ma di sicuro improbabile, che è però in grado di persuadere il lettore e risulta tutto sommato convincente.
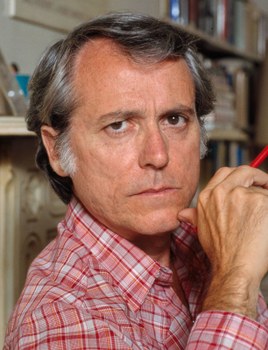
Ercolino non è il primo studioso a proporre una nuova definizione di realismo letterario. Nel suo saggio Realismo e letteratura (2007), Federico Bertoni mostra come il realismo, introdotto da Émile Zola, sia diventato ben altro nel corso del tempo. Basti pensare ai sogni e alle visioni, che possono essere considerati elementi realistici a tutti gli effetti: la realtà percepita dalla persona non finisce dove arriva la vista, ma prosegue nel mondo interiore dell’osservatore attraverso quello che è percepito dal cosiddetto “occhio interiore” (Bertoni, 2007:15-16). Per spiegarlo meglio, Bertoni porta proprio l’esempio di Underworld di DeLillo. Qui l’autore rappresenta la realtà degli anni della Guerra Fredda, non per come riportata dai giornali o dai libri di storia, ma attraverso l’esperienza diretta dello statunitense medio, a dimostrazione di come la tecnologia e i media trasformino la nostra percezione della storia (DeLillo, in DePietro, 2005:124; O’Donnell, in Duvall, 2008:108-116). In una realtà come quella degli Stati Uniti, pervasa dai media, per autori come DeLillo, il realismo consiste proprio nel mostrare quanto questi siano pervasivi e come influenzino le nostre esperienze di vita.
Secondo Bertoni, se DeLillo avesse limitato la sua scrittura a una riproduzione dei fatti non sarebbe riuscito a restituire questa pervasività dei media. Per riuscirci, DeLillo si è servito di una intermediazione. In Underworld, infatti, il realismo diventa sinonimo della capacità dell’autore di rivelare una controstoria, ossia storia sotterranea che rivela un lato della realtà che fino ad allora era rimasto nascosto (Bertoni, 2007:357-358; Ercolino, 2015:139; Cowart, in Duvall, 2008:154-155). È la stessa operazione svolta da García Márquez, che ha parlato della realtà latinoamericana senza farsi limitare dall’occhio fisico e dando spazio al suo occhio interiore e ai suoi ricordi d’infanzia.
3. Il tempo del presente
Sia Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez che Underworld di Don DeLillo parlano della contemporaneità dei rispettivi autori. Eppure entrambi sono ambientati nel passato: Cent'anni di solitudine, pubblicato negli anni ‘60, si sviluppa tra la seconda metà del XIX secolo e la prima metà del XX secolo, mentre Underworld, pubblicato negli anni ‘90, si sviluppa lungo i decenni della guerra fredda, dagli anni ‘50 fino agli anni ‘90.
Com’è possibile parlare del presente attraverso il passato? La risposta sembra darcela Linda Hutcheon, teorica della “historiographic metafiction”. Questo genere viene utilizzato dai postmodernisti per tematizzare il rapporto tra storia e realtà presente e per riflettere su come la nostra concezione della storia influenzi l’interpretazione che diamo del presente (Hutcheon, 1989:34). Questo genere, presentato come una variante del romanzo storico, crea mondi fittizi, mescolati a tracce di eventi storici realmente accaduti (Hutcheon, 1989:34). Sia García Márquez che DeLillo inseriscono nei loro romanzi fatti storici accurati: il primo riprende i racconti dei nonni materni e suoi ricordi d’infanzia (Vargas Llosa, 1971:11-29); il secondo riporta fatti tratti da articoli di giornale (DeLillo, in DePietro, 2005:121-122). Non a caso, Hutcheon lega questo genere non solo alla rappresentazione della società dei media, ma anche alla riscrittura della storia latinoamericana.
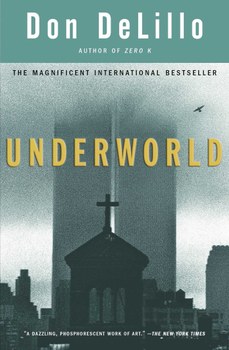
Con questa spiegazione, come si giustificano gli elementi storici fittizi per rappresentare la realtà? In Postmodernist Fiction (1987), Brian McHale prova a dare proprio una risposta a questo dubbio. L’autore associa l’urgenza di investigare la natura ontologica della realtà a un tratto peculiare della letteratura postmodernista. Per fare ciò, l’autore paragona il postmodernismo alla fantascienza, genere che ci invita a riflettere sulla nostra realtà tramite la rappresentazione di realtà altre (McHale, 1987:10-28). McHale lo ravvisa anche nel lavoro di García Márquez, che ha rappresentato il mondo latinoamericano come realtà altra rispetto all’Europa, attraverso il recupero di storie ignorate dai resoconti ufficiali. Questo sovverte il rapporto tra realtà e finzione: la storia ufficiale si rivela artificiosa, mentre la finzione narrativa si eleva ad autentica. L’effetto appare ancor più riuscito, grazie all’inserimento di elementi fantastici nell’ambientazione di Macondo, un paese immaginario, ma in grado di rappresentare l’America Latina in modo più autentico di quanto abbiano fatto fino ad allora i libri di storia europei (McHale, 1987:86-96). McHale giustifica tale operazione e parla del mondo oggettivo e di quello fittizio come inadeguati alla rappresentazione della realtà contemporanea, ma necessari in quanto sono gli unici in nostro possesso (McHale, 1987:100).
Allo stesso modo, Underworld, pur ambientato in una realistica New York in piena Guerra Fredda, comincia proprio dalla modifica di un evento storico. La vicenda inizia il 3 ottobre 1951 nel Polo Grounds, in cui si gioca una partita di baseball tra i New York Giants e i Brooklyn Dodgers. Nel nono inning, il famoso battitore Bobby Thomson effettua un incredibile fuoricampo che garantisce la partita e il campionato ai Giants. Nella realtà, non si sa che fine abbia fatto la pallina colpita da Thomson, ma nel romanzo un ragazzino riesce a impadronirsene. Il padre gliela sottrae e la vende, e il lettore segue per tutto il romanzo le vicende di una pallina che, in sé, racchiude le vicende di tutti gli Stati Uniti. Come nel romanzo di García Márquez, in Underworld troviamo la creazione di un mondo assimilabile al nostro, eppure fantastico, creato apposta per mettere in luce aspetti della nostra realtà che rimangono silenziati dalla storia ufficiale e dagli articoli di giornale.
Il testo di McHale giustifica l’esclusione del realismo ottocentesco come modello stilistico applicabile alla rappresentazione della realtà capitalista e chiarifica in modo ulteriore come mai possiamo associare entrambi i realismi di García Márquez e DeLillo al concetto di mimetismo letterario, accostando così due romanzi all’apparenza distanti.
4. Fonti
Bertoni, Federico. Realismo e letteratura: Una storia possibile, 2007.
DePietro, Thomas, ed. Conversations with Don DeLillo, 2005.
DeLillo, Don. Underworld, 1997.
Duvall, John N., ed. The Cambridge Companion to Don DeLillo, 2008.
Ercolino, Stefano. Il romanzo massimalista, 2015.
García Márquez, Gabriel. Cien años de soledad, 1967.
García Márquez, Gabriel. “La Soledad de América Latina.” The Nobel Prize, 8 dic 1982, da nobelprize.org, (data ultima consultazione 13/3/2024).
Hutcheon, Linda. The Politics of Postmodernism, 1989.
McHale, Brian. Postmodernist Fiction, 1987.
Moretti, Franco. Opere mondo: Saggio sulla forma epica dal Faust a Cent’anni di solitudine, 1994.
Uslar Pietri, Arturo. Godos, insurgentes y visionarios, 1986.
Uslar Pietri, Arturo. Letras y hombres de Venezuela, 1948.
Vargas Llosa, Mario. García Márquez: Historia de un deicidio, 1971.
Foto
Foto 1 da sobrelibros.net (data ultima consultazione 10/1/2025).
Foto 2 da britannica.com (data ultima consultazione 5/1/2025).
Foto 3 da britannica.com (data ultima consultazione 6/1/2025).
Foto 4 da deadendfollies.com (data ultima consultazione 10/1/2025).