"The Go Between" e "Atonement": due coming of age novels a confronto
Ginevra Bianchini
Il forte legame intertestuale che connette The Go-Between (Hartley, 1953) e Atonement (McEwan, 2001) porta a fare un confronto più da vicino tra le storie e i personaggi principali e non, soffermandosi in particolare sui due protagonisti, rispettivamente Leo Colston e Briony Tallis, e alla loro evoluzione attraverso la storia. Questi due romanzi sono delle coming of age novels perché raccontano, in modo meno letterariamente convenzionale, per esempio, rispetto ad un’opera di Charles Dickens come David Copperfield od Oliver Twist, il passaggio dall’infanzia all’età adulta dei rispettivi protagonisti.
1. Introduzione ai protagonisti: Briony e Leo
2. La figura della donna durante epoche in evoluzione
3. La figura del bambino e l’evoluzione dei suoi rapporti con il mondo esterno
4. Memorie di guerra
5. Il significato dell’espiazione
6. Bibliografia
7. Sitografia
8. Filmografia
1. Introduzione ai protagonisti: Briony e Leo
Essendo Briony ispirata alla figura di Leo, i due hanno anche similarità caratteriali: in particolare sono entrambi dei maniaci del controllo, caratteristica che piano piano crescendo sono costretti a smussare -Briony la esercita attraverso la scrittura creativa e Leo con la magia e le maledizioni che crede di lanciare. Hanno, inoltre, un gran bisogno di essere al centro dell’attenzione e protagonisti degli eventi. Pur essendo ancora dei bambini, già entrambi sono vittima di un acuto nervosismo: non sono persone tranquille, ma anzi piuttosto irrequiete, probabilmente perché influenzati dall’atmosfera che regna tra gli adulti e nella società che li circonda. Nonostante questi elementi in comune, le esperienze, il modo di viverle e di sopravvivere a esse dei due personaggi saranno diverse tra di loro. Già il fatto che Briony e Leo siano di sesso opposto è un dato importante, assieme poi alla loro storia familiare e soprattutto ai diversi periodi storici in cui hanno vissuto.
2. La figura della donna durante epoche in evoluzione
Tra i due romanzi si vede decisamente la diversità di percezione sia della figura della donna che dei rapporti tra i due sessi, in ambito matrimoniale e non. Dove termina la vicenda di The Go-Between inizia in un certo senso quella di Atonement, non in senso cronologico ma tematico e concettuale.
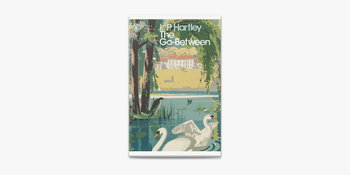
La storia di Leo finisce con la speranza per un matrimonio dettato dall’amore e quella di Briony inizia con una dichiarazione d’amore tra Cecilia e Robbie, lei di una famiglia benestante e lui figlio della governante della loro magione. Atonement inizia nel 1935 e The Go-Between termina a metà degli anni ’50, ad una ventina di anni di distanza, quando i rapporti tra uomo e donna, e la posizione della donna nella società, stanno andando incontro a notevoli cambiamenti. Nonostante abbiano delle forti similarità caratteriali, i ruoli di Leo e Briony nelle vicende sono quasi opposti: entrambi portano sì al dramma finale, ma in modo diverso, perché Briony avrà un’influenza prettamente attiva in tutto il romanzo, mentre Leo è più una pedina in mano a degli adulti. Briony, infatti, ha un carattere decisamente più impositivo e resistente rispetto a Leo, che, appunto, rimarrà traumatizzato dagli eventi della sua storia. Invece la protagonista di Atonement, pur rimanendo marchiata da ciò che ha causato, non è propriamente traumatizzata come Leo: per lei rimane più un senso di colpa interminabile, che però non ferma la sua crescita, ma la accelera, al contrario. Leo rimane bloccato, congelato al momento in cui assiste al dramma, come in una foto.
McEwan crea, prima in Briony, ma anche in Cecilia, delle figure femminili molto forti, che per certi versi possono ricordare Marian in Hartley. Tuttavia, Marian rimane ancora molto legata ai dettami che regolano la società della sua epoca; per quanto sia innamorata di Ted, ritornerà nei “ranghi” della sua classe e non avrà il coraggio di sfidare le convenzioni sociali e abbattere quello stereotipo e ruolo di donna che le era stato assegnato (Meyers, 2010: 123). Briony e Cecilia sono invece un nuovo tipo di donna, una donna che decide per sé al di là delle sue condizioni sociali; ciò può giustificare anche l’annullamento di Briony nel ruolo di infermiera col nome di Tallis. Questi due personaggi femminili sono infatti figlie dei movimenti delle suffragette inglesi dei primi del ‘900 e dell’epoca in cui McEwan stesso scrive, anni ’90 e primissimi anni 2000, in cui la figura della donna nella società è stata abbondantemente cambiata nell’immaginario comune inglese. Dal 1928 era stato infatti esteso il suffragio universale a tutte le donne del Regno Unito e i movimenti femministi avevano dato prima una forte spinta all’evoluzione della figura femminile nell’immaginario culturale inglese. Questo processo, però, è stato ed è tuttora molto lungo e lento e nel romanzo s’inserisce in un momento di transizione, collegato al periodo in cui sono ambientati gli eventi di Atonement. Dunque, in McEwan è presente l’opposto della situazione dell’epilogo di Hartley, in cui l’undicesimo Visconte Trimingham deve scegliere tra un matrimonio d’amore o uno di convenienza.
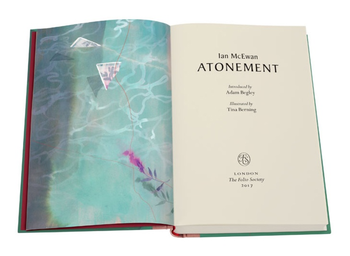
In Atonement è Cecilia che ha il potere decisionale: lei e Robbie sono eguali, la diversa provenienza sociale non ha importanza e non influenza il loro rapporto. Per il periodo in cui scrive McEwan, gli anni ’90, infatti, la condizione sia dell’uomo che della donna era decisamente cambiata rispetto all’epoca di Hartley, il quale, anche se scrive solo una quarantina di anni prima, aveva vissuto già gran parte della sua vita in una Gran Bretagna ancora molto conservatrice e maschilista, completamente diversa da quella di McEwan. L’autore di Atonement possiede invece tutto il patrimonio culturale e rivoluzionario inglese dagli anni ’60 in poi, avendo di conseguenza una visione molto più aperta rispetto al suo predecessore. Tuttavia, anche in Atonement c’è ancora uno strascico di quella condizione di sottomissione della donna, che prende forma nella vicenda di Lola e Paul Marshall. Ciò è presente probabilmente per dimostrare quanto una mentalità sia difficilmente estirpabile da una cultura, quando vi è presente da secoli: Lola, ancora una ragazzina, viene infatti violentata dall’uomo per diventarne poi moglie. Non è certamente un caso di matrimonio combinato, ma la giovane, oltre che essere traumatizzata dall’evento, è circuita dall’assalitore fino a sposarlo, quasi fosse vittima della Sindrome di Stoccolma.
“Poor vain and vulnerable Lola with the pearl-studded choker and the rose-water scent, who longed to throw off the last restraints of childhood, who saved herself from humiliation by falling in love, or persuading herself she had, and who could not believe her luck when Briony insisted on doing the talking and blaming. And what luck that was for Lola – barely more than a child, prised open and taken- to marry her rapist.” (McEwan, 2001: 324)
Non ci viene raccontato da Briony quello che è effettivamente successo tra i due dopo quei primi eventi, però quando parla del loro matrimonio, a cui lei stessa assiste, c’è una costante nota di sospetto da parte sua sui motivi che li hanno portati a sposarsi.
“The sunlight made it harder for Briony to see, but for a fraction of a moment, a tiny frown of displeasure may have registered in the bride’s face. Then she pursed her lips and looked to the front, and then she was gone.” (ibid.: 327)
Concentrandosi più sul caso di Hartley, la maggior parte del suo romanzo è ambientata nel 1900, momento in cui ancora le donne erano sottomesse alle figure genitoriali e maschili, motivo per cui venivano promesse in matrimonio già in giovane età a uomini della loro stessa classe sociale. Non esisteva la possibilità di relazioni guidate dai sentimenti, quasi nessuno -soprattutto nelle classi sociali più elevate- si sposava per amore. Infatti, Marian viene promessa in sposa a Lord Trimingham, uomo per cui chiaramente non prova nulla, al contrario di lui, il quale deciderà comunque di sposarla e adottare il figlio di lei e Ted, perché “nothing is ever a lady’s fault”, come fa notare Jeffrey Meyers:
“Trimingham, who repeatedly affirms his credo that “nothing is ever a lady’s fault”, covers up her scandalous behaviour. […] He accepts Marian’s child by Ted as his own son, marries her, and passes on his title to his heir.” (Meyers, 2010: 123)
Anche questo non incolpare le donne di nulla rientra nella mentalità prettamente maschilista dell’epoca: non è mai alcuna colpa delle donne fondamentalmente perché le donne non hanno potere decisionale o capacità di decidere per la propria vita. In questo caso, però, il carattere forte è senza dubbio Marian, la quale è molto brava all’interno di tutta la storia a dirigere gli uomini attorno a lei a fare quello che più desidera, in primis Leo. La donna ha infatti un forte ascendente sul protagonista, anche durante il loro incontro in tarda età. Leo è rimasto estremamente segnato dagli avvenimenti e non è mai andato oltre. Tuttavia, al termine della vicenda l’influenza che Marian ha su Leo può non portare una valenza negativa: lei chiede al protagonista di essere suo messaggero per l’ultima volta con il nipote, Lord Trimingham undicesimo. Infatti il giovane si trova di fronte ad un bivio, sempre in ambito matrimoniale, ma è bloccato dalle esperienze passate dei nonni:
“And they tell me – he has never told me – that he wants to marry a girl […] but he won’t ask her because…because this is still weighing on him.” (Hartley, 2000: 259)
L’intenzione di Marian è di spingerlo verso una scelta per amore e non per convenienza. Siamo negli anni ’50 e la situazione in questo ambito è in evoluzione, il matrimonio combinato ha perso terreno. Una svolta decisiva, come spesso in Gran Bretagna, era stata data negli anni Trenta da eventi che riguardavano la famiglia reale inglese, con il successore di Giorgio V, il primogenito Edoardo. Dopo la morte del padre, infatti egli annunciò che sarebbe salito al trono, nel 1936, affiancato da Wallis Simpson, un’americana di famiglia benestante, che però era ancora sposata a un altro uomo. Questa situazione chiaramente fece nascere uno scandalo e creò anche un forte conflitto d’interessi, per il fatto che Edoardo come sovrano del Regno Unito era anche capo della Chiesa anglicana, e dunque di fronte a Dio sarebbe apparso come un amante della donna, pur sposandola.
L’unica possibilità per Edoardo fu quindi di abdicare a favore del fratello minore Alberto, re Giorgio VI, mentre lui divenne duca di Windsor, e sposò il 3 giugno 1937 Wallis Simpson. Dopo questo evento cominciò a divenire socialmente riconosciuto il mito dell’amore e del matrimonio tra persona di sangue reale o nobiliare e dei commoners, che serpeggiava nella cultura inglese già da molto tempo (si veda una storia come quella raccontata in Lady Chatterley’s Lover). Va notato, però, che la parte attiva in questa decisione è spesso un uomo piuttosto che una donna: Lady Chatterley è più un’eccezione che la regola, e rimane comunque finzione. Nella vita reale a fare scelte di questo genere sono stati generalmente uomini, che, soprattutto, non hanno mai sposato vere e proprie commoners, ma persone comunque provenienti da classi sociali alto-borghesi e istruite. Un esempio più recente e contemporaneo potrebbe essere individuato nel matrimonio tra William Duca di Cambridge e Catherine Middleton. È chiaro che la figura della donna comincia a essere vista nei primi del ‘900 in modo diverso, non più solo come moglie e madre, ma anche come agente nelle scelte che riguardano la propria persona, e nelle relazioni interpersonali con uomini. Tuttavia, per avere una sua maggiore evoluzione si deve arrivare alla nostra contemporaneità con scrittori come proprio McEwan.
3. La figura del bambino e l’evoluzione dei suoi rapporti con il mondo esterno
Al centro di queste storie ci sono due bambini, le cui esperienze di brusco sviluppo verso la consapevolezza dell’età adulta vengono raccontate in retrospettiva da loro stessi anziani. Con la narrazione di Hartley ci si posiziona alla fine dell’epoca Vittoriana, precisamente un anno prima della morte della Regina Vittoria, che con il suo stile di vita e principi ha influenzato la società inglese in modo determinante, in particolare sul funzionamento e sulla struttura della famiglia delle alte classe sociali. Il carisma di questa regina l’ha resa un polo magnetico che ha dettato l’umore di un impero per tutto il suo lunghissimo regno.

In quest’epoca il bambino non veniva ancora riconosciuto come tale, ma come una sorta di adulto in miniatura, capace -spesso costretto- a fare esperienze non atte alla sua età, rimanendo però senza voce, rappresentazione e potere decisionale di alcun tipo. L’esistenza dell’infanzia in toto veniva negata, e gli effettivi bambini erano già degli adulti che dovevano “solo” crescere fisicamente, ma nel frattempo dovevano essere introdotti il prima possibile alla vita adulta e ai codici a essa legati. Un bambino come Leo, venendo coinvolto nella relazione tra Marian e Ted e anche avendo rapporti con gli altri adulti della famiglia Maudsley e non solo, rimane spesso perplesso e confuso di fronte alle situazioni con cui viene a contatto. La scena del capitolo 18 di The Go-Between, ambientata nella smoking room di Brandham Hall, è emblematica in questo senso: qui Leo viene a conoscenza dell’esistenza di questo tipo di stanze private esclusivamente per uomini, dove questi potevano agire “liberi” dalle convenzioni sociali e discorrere su qualsiasi argomento. È questo uno dei luoghi che lasciano Leo più turbato quando la visita per la prima volta, invitato da Trimingham. In questa circostanza a Leo vengono mostrati una serie di dipinti osé e dopo averli osservati attentamente, così commenta:
“This made me feel uncomfortable. I didn’t like the look of the picture or its feeling; pictures, I thought, should be of something pretty, should record a moment chosen for its beauty.” (Hartley, 2000: 188)
In questi spazi -da cui le donne sono completamente escluse- gli uomini vengono a contatto con questioni da adulti, ma soprattutto con la sessualità da un punto di vista prettamente concettuale. Il fatto che la discussione di tali argomenti sia relegata alla smoking room talk, li rende agli occhi della società pruriginosi e oggetto di tabù. Inoltre, le donne non parlano tra di loro di queste cose, solo gli uomini apparentemente hanno pulsioni sessuali e le donne ne sono mero oggetto: la figura della donna viene mostrata come inferiore e strumentale. Leo, attraverso tutto il romanzo, viene costantemente in contatto con questo mondo adulto, che ha pure un suo preciso linguaggio che lui non comprende:
“ ‘[…] He’s a bit of a lady-killer [Ted], but there’s no great harm in that.’ […] Lady-killer: what did that mean? I didn’t like to ask too many questions.” (Ibid.)
E questo succede ancora quando viene utilizzato il termine “spooning” per parlare dei rapporti sessuali -il cui significato è ancora sconosciuto a Leo, infatti il bambino chiede continuamente spiegazioni a riguardo, ma tutti si rifiutano di dargliele, dicendo che imparerà crescendo. Si nota che sia Leo sia Briony cercano ossessivamente l’attenzione, la considerazione degli adulti, senza successo. Sono dei bambini quasi abbandonati a se stessi, senza alcun tipo di guida che faciliti il doloroso passaggio dall’infanzia all’adolescenza.

Nella cultura dell’epoca, dato che si considerava che i bambini non fossero proprio bambini, ma già adulti in miniatura, non si poneva il problema di dargli un tipo di educazione che si aprisse in modo graduale a una diversificazione e profondità degli argomenti. Gli veniva proposto tutto da subito, senza alcun tipo di filtro o moderazione; erano esposti, vulnerabili e non avevano chi gli spiegasse che cosa significava cosa, ma erano costretti a imparare da soli e a vivere queste esperienze nella loro mente, nella loro intimità. Briony e Leo sono ignorati dalle rispettive famiglie in questi ambiti, le figure genitoriali sono quasi inesistenti. In particolare, il padre di Leo è deceduto e quello di Briony sempre via per lavoro, e dall’altro lato anche le madri sono assenti nei momenti di crescita dei figli -soprattutto Emily, la madre di Briony, ha una completa mancanza di controllo sugli eventi che coinvolgono la sua famiglia, sempre chiusa nella sua camera e aggredita da emicranie. Si percepisce un costante distacco e un’impossibilità da parte degli adulti, in particolare i genitori, di concepire l’esistenza della figura del bambino, che ha chiaramente una sensibilità diversa rispetto a loro. C’è una freddezza di fondo nella famiglia, una mancanza di contatto, un deserto affettivo. Le relazioni più strette per Briony sono quelle con i fratelli maggiori, mentre per Leo, figlio unico, con le figure di Marian e Ted. È normale, dunque, che in una società governata dal gelo affettivo il contatto fisico sessuale, non codificato dal matrimonio, porti allo scoppio del dramma.
Fino agli anni ’60 circa, la figura dell’adolescente non era riconosciuta nell’immaginario culturale. Nelle classi più agiate i genitori avevano, soprattutto quando i figli erano in tenera età, pochi rapporti con loro. I bambini venivano allevati dalle governanti, dai fratelli -se li avevano- o, come si può notare in questi due romanzi, erano spesso lasciati a se stessi. Non era consuetudine che i genitori fossero partecipi e attivi nella crescita del figlio, erano più delle figure esterne con cui i bambini venivano occasionalmente a contatto e da cui questi ultimi ricevevano poche attenzioni. I genitori agli occhi dei bambini erano più figure istituzionali che poli verso cui dirigere il proprio affetto.
“The Parents. Whatever institutionalised strength was locked in this plural was about to fly apart, or had already done so […]” (McEwan, 2001: 12)
Non è un caso infatti che sia Briony che Leo cerchino l’attenzione non dei loro genitori, ma dei fratelli o di altri giovani. I due protagonisti durante la loro infinita ricerca d’affetto e attenzione non comprendono quello che succede attorno, e, data la mancanza di strumenti conoscitivi, cadono in errore, finendo per causare una serie di tragedie. Questa assenza di figure genitoriali induce nei bambini dei Complessi di “Elettra” (Briony) e di “Edipo” (Leo), nei confronti delle persone con cui entrano più a contatto. Nei rapporti di Briony con la sorella Cecilia e Robbie, di Leo con Marian e Ted, traspare un misto di venerazione, amore, odio, attrazione, invidia. Ai loro occhi questi sono come il padre e la madre assenti, che vogliono emulare ma di cui vogliono anche distruggere il mito, per sostituirlo con la loro personalità adulta e sviluppata. Si assiste alla maturazione delle preferenze sessuali dei due protagonisti, anche se tra i due quello che si trova maggiormente in un momento di ambiguità e indecisione è Leo. Il bambino prova una forte attrazione anche nei confronti di Ted, molto viscerale e terrena, mentre quella per Marian è più idealizzata ed eterea, come se lei fosse una donna angelicata stilnovista. Leo prova un misto di paura e fascino quando vede per la prima volta Ted, in costume dopo un bagno. Poiché il personaggio è strutturato sull’autore stesso del romanzo, questa caratteristica è data probabilmente dal fatto che Hartley era omosessuale, ma non dichiarato, fino alla fine della sua vita. Affermò, solo dopo l’uscita del suo romanzo del 1971, The Harness Room, che quello era il suo “romanzo omosessuale”. Ali Smith definisce perfettamente The Go-Between come:
“A story of lost innocence, hypocrisy and Britishness – but LP Hartley's masterpiece can also be read as a sophisticated gay novel” (Smith, 2011)
Un romanzo molto complesso che racconta dell’esperienza di crescita dello stesso autore, però in modo molto sottile e difficile da individuare a un primo colpo d’occhio.
“It works a magic on obviousness, so that it becomes a novel about British embarrassment and embarrassing Britishness.” (Ibid.)
Il lato pruriginoso tipico della società inglese dell’epoca viene perfettamente a galla nel romanzo, prendendosi quasi gioco di uno dei problemi che distruggevano dall’interno l’istituzione della famiglia borghese. Inoltre, Maurizio Ascari fa notare come in particolare:
"McEwan suggests that the first physical attraction is that which links us to our family members -sisters, brothers, mothers and fathers- and the discovery of the other sex proceeds from this originary drive." (Ascari, 2011: 86)
Questa tensione sessuale tra membri della stessa famiglia si esplicita per Briony con sua sorella Cecilia, ma soprattutto con il fratello di sangue Leon e il fratello acquisito Robbie. Stessa cosa sembra valere per la sorella maggiore della protagonista, che prova attrazione per Robbie anche in età adulta, come se non fosse mai stato superato questo complesso infantile. Robbie, infatti, dopo la scomparsa del padre, era stato accolto e mantenuto dai Tallis, anche negli studi, come un figlio loro. Questa valenza incestuosa nelle relazioni familiari non vale solo per le giovani Tallis, ma anche per Paul Marshall, altro personaggio di Atonement, al centro di una scena in cui si sveglia da un sogno con forti valenze erotiche in cui
“[…] his young sisters had appeared, all four of them, standing around his bedside, prattling and touching and pulling at his clothes. He woke, hot across his chest and throat, uncomfortably aroused.” (McEwan, 2001: 60)
Marshall sembrerebbe poi incanalare questi suoi desideri erotici su Lola, fino all’usare violenza su di lei. Anche nel suo caso questi complessi non sono superati e anzi portano a generare comportamenti oltre il normale.
4. Memorie di guerra
Come già anticipato, in entrambi i casi ci troviamo in periodi sull’orlo di un conflitto: nel caso di The Go-Between, la guerra rimane più un’ombra, un fantasma, che getta una costante atmosfera di inquietudine sulla storia e che influenza in parte i personaggi; invece in Atonement la presenza della guerra è molto più viva e forte, soprattutto perché due sezioni del romanzo sono proprio ambientate durante la Seconda Guerra Mondiale.

Nelle due opere viene fatta una denuncia velata o evidente della guerra, che rimane un mostro sempre pronto a ingoiare e distruggere la società. Si percepisce un costante senso di minaccia, di isteria, generate da elementi esterni non visibili a colpo d’occhio, ma che sono invece il segnale d’allarme di una percezione generale della comunità verso qualcosa di imminente e terribile. Quasi una sorta di istinto, che si basa sulla propria contemporaneità, su un’atmosfera generale della società; però la maggior parte dei personaggi tenta di scacciarlo, ma questa impressione rimane sempre lì come un avvoltoio sopra una preda. In The Go-Between è presente l’eco della Seconda Guerra Boera, che richiama poi l’avvicinarsi della Prima Guerra Mondiale e la fine delle false aspettative di una Golden Age. Le guerre, al contrario di quanto accade in Atonement, non vengono raccontate direttamente, ma alla fine del romanzo, durante l’incontro tra Leo e Marian, viene ricordato quanto sia stato distrutto e andato perso negli anni immediatamente precedenti, sia a livello personale che societario:
“Hugh dying, Marcus and Denys killed, my son Hugh killed, and his wife […] But they weren’t our fault – they were the fault of this hideous century we live in, which has denatured humanity and planted death and hate where love and living were.” (Hartley, 2000: 260)
In diverso modo viene fatto, dunque, dai due autori un discorso sull’impatto della guerra, chiaramente attingendo dalla propria esperienza personale. Hartley, infatti, essendo nato nel 1895 e morto nel 1972, ha avuto la sfortuna di assistere e partecipare in prima persona ad entrambe le Guerre Mondiali e viverne anche l’aftermath. Inoltre, Hartley come tanti altri suoi contemporanei si arruolò nel 1916 e fu incaricato come ufficiale a Norfolk, senza però mai lasciare il suolo inglese, essendo impossibilitato per motivi di salute a ricoprire funzioni attive in campo straniero. Dopo la guerra fu anche congedato dall’esercito per invalidità. Dall’altro lato, McEwan non ha vissuto sulla propria pelle nessuna delle due guerre, appartenendo alla generazione immediatamente seguente. Però, come lui stesso ha dichiarato, ha fatto esperienza di quegli eventi attraverso i racconti del padre -in particolare riguardanti la disastrosa ritirata di Dunkerque:
“Many ex-servicemen have found it difficult or impossible to talk about their experiences of war. My father never had any such problems. He never tired of telling me […] "Stop me if I've told you this before," was a sentence my father never uttered. He needed to relive his experiences, especially in the last year of his life. Perhaps after a sedentary postwar office job in the army, he sensed that the Dunkirk episode and his slow recovery from it was the most intense period of his life, the time when he felt most truly alive.” (McEwan, 2006)
L’autore di Atonement si è rifatto in primis a questi ricordi dolorosi, ma anche fondamentali, del padre per costruire la base psicologica della seconda sezione, aggiungendo poi una precisa correttezza storica, dettata dal genere in cui si inserisce, l’historiographic metafiction. Ci sono quindi in questi romanzi due tipi diversi di memoria raccontati: la prima, di Hartley, è diretta, e la seconda, di McEwan, è per proxy, tramite il padre e altre fonti storiche. È interessante notare che per una persona come Hartley, che ha proprio vissuto quegli stessi eventi, sia impossibile raccontarli, e riesca solo ad alludervi in modo metaforico e simbolico. Invece McEwan, che ha sentito il loro racconto da chi c’è stato, riesce a mettere per iscritto e immaginare, partendo dalla realtà dei fatti, l’orrore, la distruzione e lo sconvolgimento di quegli anni.
“When I came to write Atonement, my father's stories, with automatic ease, dictated the structure […] It is an eerie, intrusive matter, inserting imaginary characters into actual historical events. A certain freedom is suddenly compromised; as one crosses and re-crosses the lines between fantasy and the historical record, one feels a weighty obligation to strict accuracy. In writing about wartime especially, it seems like a form of respect for the suffering of a generation wrenched from their ordinary lives to be conscripted into a nightmare.” (Ibid.)
L'autore cerca di identificarsi nel dramma ed è qui che si palesa la sua bravura. Narra quegli eventi come se vi avesse partecipato in prima persona, e ci riesce forse proprio perché non li ha vissuti. Nel suo background psicologico e culturale manca il trauma della guerra in prima persona, mentre in quello di Hartley è più che presente: l’orrore, la paura, il ricordo sono talmente vivi e palpabili da non poter esser raccontati, non esistono parole per descrivere quello che si è passato in quegli anni -se non una documentazione fredda e distaccata dei fatti, senza coinvolgimento emotivo. Sono pochi i narratori che sono riusciti a mettere per iscritto la propria diretta esperienza delle guerre che hanno sconvolto il mondo attraverso il ‘900. Per chi è venuto dopo e ne è quindi venuto a conoscenza, è più “facile” narrare di un trauma che non gli appartiene in prima persona, sempre, come dice McEwan, nel rispetto di chi quell’incubo l’ha attraversato. Questa mancanza di parole, l’impossibilità di raccontare, ricorda il grido finale di Kurtz,
“The horror! The horror!” (Conrad, 2012: 91)
che l’uomo emette poco prima di morire in Heart of Darkness, il capolavoro di Joseph Conrad: non si può spiegare quell’orrore, solo chiamarlo, invocarlo per immagini e ricordi.
5. Il significato dell’espiazione
Uno dei fulcri concettuali di entrambe le storie è, come dice lo stesso titolo di uno dei romanzi, l’espiazione. I due protagonisti vogliono cercare una soluzione alle colpe di cui si sono macchiati in giovane età, quando non erano ancora pienamente consapevoli delle tragiche ripercussioni che le loro azioni avrebbero avuto.

In un certo senso Briony e Leo possono essere considerati come in parte innocenti, perché hanno agito sotto l’impulso di sensazioni e sentimenti che non erano ancora in grado di comprendere e perché sono stati testimoni di situazioni -relazioni amorose nei loro casi- per cui non avevano alcun tipo di esperienza che gliele facesse capire. Il “grado” di innocenza però cambia tra i due, perché hanno agito in modi molto diversi, anche se con risvolti simili, alla fine. Leo in particolare viene sfruttato ed è vittima di Marian e Ted, che lo rendono il loro “Messaggero d’amore”(questo è infatti il titolo che è stato dato in italiano al film di Joseph Losey del 1971, tratto dal romanzo The Go-Between), circuendolo e facendolo divenire il terzo elemento di un triangolo amoroso che il bambino ancora non può capire. Il protagonista viene sconvolto sempre di più dagli avvenimenti a cui assiste, vivendo sulla sua pelle la storia d’amore dei due come loro tramite e finendo per provare sentimenti contrastanti per entrambi. Leo finirà per essere traumatizzato da questi eventi, in particolare dopo essere stato costretto da Mrs Maudsley, la madre di Marian, a confessare quello che sa sulla relazione tra i due amanti clandestini: questa sua rivelazione condurrà al dramma finale, cioè la scoperta in flagrante dei due amanti e il conseguente suicidio di Ted per il senso di colpa provato nei confronti sia di Marian per averla disonorata, sia di Leo, per aver sfruttato la sua innocenza di bambino. Probabilmente anche per questo suo grado di colpa “minore”, per Leo sarà più facile raggiungere una sorta di espiazione alla fine del romanzo, riprendendo il suo ruolo di go-between per Marian, però questa volta con il nipote della donna. In un certo senso, Marian continua a portare avanti l’inganno di quando Leo era bambino, attraverso il forte ascendente che ha su di lui, dicendo:
“You came out of the blue to make us happy. And we made you happy, didn’t we? […] You owe it to us, Leo, you owe it to us; and it’ll be good for you, too.” (Hartley, 2000: 260-261)
In questo caso le sue parole sembreranno spingere Leo a espiare le sue colpe attraverso questo ultimo atto nei confronti del nipote.
“Turning once more into a go-between, the protagonist has the chance to reunite what had previously been separated, both in the others and in himself, mending the thread that unites the present to the past, the adult to the child and that harks back to the world before the fall.” (Ascari, 2011: 93)
Briony invece appare come meno “passiva” rispetto a Leo, perché il suo ruolo nella vicenda di Atonement è decisamente molto più attivo, già per il fatto che è lei stessa la narratrice di tutta la storia. Le sue azioni inoltre non sono direzionate da nessuno, se non dalla sua fervida immaginazione letteraria, e il suo breve ruolo di messaggera per Robbie e Cecilia prende una certa piega seguendo sue decisioni e idee, senza influenze esterne. Anzi, sarà la stessa Briony a innestare idee, in Lola in particolare, convincendola che Robbie è un molestatore e che è stato lui a violentarla. Il processo di espiazione di Briony sarà molto più complesso di quello di Leo. Infatti la ragazza passerà attraverso numerose fasi, di cui le principali sono la scrittura stessa del romanzo e l’esperienza di infermiera a Londra durante la Seconda Guerra Mondiale. Per la seconda in particolare Briony sarà costretta alla prova per lei più dura, cioè privarsi del suo nome, della sua identità, per divenire parte del gruppo, della massa, un po’ come un soldato.

Nella chiusura dei due romanzi c’è una grande differenza, perché The Go-Between termina con un’atmosfera di apertura verso il futuro, una nota di positività, una possibilità per il protagonista di essere purificato dalle sue colpe. Non si saprà mai se Leo fa questo passo oppure no, ma almeno uno spiraglio di speranza c’è. Invece la fine di Atonement è completamente nera e priva di soluzione: Cecilia e Robbie sono morti senza essersi mai ricongiunti nella vita reale e Briony non avrà mai il loro perdono. Questa ombra di speranza nell’opera di Hartley potrebbe per certi versi sembrare paradossale visto che egli scrive nel decennio esattamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia c’è speranza e volontà di ricostruire una nazione prostrata dalla guerra, per quanto il cammino sia lungo e faticoso. La fine della vicenda di Leo diviene una metafora della ricostruzione e conseguente evoluzione dell’identità culturale inglese dopo che è stata messa così tanto a dura prova dagli anni precedenti.
Gli anni ’90, in cui vive McEwan, seguono il periodo in cui Margaret Thatcher è stata Primo Ministro, cioè dal 1979 al 1990, caratterizzato da una politica fortemente conservatrice, nazionalista e isolazionista, e rapporti non facili con il resto dell’Europa: l’impostazione antieuropeista della Thatcher ha fatto la storia e lasciato una netta divisione tra la Gran Bretagna e il continente. McEwan scrive in un’epoca che secondo lui ha completamente perso valori comunitari a cui rapportarsi, ma soprattutto ha perso qualsiasi possibile fede in Dio e nell’uomo. A conferma di questo suo pessimismo si è aggiunto, poco dopo la pubblicazione di Atonement nel 2001, l’attentato alle Torri Gemelle dell’11 Settembre dello stesso anno. McEwan in un’intervista del 2002, “Faith and doubt at Ground Zero”, commenta:
“I felt, more than ever, confirmed in my unbelief. What God, what loving God, could possibly allow this to happen?” (McEwan, 2002)
Nonostante questa negatività, comunque McEwan attraverso il racconto di Briony dà un finale più sereno alla sfortunata storia d’amore di Cecilia e Robbie. Non è chiaro se ciò dimostri che per lui nella narrativa forse c’è una possibilità di sopravvivenza e di felicità di personaggi altrimenti segnati da eventi tragici. Per Charles Pastoor la soluzione non può che essere una:
“[…] McEwan is thinking about and acting as the God that he, as an atheist, does not believe in. To offer a story in which the characters experience salvation would be to act as a God who offers the possibility of salvation to his creatures, and to do so would be to pattern himself after such God. But such self-patterning would be a fundamental denial of his own unbelief. McEwan, as God, must deny his characters any kind of salvation because, wherever they find it, it still comes from him, and he himself does not believe that a God who offers any kind of salvation exists.” (Pastoor, 2014: 212)
I suoi personaggi quindi non possono avere il perdono più per una coerenza letteraria tra l’autore e la sua mancanza di fede, che per una impossibilità assoluta di espiazione. Le interpretazioni possono essere infinite, ma chiaramente l’andamento storico del periodo in cui il romanzo è stato scritto ha avuto influenza sul finale senza speranza della storia. Queste colpe che i protagonisti reggono sulle loro spalle sono anche le colpe di una generazione intera, che non ha saputo “vedere” ed interpretare gli eventi che le accadevano attorno, perché ancora si trovava in un momento di transizione, metaforicamente dall’infanzia all’adolescenza. Non si è saputo prevedere a quale disastro si sarebbe giunti su scala mondiale con la Guerra, e di questo le generazioni di Hartley, in un modo, e di McEwan, in un altro, portano la colpa.
6. Bibliografia
Aristotele, Poetica, 2011.
Ascari Maurizio, Literature of the Global Age – A Critical Study of Transcultural Narratives, 2011.
Chatman Seymour, Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film, 1978.
Cicerone, Somnium Scipionis, 2010.
Conrad Joseph, Heart of Darkness, 2012.
Cremonini Giorgio & De Marinis Gualtiero, Joseph Losey, 1981.
Cretney, Stephen, Family Law in the Twentieth Century, 2003.
De Giusti Luciano (a cura di), Joseph Losey. Senza re, senza patria, 2010.
Finney Brian, "Briony’s Stand Against Oblivion, The Making of Fiction in Ian McEwan’s Atonement", in Journal of Modern Literature, n. 27, 2004.
Freud Sigmund, Il disagio della civiltà, 2010.
Hampton Christopher, Atonement – The Shooting Script, 2007.
Hartley L.P., The Go-Between, 2000.
Hutcheon Linda, A Theory of Adaptation, 2013
Ingersoll Earl G., "Intertextuality in L.P. Hartley’s The Go-Between and Ian McEwan’s Atonement", in Forum of Language Studies, 2004.
McEwan Ian, "interview", in John Haffenden, Novelists in Interview, 1985.
McEwan Ian, Atonement, 2001.
Meyers Jeffrey, "Theme and Variations: Lady Chatterley’s Lover and L.P. Hartley’s The Go-Between", in The Gettysburg Review, n. 3, 2010.
Miller Donna Rose, Language as Purposeful: Functional Varieties of Text - 2nd Edition, 2017.
Pastoor Charles, "The Absence of Atonement in Atonement", in Renascence, n. 66, 2014.
Pinter Harold, Five Screenplays, 1977.
Pinter Harold, Collected Screenplays Two, 2000.
7. Sitografia
Dizionario di Medicina Treccani, "complesso di Edipo"e "complesso di Elettra", 2010 (data di ultima consultazione 14/04/2017).
Lugli Emanuele, "Atonement’s green dress deserves all the accolades", in The Guardian, 2008 (data di ultima consultazione 20/05/2017).
McEwan Ian, "Interview", Frontline, 2002 (data di ultima consultazione 14/04/2017).
McEwan Ian, "An Inspiration, Yes. Did I Copy from Another Author? No.", in The Guardian, 2006 (data di ultima consultazione 14/04/2017).
Observer The, "‘It’s all about bums on seats’", in The Guardian, 2008 (data di ultima consultazione 20/05/2017).
Smith Ali, "Rereading: The Go-Between by LP Hartley", in The Guardian, 2011 (data di ultima consultazione 14/04/2017).
Thomson David, "Joseph Losey’s rebirth in Britain", in The Guardian, 2009, (data di ultima consultazione 15/04/2017).
8. Filmografia
Losey, Joseph, The Go-Between, 1971.
Wright, Joe, Atonement, 2007.
Foto 1 da Apple Books (data di ultima consultazione 25/08/2021).
Foto 2 da Tina Berning (data di ultima consultazione 25/08/2021).
Foto 3 da Bibliofreak.net (data di ultima consultazione 25/08/2021).
Foto 4 da Roger Ebert (data di ultima consultazione 25/08/2021).
Foto 5 da La Repubblica (data di ultima consultazione 25/08/2021).
Foto 6 da Period Drama News (data di ultima consultazione 25/08/2021).
Foto 7 da Telefilm Central (data di ultima consultazione 25/08/2021).