- Home
- Architectural Humanities Apri sottomenù
-
Progetti
Apri sottomenù
- Ecosistema Digitale per la Cultura - EDC
- Cittadinanza temporanea e nuova percezione della città: studenti, turisti, migranti
- Etiche ed estetiche della città
- Prospettive dell’estetica contemporanea
- Estetica di architettura, design, paesaggio e città
- Urban aesthetics networking
- Places and Memory
- Conferenze dottorandi
- Pubblicazioni Apri sottomenù
- Agenda
Volumi
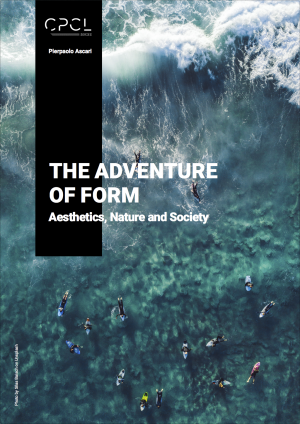
The Adventure of Form:
Aesthetics, Nature and Society
Pierpaolo Ascari
Traslated from italian by Violeta Fantoni
BK, CPCL series
2021, 139 pp.
Link all'editore
The parts of this book could be arranged with complete impunity around one of the brightest stars in the firmament of philosophy and aesthetic reflection. Moreover, that star does not merely suggest a hypothesis of thematic correlation between the individual parts, but raises the problem of their own tendency (as parts) to have always implied a recomposition. The reference is to Kant’s third Critique, where the overall view is a preliminary condition to any fragment of knowledge and experience: if in the following pages it is possible to find a certain number of connections, it is also in relation to the problem that Kant meant to resolve by identifying a faculty that binds the exercise of the intellect to the latency of an organic framework. A framework without any content, as is well known, except precisely that of the propensity of each phenomenon to be first and foremost part of something. According to Kant, it is only by virtue of this propensity that we can enter into a relationship with the world, that we can feel and perceive it and that we enable it to mediate, through the feeling of pleasure, the experience of ourselves. This is not a requirement of the world, since it does not fall within the phenomenal and mechanical horizon of knowledge, but an indispensable projection for the subject to establish contact with the evidence of any singularity. And it will be precisely to the release of this evidence that one of the first and most enthusiastic readers of the third Critique, Goethe, will immediately associate the notions of form, morphology and metamorphosis, pinpointing an opening which, through Kantian reflection, can lead to the topics we will discuss.
Table of content
Introduction: Form and Ground p. 7
Chapter One: Form and Metamorphosis p. 22
Chapter Two: Form and Matter p. 51
Chapter Three: Form and Force p. 62
Chapter Four: Form and History p. 76
Chapter Five: Form and Gender p. 89
Chapter Six: Form, Gender and Class p. 104
Chapter Seven: Form, Gender, Class and Race p. 120
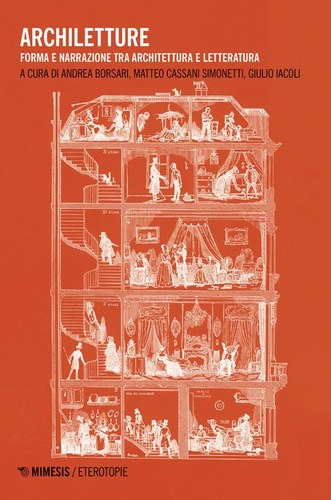
Archiletture
Forma e narrazione tra architettura e letteratura
a cura di Andrea Borsari, Matteo Cassani Simonetti, Giulio Iacoli
Mimesis, coll. Eterotopie
2019, 642 pp.
Archiletture si interroga sui rapporti tra letteratura e architettura portandosi alla radice di una possibile relazione strutturale tra le due discipline, senza limitarsi alla pur essenziale rilevazione tematica nei testi letterari di luoghi o figure in qualche modo interessanti per la cultura architettonica. Il suo centro di interesse è l’individuazione di casi di studio in cui l’affinità strutturale tra letteratura e architettura emerge come elemento caratterizzante il processo creativo e la riflessione sui modi in cui tale affinità si manifesta. I contributi inclusi nel volume riguardano, da un lato, opere letterarie la cui matrice è una forma architettonica e, dall’altro lato, opere di architettura – disegni, scritti, costruzioni – in cui la scrittura non svolge un ruolo sussidiario nel processo creativo, ma diviene altresì strumento per includere nel progetto la componente circostanziale della vita che si immagina svolgersi, o essersi svolta, nei luoghi o in relazione agli oggetti progettati.
Indice
Introduzione
Andrea Borsari, Matteo Cassani Simonetti, Giulio Iacoli, p. 9
Parte prima: Luoghi e strutture della narrazione
Strutture narrative e architettura dell'opera
Jacques Neefs, p. 39
Visionary, Prophet, Preacher: The Relationship Between Figuration and Narration in the Models of Artistic and Architectural Creativity Described by John Ruskin
Giovanni Leoni, p. 59
La Parigi "moderna" di Charles Baudelaire e Walter Benjamin
Antonio Pizza, p. 75
The Language of Architecture - The Architecture of Language: The Case of the Dutch Architect H.P. Berlage
Harman van Bergeijk, p. 91
Alcune considerazioni su spazio e tempo nella Affinità elettive di Johann Wolfgang Goethe (1809)
Roberta Malagoli, p. 105
Architectures (1921) e Eupalinos ou l'architecte: Note sulla Compagnie des Arts Français, un testo di Paul Valery e un recueil curato da Louis Süe e André Mare
Matteo Cassani Simonetti, p. 121
Parte seconda: Metropoli di carta: Gesti visioni, ornamenti
Mitopoiesi delle forme e delle figure: per una filosofia del gesto e della parola
Raffaele Milani, p. 143
Nagai Kafū and the Logic of Place in the City of Situations: Tokyo
Laura Ricca, p. 155
Distopie da un futuro passato: La visione di James G. Ballard
Federico Farné, p. 167
Architettura e letteratura, fantasmagoria dei luoghi e immagini di città di Siegfried Kracauer
Ivano Gorzanelli, p. 175
Metropoli senza coscienza di classe: Gli impiegati di Sigfried Kracauer come decostruzione della ratio nella spazialità del moderno
Mauro Pala, p. 187
Architetture-genere: Tre movimenti descrittivi dagli anni Sessanta (Parise, Bassani, Ginzburg)
Giulio Iacoli, p. 205
Parte terza: Case e corpi, libri e geografie
Una gita sulla collina del mormorio, ovvero una passeggiata fra arte, letteratura e architettura
Bertrand Westphal, p. 223
Architettura, Memoria e Riscritture dall'Hypnerotomachia Poliphili (1499) al Songe de Poliphile (1546)
Maria Gabriella Adamo, p. 237
Archilettura dell'Architettonico libro di Antonio Averlino Filarete
Marina Dalla Putta Johnston, p. 257
Per una grammatica della narrativa condominiale
Gloria Bonaguidi, p. 271
Forma della casa, forma del corpo, forma del testo: Magrelli nel "condominio di carne"
Riccardo Donati, p. 291
La casa chimerica
Andrea Borsari, p. 305
Parta quarta: Mondi di mondi
Architetture mondo
Susi Petri, p. 333
La stradario di una vita: Walter Benjamin e Léon Daudet
Pierpaolo Ascari, p. 353
La wonderbox di Henry James. The Turn of the Screw: architettura del testo, architetture nel testo
Paola Carmagnani, p. 369
Luoghi, oggetti e strane pratiche: Quattro panchine in Samuel Beckett
Ugo Cornia, p. 385
Interni, castelli e ville prussiane nella prosa del tardo realismo tedesco e il colombario romano di Friedrich Nietzsche
Stefania Sbarra, p. 397
Parte quinta: Spazi per immagini nel tempo
L'innocenza dei luoghi: Cronaca di un pellegrinaggio
Sergio Porta, p. 417
Anti-luoghi e contro-spazi: L'architettura manicomiale da Franco Basaglia a Fabrizia Ramondino
Marina Guglielmi, p. 435
Una casa come loro: Curzio Malaparte e John Hejduk
Lamberto Amistadi, p. 451
Qui e (non) ora: La spazializzazione del tempo in Here di Richard McGuire
Stefano Ascari, p. 469
«...and this is where I'll put the living room». Architetture a fumetti: Richard McGuire e Chris Ware
Michele Righini, p. 487
Narrare senza architettura: L'Islanda nei romanzi di Jón Kalman Stefánsson
Sofia Nannini, p. 501
Parte sesta: Scritture e costruzioni tra intérieurs e cityscapes
Alberto Savinio e lo spazio urbano
Rosita Tordi Castria, p. 515
Un «libro tradotto in pietre vive»: Narrazione e architettura nella costruzione del Vittoriale di Gabriele d'Annunzio
Micaela Antonucci, 523
Architecture in a Book. Le Corbusier's Le Poème de l'Angle Droit
Daniel Naegele, p. 545
Dal Cabinet d'objets précieux alla Maison-Musée: Architetture di interni nel XIX secolo tra scrittura, collezionismo, arti decorative e applicate
Cettina Rizzo, p. 563
Life in the big cities: Moltitudine e invisibilità metropolitana nella narrativa statunitense contemporanea
Fabio Vittorini, p. 577
La morfologia della Medina di Tunisi come narrazione urbana negli studi di Roberto Berardi
Francesca Privitera, p. 591
Profili biografici degli autori, p. 607
English abstracts, p. 617
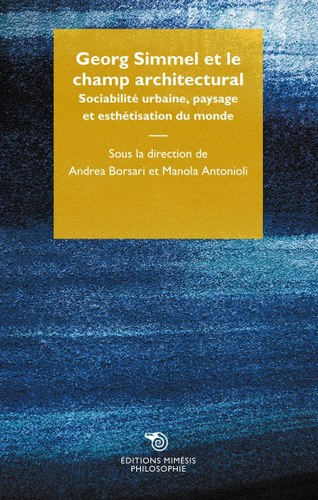
Georg Simmel et le champ architectural
Sociabilité urbaine, paysage et esthétisation du monde
sous la direction de Andrea Borsari et Manola Antonioli
Mimésis, coll. Philosophie
2020, 208 pp.
L’intention de cet ouvrage est de montrer l’importance de l’œuvre de Georg Simmel (1858-1918) en croisant différentes disciplines (philosophie, sociologie, anthropologie, théorie de l’architecture et de la ville) autour de la question de l’existence d’un « champ architectural » dans sa pensée.
Sommaire
Introduction
Andrea Borsari et Manola Antonioli, p. 7
Un champ architectural dans la pensée de Georg Simmel?
Andrea Borsari, p. 13
Sociologie de l'espace relationnel
Manola Antonioli, p. 41
Le ville comme forme de l'esprit objective: Quelques considérations herméneutiques
Denis Thouard, p. 55
Fragmentation et crise de la citoyenneté dans la grand ville contemporaine
Gregor Fitzi, p. 71
Simmel, Kracauer et la corporéité des choses dans la grand ville
Pierpaolo Ascari, p. 83
Sensualité, anthropologie et architecture: Méditations avec Simmel
Ingo Meyer, p. 95
Sensorialité métropolitaines: Objets sensibles et cadres spatiaux selon Benjamin, Simmel et le métro de New York
Henrik Reeh, p. 115
Simmel et la découverte du paysage
Paolo D'Angelo, p. 139
Grenzwesen: Espace, frontière, symbole chez Georg Simmel
Fabrizio Desideri, p. 155
Totalité et multiplicité
Jacinto Lageira, p. 169
La réception de l'œvre de Georg Simmel dans le champ architectural en France et en Italie
Alexandra Pignol et Cristiana Mazzoni, p. 183
Notes bibliographiques des auteurs, p. 199
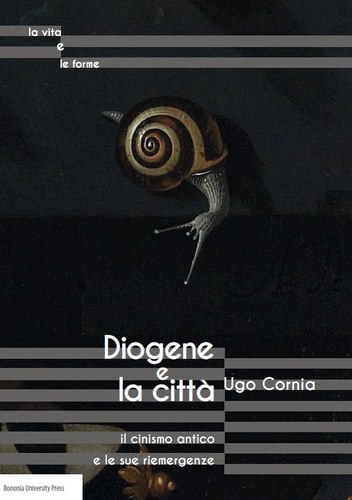
Diogene e la città
Il cinismo antico e le sue riemergenze
Ugo Cornia
BUP, coll. La vita e le forme
2021, 256 pp.
Il libro si propone di indagare, a partire dagli stimoli offerti dalle ricerche di alcuni filosofi e studiosi come Hadot, Agamben, Foucault, Fabbrichesi, Goulet-Cazé e Sloterdijk, la specificità dell’antico cinismo, una forma di vita molto particolare, il cui stile ha forse ancora oggi qualcosa da dire. A tale scopo, il testo ricostruisce un quadro di insieme che ricompone la peculiare forma di vita cinica, molto autarchica e polemica in relazione alle principali esperienze di vita: l’origine e la cittadinanza, il rapporto con l’economia, il potere, le convenzioni sociali, il sapere e la religione. Contestualizza inoltre la forma di vita cinica in relazione al contesto urbano, perché il cinismo si è sviluppato all’epoca della civiltà greco-romana e all’interno delle città. Nei templi o nelle piazze, attraverso comportamenti sfrontati e spudorati, veniva contestato l’abituale modo di vestirsi o di abitare, e veniva scarsamente considerato il ruolo delle normali consuetudini e delle leggi. Nella ricerca qui proposta viene inoltre indagata la persistenza di una corrente sotterranea del cinismo, con continue riemersioni, nel corso dello sviluppo della cultura occidentale, dalla fine del mondo greco-romano al diciannovesimo secolo. Riferimenti a Diogene sono anche presenti nella cultura araba e in alcune raccolte medioevali, così come in Erasmo da Rotterdam, Montaigne, Rabelais, Thoreau, Marx e Nietzsche. Per quanto riguarda il Novecento si sono analizzati alcuni motivi cinici presenti nella narrativa di vari autori come Tolstoj, Bernhard, Beckett, Hašek e Kristóf. Infine, in ambito filosofico, viene approfondito in quale modo il cinismo sia stato recuperato da Foucault e Sloterdijk, mentre per la sfera socio-economica si è cercato di evidenziarne i nessi con le proposte del pensiero della decrescita e di Ivan Illich.
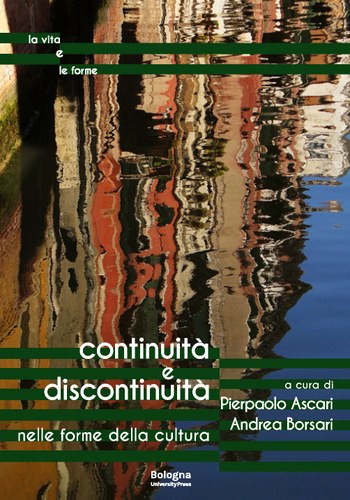
Continuità e discontinuità nelle forme della cultura
a cura di Pierpaolo Ascari e Andrea Borsari
Bologna University Press, collana La vita e le forme
2023, 125 pp.
L’ipotesi che sorregge la ricerca è che filosofia, letteratura, scienze umane e sociali del Novecento, soprattutto in ambito tedesco, ma non solo, siano state attraversate da una serie di domande che hanno interrogato le modalità con cui le varie forme della cultura e delle culture predispongono la comprensione del nuovo e il suo mostrarsi attraverso configurazioni precedenti. Formule di pathos e migrazione delle immagini, storia dei motivi letterari, filosofia delle forme simboliche e interpretazione figurale si compongono in una ideale connessione di intenti, intrecci, rimandi e conflitti che hanno nell’impresa di Hans Blumenberg una sorta di termine di comparazione e di centro di irraggiamento nelle diverse soluzioni. Per questo, il volume è racchiuso tra due interventi dedicati alla metacinetica delle metafore (A. Haverkamp) e degli orizzonti di senso epocali in Blumenberg (A. Borsari). Entro questa cornice, il libro esplora due possibili direzioni: le prospezioni sulla continuità e la discontinuità scaturite dall’energetica delle Pathosformel di Aby Warburg (A. Pinotti) e dall’affresco storico sull’unità della civiltà letteraria occidentale nella Toposforschung di Ernst Robert Curtius (F. Bertoni); gli scarti di continuità presenti nell’avvento dell’immagine fotografica secondo Siegfried Kracauer (O. Agard), nell’essere del non ancora di Ernst Bloch (M. Latini) e negli anacronismi di Alfred Sohn-Rethel (P. Ascari), nonché nel progetto di atmosferologia di Hermann Schmitz (T. Griffero).
Indice
Introduzione: Discontinuità e continuità
Pierpaolo Ascari – Andrea Borsari, p. 5
Metaphor, Discontinuity and Latency: Blumenberg’s Metaphorology between Aristotle and Saussure
Anselm Haverkamp, p. 15
«Camaleonte dell’energia»: La Pathosformel come neutro in Aby Warburg
Andrea Pinotti, p. 25
Ernst Robert Curtius: Topos
Federico Bertoni, p. 39
Siegfried Kracauer’s historical anthropology of photographic image
Olivier Agard, p. 53
Ernst Bloch e i passaggi di città
Micaela Latini, p. 65
Felt Body and Atmosphere: The (Neo)phenomenological Paradigm
Tonino Griffero, p. 75
Alfred Sohn-Rethel: forma-merce e forma-pensiero
Pierpaolo Ascari, p. 87
Epoche, pseudomorfosi, rioccupazioni: Hans Blumenberg, Hans Jonas e il problema delle soglie epocali
Andrea Borsari, p. 99
Gli autori, p. 125
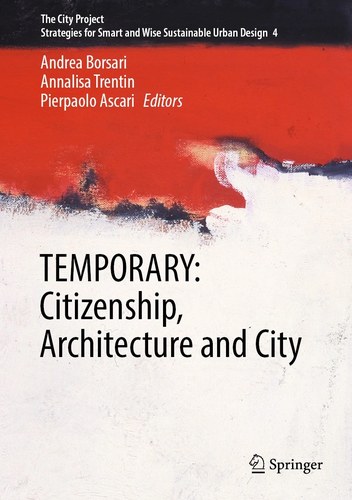
TEMPORARY:
Citizenship, Architecture and City
eds. Andrea Borsari, Annalisa Trentin, Pierpaolo Ascari
Springer, The City Project
2024, XI + 177 pp.
Table of contents
On Temporary: Citizenship, Architecture and City
Pierpaolo Ascari, Andrea Borsari, Annalisa Trentin pp. 1-9
Exploring Temporary
The Crisis of Citizenship. A Symptom of Societal Destructuration
The Dangerous Adventure of Designing Bubbles
Whose Shadow? On Camps and Counter-Camps
Inhabiting the Ecological Conversion: Experiments in Diavolution
Andrea Mubi Brighenti, pp. 49-55
Images of the People. Populus, Plethos, Plebs and Ethnos
Making the Temporary Become Chronic: The Transit City
Navigating Crises. Transient Communities for Urban Preparedness
Energy Community and Citizenship as Enabling Actions for Integrated Energy Plan Implementation and Urban Energy Transition
Art of Temporary Living: Looking Inside Student Rooms
Permanent versus Temporary: A Struggle within City Transformations
Dissonant Times
Assemblages/Decentralised
Andrea Cattabriga, pp. 123-126
Transition/Deviance
Valentina De Matteo, pp. 127-130
Hacktivism/Sexual Tourism
Francesco Di Maio, pp. 131-135
Life Cycle Thinking/Life Cycle Phase
Time-Based Packaged Goods/Valigia (Suitcase, Luggage)
Adaptation/Cueva and Tomas De Terreno
Marco Iannantuono, pp. 145-148
Temporary Uses/Pop-Up Spaces
Classroom/Digital Citizenship/Material Culture
Grenze Versus Schranke/Open Form
Deliberation/Climate Justice
Border/Rules
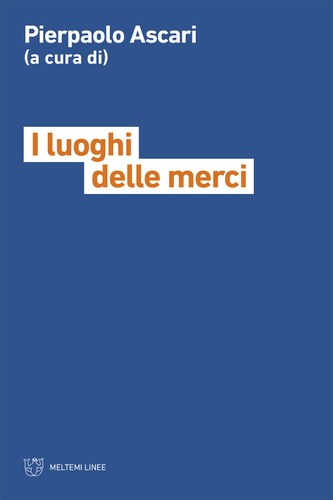
I luoghi delle merci
a cura di Pierpaolo Ascari
Meltemi, collana Linee
2022, 258 pp.
L’analisi di ciò che accade negli spazi deputati all’attività commerciale ci consente di stabilire che il valore si determina in rapporto a un’esperienza estetica, anche dei luoghi. Dal grande magazzino ottocentesco fino ai shopping mall contemporanei, la morfologia di questi luoghi risulta un delicato punto di equilibrio tra la volontà di favorire le prestazioni della merce, la rielaborazione dei repertori formali che si sono sedimentati nella storia dell’architettura e l’esito sempre incerto della loro contingenza, caratterizzata dalle medesime tensioni tra artificio e spontaneità che animano qualunque altro spazio rituale. Alla metafora ormai classica della cattedrale, l’esplorazione proposta da questo volume affianca le immagini altrettanto connotate del purgatorio, dell’apocalisse, dell’Eden o del Nuovo Mondo, con l’intenzione di provare a comprendere quali siano le esperienze che si determinano nella dimensione più prosaica e terrena della vita di ogni giorno.
Indice
Introduzione. Massa, luoghi e merci
Pierpaolo Ascari pp. 7-19
Zola e la ladra: i grandi magazzini
Pierpaolo Ascari pp. 21-68
Kracauer, Benjamin e i “Passages di Parigi”
Ivano Gorzanelli pp. 69-82
Il “nuovo Colosseo”: I Grandi magazzini Bocconi a Roma tra innovazione tecnica e monumentalità architettonica
Micaela Antonucci pp. 83-113
Strade e merci
Matteo Sintini pp. 115-125
L’autostrada come nuovo mondo
Ugo Cornia pp. 127-49
Abbondanza e apocalissi: il fumetto come luogo delle merci
Stefano Ascari pp. 151-173
La messa in causa delle merci contemporanee
Flaviano Celaschi pp. 175-189
Il Purgatorio della merce. Spazi e i riti della sostenibilità come salvezza dell’anima del consumo
Vando Borghi pp. 191-218
Il mall e oltre. Tipologia e dinamica di un luogo delle merci
Andrea Borsari pp. 219-249
Gli autori pp. 251-254
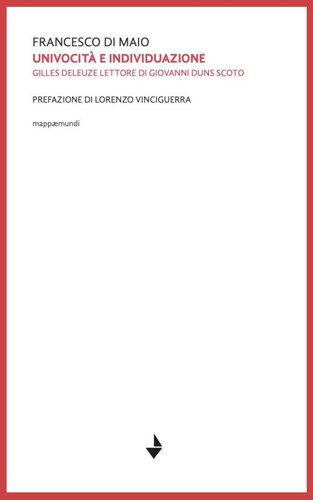
Univocità e individuazione
Gilles Deleuze lettore di Giovanni Duns Scoto
Francesco Di Maio
Ventura, collana mappæmundi
2023, 255 pp.
>https://www.mappaemundi.it/catalogo/univocit%C3%A0-e-individuazione
«C’è una sola proposizione ontologica: l’Essere è univoco. E c’è sempre stata una sola ontologia, quella di Duns Scoto». Nonostante il clamore di questa dichiarazione, il rapporto che Gilles Deleuze intrattiene con l’opera di Giovanni Duns Scoto non è mai stato analizzato nel dettaglio finora. Questo libro è la prima monografia in assoluto sul tema e colma questa lacuna negli studi critici. Attraverso la discussione delle fonti – Joë Bousquet, Maurice de Gandillac, Étienne Gilson, Pierre Bayle, fino ad arrivare allo scotismo barocco di Claude Frassen e a Gilbert Simondon –, assumono chiarezza le cause e le motivazioni di alcuni dei concetti più importanti che Deleuze mutua dal Doctor Subtilis. L’univocità dell’essere, la distinzione formale, l’ecceità: queste nozioni non solo innervano le opere del filosofo francese del 1968, Differenza e ripetizione e Spinoza e il problema dell’espressione, ma assumono un ruolo determinante anche nei testi scritti con Félix Guattari. Ed è così che Duns Scoto, sul cui volto sono ormai spuntati i «baffi imponenti» di Nietzsche, permette alla schizoanalisi di muovere la sua autocritica più importante, quella cioè rivolta al desiderio.
Sommario
Abbreviazioni 7
Prefazione: Lo scotismo sviluppato di Gilles Deleuze
di Lorenzo Vinciguerra
PARTE I: 1968
Capitolo 1: Appunti per un Medioevo minore. La tradizione dell'univocità dell'essere
1.1 Stato dell'arte e presentazione metodologica p. 17
1.2 Deleuze e la storia della filosofia p. 20
1.3 Prime perplessità p. 28
1.4 Deleuze e i medievali p. 31
1.5 Geofilosofia e Medioevo p. 33
1.6 Per una storia del concetto d'espressione p. 50
Capitolo 2: Sulle fonti dello Scoto di Deleuze
2.1 Uno stimolo incisivo p. 69
2.2 «Quisquilie», o di un certo stoicismo p. 76
2.3 Un'«ipotesi cosmica», o di uno spinozismo mancato p. 81
2.4 «Uno spinozismo non sviluppato», o dello scotismo per Bayle p. 84
2.5 Barbouillamenta Scoti, o della distinzione p. 95
Capitolo 3: Da Scoto a Spinoza
3.1 Sull'univocità degli attributi p. 113
3.2 Scoto fonte di Spinoza? p. 115
3.3 Per un'ontologia semiologica p. 119
3.4 Deleuze critico di Gilson p. 124
3.5 Sullo scotismo di Spinoza p. 152
PARTE II: 1977
Capitolo 4: Desiderio e individuazione
4.1 Simondon contro Scoto p. 173
4.2 1977 p. 182
4.3 Una rilettura p. 185
4.4 Sulla storicità del concetto di soggetto p. 188
4.5 H p. 190
4.6 Simondon con Scoto p. 194
4.7 Una grammatica dell'ecceità p. 210
Conclusioni p. 219
Bibliografia primaria p. 229
Bibliografia secondaria p. 233
Indice dei nomi p. 249

Siegfried Kracauer
Per una decifrazione estetica della città (1925-1937)
Ivano Gorzanelli
Ventura, mappæmundi
2024, 281 pp.
>https://www.mappaemundi.it/catalogo/siegfried-kracauer
«Una mitragliata di intuizioni minime» per liberare la dialettica dalla filosofia della totalità. Così Kracauer scrive ad Adorno nel maggio del 1930 volendo illustrare all’amico la caratteristica del proprio lavoro. Una propria via, strutturata. Il libro vuole discutere e indagare questa via attraverso la città: le sue forme, le sue immagini, le sue metamorfosi, nei testi degli anni Venti e Trenta fino all’indagine su Jacques Offenbach e la Parigi del suo tempo (1937). Avvalendosi di saggi, articoli di giornali, testi letterari e utilizzando le figure della luce come possibile accesso a una decifrazione estetica della modernità, questa ricerca ripercorre un periodo decisivo della storia intellettuale di Kracauer. Sono questi gli anni della lotta contro quell’idealismo che egli riteneva essere uno «spettro» capace di penetrare nelle nuove forme del divertimento per irrigidirle e trasformarle in rappresentazioni vuote. Il libro vuole poi descrivere una traiettoria nelle riflessioni di Kracauer sul destino della Germania sul finire degli anni Venti e inizio anni Trenta e indaga anche attraverso carteggi con altri importanti pensatori contemporanei, quali Benjamin, Löwenthal, Adorno, Bloch, come il pensiero e la scrittura di Kracauer siano cambiati mentre cresceva tutt’attorno l’onda nera del fascismo.
Sommario
Introduzione 9
Capitolo 1. La luce come decifrazione della modernità p. 251
1.1 L’arte e la vita: a confronto con Lukács p. 28
1.2 Mosaico e rappresentazione: un confitto estetico? p. 34
1.3 La «doppia esistenza» del viaggio e della danza p. 49
1.4 Georg Simmel, un’eredità difficile? p. 56
1.5 Napoli, Positano, Marsiglia: a confronto con altre immagini p. 63
1.6 Parigi, Berlino e la natura del paesaggio urbano p. 85
1.7 La luce come decifrazione della modernità p. 98
1.8 Sul metodo: leggere Kracauer p. 105
Capitolo 2. Ginster, critica della ragione geometrica p. 107
2.1 Tra due stupidità: autorappresentazione e immagine di sé p. 115
2.2 Il decoro e la rappresentazione geometrica p. 127
2.3 Anacronismo, spettri e suppellettili: Ginster e la storia p. 134
2.4 «Di fuori e di fronte»: Ginster, lo straniero p. 142
2.5 Essere altrove: il tempo osservato p. 149
2.6 Microscopi e acquari: sugli spettri, le forme e Gilbert Clavel p. 152
2.7 La radicalità della noia e quella della falsificazione p. 159
2.8 «Uno che non ha niente da fare»: stazioni, porti e rifiuti p. 170
2.9 Ginster e la ragione p. 181
Capitolo 3. Ambivalenza del mito e ambivalenza della ragione: sulle immagini di città in Siegfried Kracauer p. 187
3.1 Mito e immagini di città p. 194
3.2 Il mito come idealismo: contro Lukács e Buber, con Marx p. 201
3.3 Il mito e le Tillergirls: un confitto tra forme culturali p. 211
3.4 La decifrazione delle immagini spaziali come rappresentazione della disgregazione p. 218
Capitolo 4. Jacques Offenbach e la forma urbana dell’ambiguità p. 229
4.1 La rivoluzione del disprezzo e le immagini di città p. 238
4.2 Napoleone III e l’ambiguità dell’operetta p. 240
4.3 Una cultura urbana chiusa p. 243
4.4 «Il mondo era diventato democratico» p. 245
4.5 Intrattenimento, ebbrezza e città p. 247
4.6 Il confitto estetico, la natura della maschera e la propaganda p. 256
Capitolo 5. Una possibile conclusione p. 261
Bibliografa p. 271
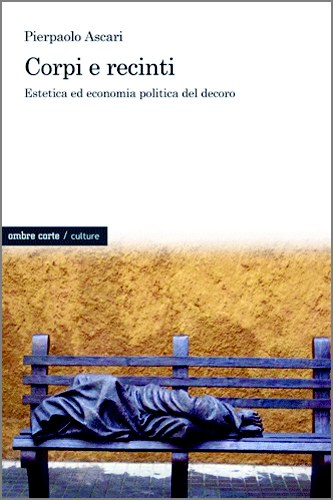
Pierpaolo Ascari
Corpi e recinti
Estetica ed economia politica del decoro
ombre corte, collana Culture
2019, 134 pp.
>https://www.ombrecorte.it/index.php/prodotto/corpi-e-recinti/
Le politiche per il decoro occupano da qualche tempo una posizione di punta nelle strategie per il governo dei comportamenti e delle diseguaglianze sociali. Apparentemente il divieto di stendere il bucato alle finestre o di coricarsi sulle panchine di un parco sembrerebbe rinviare al confine tra le prerogative del giudizio estetico e i problemi di ordine morale, ma osservate più da vicino tutte queste proibizioni si rivelano il prolungamento della guerra ai poveri e delle politiche migratorie con altri mezzi. Quelle che il decoro bandisce sono le impronte urbane della classe e della razza, la memoria vivente di una città sufficientemente porosa da lasciar intravvedere gli aspetti meno neutrali del paesaggio connaturato al potenziamento della rendita e del profitto. Delle pessime ragioni della pubblica decenza, dunque, è possibile tratteggiare un’economia politica che attraverso la formazione ottocentesca dei quartieri operai in Inghilterra, l’urbanistica coloniale di Algeri, gli uffici di collocamento nella Berlino degli anni Trenta, l’Italia delle migrazioni interne, gli Stati Uniti della tolleranza zero e i centri deputati allo smistamento dei migranti non ha mai smesso di assegnare allo spazio il compito di molestare e colpevolizzare le vite degli sconfitti. Ma il senso di queste molestie emerge in tutta evidenza attraverso l’analisi di quanto accade sui boulevard del Secondo Impero, dove all’allontanamento dei soggetti sgraditi dovevano innanzitutto corrispondere la produzione dei bisogni, i desideri e l’esperienza corporea dei soggetti conformi. Le politiche per il decoro, allora, si potrebbero definire forme di “recinzione percettiva”, misure di intervento sulla realtà percepita che delle vecchie enclo- sure trattengono sia la valenza predatoria che quella disciplinare, alimentando la percezione dell’insicurezza.
Indice
Introduzione p. 7
Capitolo primo: Kracauer e gli spazi tipici p. 15
Capitolo secondo: Marx e l’altro tempo p. 30
Capitolo terzo: Foucault e un certo modo di praticare la guerra p. 46
Capitolo quarto: Il boulevard p. 61
Capitolo quinto: Engels e il metodo Haussmann p. 73
Capitolo sesto: Fanon e la recinzione percettiva p. 91
Capitolo settimo: Per una critica punk al riformismo estetico p. 110
Conclusione: Nei luoghi delle merci p. 126

Oggetti contesi
Le cose nella migrazione
a cura di Pierpaolo Ascari
Mimesis, collana Eterotopie
2020, 198 pp.
>https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857568607
Per diventare cose, ha scritto una volta Remo Bodei, gli oggetti devono assumere una valenza soggettiva, emergendo dal campo di forze che se ne contendono il significato. Il caso più emblematico di questa emersione rimane probabilmente quello dello smartphone, il cui avvistamento tra le mani di un migrante prelude spesso allo sfogo di retoriche xenofobe e razziste. Al lato opposto della contesa, internet risulta invece il medium diasporico per eccellenza, perché solo nel cyberspazio è possibile accorciare le distanze che separano chi parte da chi rimane e coloro che partono tra di loro, trasformando dispositivi come la parabola satellitare o il telefono in un “frammento di casa”. Gli anziani che tengono a portata di mano cellulari, telecomandi, orologi, libri e interruttori riconoscono a tali dispositivi la medesima funzione, attribuendo a determinati oggetti la capacità di preservare un regime di “sicurezza ontologica”. Il presente volume, allora, si potrebbe anche intendere come un tentativo di preservare la traccia delle cose occultate dalle gerarchie di classe, di razza e di genere che ne forzano l’oggettivazione.
Indice
Introduzione: Le cose nella migrazione
Pierpaolo Ascari p. 7
La valigia: Madri, cose e spazi domestici temporanei nelle migrazioni forzate
Selenia Marabello p. 21
Il gelsomino e la mora selvatica: Le passeggiate sensobiografiche in una ricerca pedagogica con giovani rifugiati a Lecco
Silvia Luraschi p. 37
La qualità: La costruzione della “bianchezza” nelle linee di macellazione della carne
Valeria Piro p. 53
Il divano: Forme e spazi del contendere: elementi per un’antropologia del conflitto urbano
Giuliana Sanò p. 69
Lo smartphone: Ammu? Amar phone kuthay? Devices e apprendimento linguistico di bambini migranti: Riflessioni da un’etnografia condotta a Venezia tra famiglie bangladesi
Valeria Tonioli p. 85
Il tema scolastico
Rosalba Nodari, Silvia Calamai p. 99
Il bigliettino: Forme del parlare visibile nel paesaggio linguistico urbano
Ilaria Fiorentini p. 113
Il separé
Maria Carolina Vesce p. 129
La patata: Contese alimentari tra migrazioni e mobilità nelle valli alpine occidentali
Gaia Cottino p. 143
L’album di famiglia: Pratiche della memoria e forme di presentazione della coppia interculturale
Lidia Katia C. Manzo p. 161
Il lavabo: Bloch, Benjamin, Kracauer e la cancellazione delle tracce
Pierpaolo Ascari p. 179

Pierpaolo Ascari
Attraverso i confini
Lettura, storia ed esperienza estetica in Stendhal e Flaubert
Mimesis, collana Eterotopie
2018, 112 pp.
>http://mimesisedizioni.it/libro/9788857551302
Julien Sorel ed Emma Bovary muoiono perché hanno letto certi libri: c’è pochissimo da scherzare! Senza i memoriali di guerra o i romanzi d’amore le loro vite sarebbero state diverse o, per meglio dire, non sarebbero mai esistite. Chi le ha immaginate, quindi, non avrebbe mai sottoscritto le parole con cui Italo Calvino stabiliva che “all’interno dei libri l’esperienza è sempre possibile, ma la sua portata non si estende al di là del margine bianco della pagina”. La fiducia di Stendhal e Flaubert nell’esistenza di un passaggio segreto che conduca il lettore alla scoperta del mondo è incrollabile: per questo l’attraversamento di quel confine si rivela non solo possibile, ma necessario.
Indice
Premessa
Stendhal
Come un nemico
La discesa di Cristo al Limbo
Una storia assai complicata
L’amico di Joinville
Avevano delle amanti, loro
L’influenza del frac francese
Particolari sull’esecuzione
Myself
Flaubert
Polvere di vecchie sale
La magia del solo nome
Le opere più belle
Non ci capisco un bel niente
Un grande scrittore
Il pensiero del libro
Le tartine di Carlotta
Presto ci sarà un bel po’ di confusione
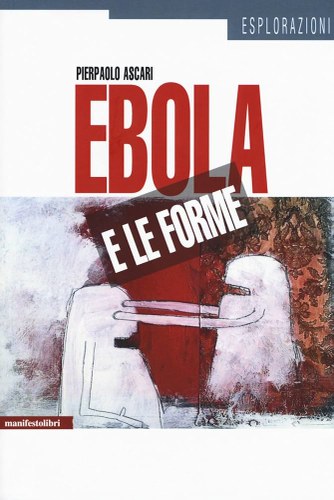
Pierpaolo Ascari
Ebola e le forme
manifestolibri, collana Esplorazioni
2016, 98 pp.
>https://www.manifestolibri.it/shop/ebola-e-le-forme/
Mentre in Africa Occidentale la febbre emorragica uccideva migliaia di persone, in alcuni villaggi della Guinea Forestale e negli slum di Monrovia si diffondeva uno slogan: “Ebola non esiste”. Eppure il virus era lì, davanti agli occhi di tutti. Cosa stava accadendo? Si trattava di una storia di altri tempi, come sostenevano in vario modo i commentatori europei, oppure l’inconscio coloniale tendeva a esorcizzare una realtà molto più vicina e contemporanea? Forse si poteva ricavare dalla cronaca l’oggetto per un’inchiesta filosofica, che a partire dal focolaio dell’epidemia conducesse al cuore stesso della modernità, dove il “sogno politico della peste” non ha mai smesso di organizzare uno specifico rapporto tra le tecnologie di governo e le forme di soggettivazione. Attraverso le analisi di Fanon, Foucault, Debord e Derrida, ricorrendo spesso alla rappresentazione letteraria del contagio, questo libro conferisce alla ribellione dell’Africa Occidentale un valore storico, che non investe solo il piano del “nostro modo di fare affari” ma ne interpreta la consistenza politica, accorciando le distanze apparentemente continentali che separano i dannati della terra dai populismi europei, dai loro show e dalla nostra esperienza del tempo.
Indice
Eccitazioni nervose p. 9
Ai bei tempi di Ellis Island p. 15
Monsignor Ebola a Roma p. 23
Il sogno politico della peste p. 29
Milano, 1630 p. 33
Lo spettacolo della quarantena p. 39
There is not alternative p. 45
Una storia d’altri tempi p. 49
Tensioni muscolari p. 53
Un’altra maledizione p. 61
Il peut-être della contingenza nel movimento autonomo del non-vivente p. 65
Nel futuro anteriore p. 71
Delle etnostrategie p. 74
Degli investimenti p. 77
Della legge p. 80
La mamaya politica p. 85
Massa e pigiama-party p. 93
Reificazioni p. 99
Il nostro modo di fare affari p. 103
Nei frammenti di silicio p. 107
Una cosa che non è una cosa p. 111
Animali politici p. 117
Note p. 122

Pierpaolo Ascari
Fine di mondo: Dentro al rifugio antiatomico da giardino
Machinalibro/DeriveApprodi
2024, 96 pp.
Con l’invasione dell’Ucraina e la distruzione di Gaza, nei nostri notiziari si è improvvisamente rifatta viva una vecchia conoscenza: la bomba atomica. A nominarla sono adesso ministri e presidenti che ancora una volta potranno poi celebrarne la funzione deterrente. Rischiamo così di ignorare quanto la bomba non abbia mai smesso di svolgere anche un secondo tipo di lavoro. Di questo lavoro, a partire dalla vicenda poco nota dei rifugi antiatomici promossi dall’amministrazione Kennedy nei giorni più frenetici della guerra fredda, il libro rende conto attraverso l’analisi della narrativa e del cinema di fantascienza, le fonti storiche e la cronaca di costume, il fumetto e la riflessione filosofica, per giungere alla conclusione che nonostante il loro fallimento commerciale, proprio quei rifugi avrebbero dato una forma compiuta alle proposte di salvezza che continuano a orientare il mondo sempre più pericolante in cui sopravviviamo. Insomma, ecco qua la storia di un incubo che non ha mai abbandonato le nostre vite.
Indice
Introduzione: Violenza e ironia p. 7
1. Raggi gamma p. 15
2. Stringete viti p. 21
3. Shelter morality p. 31
4. Ascensori fuori uso p. 39
5. Megalucertole p. 45
6. Macerie p. 53
7. Bill Maguire p. 59
8. Nuove frontiere p. 69
9. Parole di Dio p. 77
Epilogo: Sopravvivere alla bomba p. 83
Nota al testo p. 91
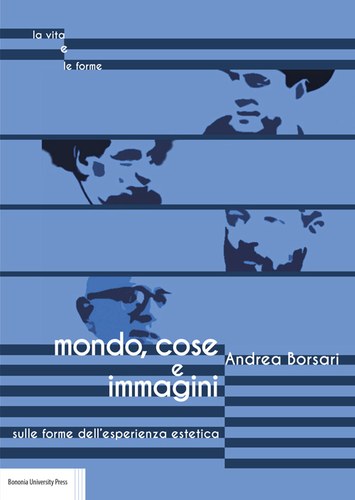
Andrea Borsari
Mondo, cose e immagini
Sulle forme dell’ esperienza estetica
BUP, collana La vita e le forme
2018, 192 pp.
https://buponline.com/prodotto/mondo-cose-e-immagini/
Il volume propone un itinerario attraverso la riflessione della filosofia contemporanea, seguendo il filo di tre termini decisivi per la delimitazione dell’ambito estetico, «mondo», «cose» e «immagini», e prendendo le mosse dalla ricostruzione del contributo di quattro pensatori individuati per la ricchezza e l’originalità con cui hanno elaborato tali nozioni e consentito di ripensare la relazione percettivo-sensibile con il mondo e l’esperienza nel suo insieme: Hans Blumenberg, Georges Perec, Georg Simmel e Theodor W. Adorno. «Mondo» circoscrive e illustra la pluralità dei contesti di esperienza e, al contempo, segna il concetto limite della totalità della realtà e del suo senso come mondo di mondi. Le «cose» hanno assunto nell’organizzazione del pianeta e nell’agire umano un’enorme importanza, in quanto oggetti del desiderio di massa, simboli di status nella società affluente, elementi di uno stile di vita nell’epoca del trionfo dell’immagine, strumenti di una consapevole inversione di tendenza nella cultura dei limiti dello sviluppo. Anche le «immagini» hanno un carattere pervasivo nella nostra esperienza quotidiana, collegato al trasferimento dei procedimenti di costruzione delle forme visibili dal campo dell’arte alla panoplia di dispositivi della visione che producono una sorta di realtà sostituta che arriva fino a saturare il nostro orizzonte. Al centro dei vari rimandi interni al libro si trova il rapporto che Simmel fu in grado di definire tra realtà visibile, sensibile e percepibile, e teoria, nella direzione di una modalità specifica del pensare attraverso le cose e le immagini, in una sorta di «teoria sensibile della modernità».
Indice
Introduzione p. VII
I. Realtà, mondo e cultura – Hans Blumenberg p. 1
1. Odisseo e la metacinetica degli orizzonti di senso p. 1
2. Per una tipologia del concetto di realtà p. 3
3. Coscienza della realtà e distanza ontologica p. 7
4. La possibilità del mondo: «Weltbilder» e «Weltmodelle» p. 14
5. Percorrere l’orizzonte p. 21
6. Metafore del mondo p. 26
7. Mondo della vita e concetto di realtà p. 31
8. Cultura tra realtà e finzione p. 39
9. L’antinomia antropologica: «Vogliamo tutto» p. 51
10. Il «più grande antropologo mancato» e l’opzione estetica p. 54
II. Cose, quadri e collezioni – Georges Perec p. 61
1. L’esprit des choses p. 61
2. La memoria ossessionata p. 68
3. La vita imperfetta p. 75
4. La compiutezza e l’inafferrabile p. 80
5. Lo specchio infinito p. 84
6. L’inganno dell’occhio p. 87
7. Collezionismo, rigore e passione p. 90
8. I collezionisti della Vita p. 91
9. Dai libri alle citazioni: collezionare Parigi (W. Benjamin) p. 93
10. I ricordi impacchettati p. 95
11. La memoria involontaria della collezione p. 96
III. Aisthesis, esposizioni e istantanee – Georg Simmel p. 101
1. Il «principio esposizione»: la percezione delle forme p. 101
2. Istantanee «sub specie aeternitatis» p. 114
3. Il significato estetico della distanza p. 117
4. Persistenza e transitorietà nell’immagine p. 120
5. Nucleo teorico e origine della «Kulturphilosophie» p. 121
6. Concetto e tragedia della cultura p. 124
7. Dialettica e rinascita della cultura (E. Cassirer) p. 127
8. Cultura soggettiva e cultura oggettiva p. 132
9. Costituzione storica e antropologica dell’aisthesis p. 134
IV. Mana, immagini e morfologia – Theodor W. Adorno p. 137
1. «Mana»: genealogia antropologica di una categoria dell’estetica p. 137
2. Convergenze e dissidi sull’immagine: Adorno e Canetti p. 145
3. Una fedelissima infedeltà filosofica: Adorno, Kracauer, Simmel p. 153
4. Personalità, realtà e sguardo p. 156
5. Pathos per l’immagine e relazioni fra le cose p. 159
6. Topografia dell’essere p. 162
7. Il «filosofo della civilizzazione europea» e il «viandante tra le cose» p. 166
8. Forme della società e forme dell’arte p. 168
9. Morfologia estetica e sociale: Simmel, Kracauer e oltre p. 171
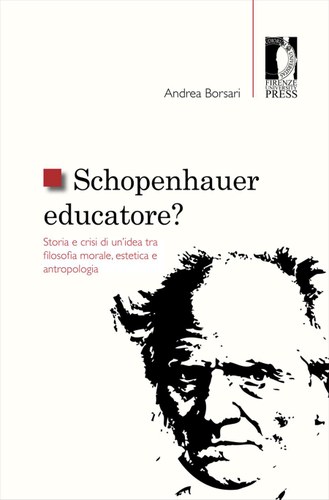
Andrea Borsari
Schopenhauer educatore?
Storia e crisi di un’idea tra filosofia morale, estetica e antropologia
FUP, collana Studi e saggi
2012, 112 pp.
https://books.fupress.com/catalogue/schopenhauer-educatore/2485
The book investigates the reflection of Arthur Schopenhauer on education, calling to mind some of the great figures who have underlined his value as educator: Nietzsche of the Third Untimely Meditation, Hadot and Foucault of the Art of Living and Care of the Self; or, from the opposite perspective, the roles that were projected onto the philosopher as a teacher: aesthetic educator who was master of artistic contemplation for numerous generations of artists and writers between the nineteenth and twentieth centuries, master of wisdom, revealer of Eastern cultures, eudaemonological model of practical philosophy. The research also examines the recent renewed interest in «formation» (Bildung) in order to repropose the problem of how to return from the viewpoint of Schopenhauer's «anthropological results» to the very conceptual core – the relationship between the educational field and philosophical universe of Schopenhauer in connection with his notion of the human subject.
Sommario
Presentazione: Arthur Schopenhauer nella storia e nella crisi dell’idea di Bildung p. vii
Capitolo 1: Il campo educativo schopenhaueriano p. 1
1. Il corpus teorico e testuale di «Erziehung» e «Bildung» in Schopenhauer p. 1
2. Educazione naturale vs educazione artificiale: l’«hysteron proteron» tra intuizioni e concetti p. 4
3. Il «pensare da sé» e la «diretta apprensione del mondo» p. 6
4. Successione naturale delle conoscenze e genesi del pregiudizio p. 8
5. «Leggere nel libro della vita»: il viaggio e la concezione esperienziale della formazione p. 10
6. Educazione ed età della vita: infanzia, giovinezza, maturità, vecchiaia p. 13
7. Educazione ed età della vita: prescrizioni formative per giudizio e memoria p. 15
8. Limiti e pregi educativi della lettura, dell’erudizione e dell’università p. 17
9. «Bildung» come processo e come risultato p. 21
10. Le difficoltà di una ricezione p. 22
11. Appendice: una riscoperta tardiva p. 26
Capitolo 2: Lo Schopenahuer «Erzieher» di Nietzsche, l’educazione estetica e il «maestro di saggezza» p. 33
1. Direttrici di lettura filosofiche del compito educativo in Schopenhauer p. 33
2. Friedrich Nietzsche e «Schopenhauer als Erzieher» p. 34
3. Vita filosofica, immagine dell’uomo e ideale educativo p. 36
4. A che cosa debba propriamente educare Schopenhauer p. 41
5. Schopenhauer e l’educazione estetica p. 42
6. Eudemonologia (Pierre Hadot) p. 45
7. Etica ed estetica del sé (Michel Foucault) p. 46
8. Maestro di saggezza? p. 48
9. Saggezza tra Oriente e Occidente p. 51
Considerazione intermedia: La Bildung nel pensiero tedesco contemporaneo – Una cornice teorica al contributo di Schopenhauer p. 55
Capitolo 3: Arte, impulso formativo e antropologia: Schiller, Heidegger e Marquard p. 59
1. Martin Heidegger lettore di Schiller: educazione estetica ed essenza dell’uomo p. 59
2. Conflitto e gerarchia delle facoltà nella definizione dell’umano p. 61
3. Arte e gioco come mezzi di educazione allo stato estetico e sviluppo dell’umanità p. 63
4. Odo Marquard lettore di Heidegger lettore di Schiller: contro il «fondamentalismo dell’arte» p. 64
5. Attesa di autenticità e pluralità della condizione umana e dell’educazione p. 66
Capitolo 4: Sulla crisi della Bildung: Henrich e Schleirmacher, Liessmann e Adorno p. 69
1. Dieter Henrich: la filosofia nel processo della cultura p. 69
2. Crisi e futuro della «Bildung» p. 70
3. Condizione umana – formazione – conoscenza: Henrich con F.D.E. Schleiermacher p. 72
4. Konrad Paul Liessmann: teoria della non formazione p. 74
5. Da «Bildung» (Hegel, von Humboldt) a «Halbbildung» (Nietzsche, Adorno) e «Unbildung» (Liessmann) p. 76
6. Gli errori della società della conoscenza p. 79
Conclusioni e nuove prospettive di ricerca: I «risultati» di Schopenhauer: Antropologia e «Bildung» p. 83
Bibliografia p. 89
1. Opere di Arthur Schopenhauer p. 89
2. Letteratura su Arthur Schopenhauer p. 90
3. Alcuni filosofi e filosofi dell’educazione in relazione a Schopenhauer e alla «Bildung» p. 94
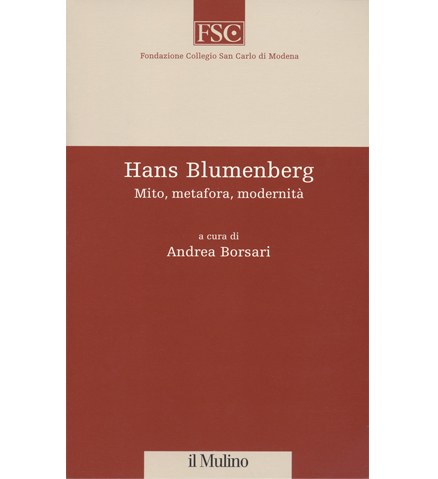
Hans Blumenberg
Mito, metafora, modernità
a cura di Andrea Borsari
il Mulino, collana Fondazione Collegio San Carlo di Modena
1999, 481 pp.
>https://www.fondazionesancarlo.it/pubblicazione/hans-blumenberg/
Alcuni tra i maggiori specialisti italiani ricostruiscono il pensiero e l’opera del filosofo tedesco Hans Blumenberg (1920-1996). Egli fu l’autore di libri brillanti come Naufragio con spettatore, L’ansia si specchia sul fondo, Il sorriso della donna di Tracia, che hanno alimentato con un’abilità letteraria ineguagliata nel secondo Novecento la tradizione saggistica e aforistica della filosofia tedesca, e di grandi opere come La legittimità dell’età moderna, La leggibilità del mondo, L’elaborazione del mito, Paradigmi per una metaforologia, Tempo della vita e tempo del mondo, che hanno rappresentato pietre miliari nella discussione di domande cruciali per la filosofia contemporanea. Tra queste: l’avvento della modernità fu una secolarizzazione del medioevo o una manifestazione dell’autoaffermazione umana di fronte a un creato ostile o indifferente? Che cosa segna il passaggio da un’epoca a un’altra? Esistono delle metafore fondamentali radicate nel mondo della vita e irriducibili a un contenuto concettuale, ed è possibile farne la storia? Il mito ha un’origine oppure il suo tramandamento è continua produzione di senso che include in sé il racconto della propria origine? Le prestazioni primarie della cultura umana sono quelle della messa a distanza dall’assolutismo della realtà?
Indice
Introduzione: Hans Blumenberg
Andrea Borsari, p. 9
Metafora e mito nell'opera di Hans Blumberg
Remo Bodei, p. 29
Metafora e metaforologia
Una filosofia in contro-luce: Glosse su teoria e metafora in Hans Blumenberg
Fabrizio Desideri, p. 47
Il progetto di metaforologia e l'Historismus di Hans Blumenberg
Barnaba Maj, p. 65
Blumenberg oltre Blumenberg: il linguaggio per metafore e immagini e la filosofia pratica
Francesca Rigotti, p. 97
Metaforologia e grammatologia: illeggibilità del mondo e indecidibilità del testo
Cristina Demaria, p. 109
Lavoro sul mito, lavoro del mito
Mitologie dell'oblio: Hand Blumenberg e il dibattito sul mito
Michele Cometa, p. 141
Illuminismo e docetismo: Blumenberg e Bultmann sul mito
Ezio Prato, p. 167
Glosse alla Passione
di Pierangelo Sequeri, p. 201
Tempo, storia, modernità
Platonismo dell'immanenza: Fenomenologia e storia in Hans Blumenberg
Gianni Carchia, p. 215
Il mito della storia: La dialettica della ragione storica nella riflessione di Hans Blumenberg
Flavio Cassinari, p. 227
Il gioco delle distanze: Tempo, storia e teoria in Hans Blumenberg
Bruno Accarino, p. 287
L'«antinomia antropologica»: realtà, mondo e cultura di Hans Blumenberg
Andrea Borsari, p. 341
Bibliografia e tavola delle abbreviazioni
Bibliografia, p. 421
Tavola delle abbreviazioni dei volumi di Hans Blumenberg citati, p. 475
Gli autori, p. 477
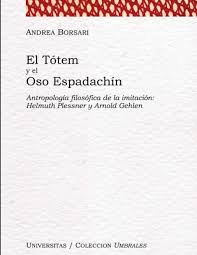
Andrea Borsari
El tótem y el oso espadachín
Antropología filosófica de la imitación
Plessner y Gehlen
Traducción de Carlos M. Martínez Ruiz
Universitas, coleccion Umbrales
2007, 200 pp.
El tótem y el oso espadachín es un libro de Andrea Borsari que explora las teorías de Helmuth Plessner y Arnold Gehlen sobre la relación entre el hombre y el animal a través de la mímica y la imitación. En la primera parte del libro, Borsari analiza la teoría de Plessner sobre la imitación como una forma de expresión humana y animal. Plessner sostiene que la mímica es una forma de comunicación no verbal que permite a los seres humanos y animales expresar emociones y sentimientos de manera efectiva. Borsari explora cómo esta teoría se aplica a la relación entre el hombre y el animal, y cómo la imitación puede ser una forma de conexión entre ellos. En la segunda parte del libro, Borsari examina la teoría de Gehlen sobre la imitación como una forma de adaptación humana y animal. Gehlen sostiene que la imitación es una forma de aprendizaje que permite a los seres humanos y animales adaptarse a su entorno y sobrevivir.
Índice
Abreviaturas, p. 9
I. Introducción, p. 15
II. Primera Parte: Helmuth Plessner: Mímica y antropología de la imitación, p. 31
1. El "Teatro de Marionetas" y el oso espadachín, p. 33
2. Lenguaje y expresión mí: hombre y animal, p. 38
3. Gesto-signo y mímico-expresivo: convencíon, inmediatez, interpretacíon, semejanza, p. 46
4. Antropología de la imitación : reciprocidad de la mirada y del esquema corpórea, p. 53
5. Acto imitatorio como "monopolio del hombre": ontogénesis y tipología, p. 60
6. Conditio humana: rol, actor, máscara, juego, p. 71
7. Plessner y el problema de la mimesis, p. 85
III. Segunda Parte: Arnold Gehlen: Totemismo y representatión imitativa, p. 93
1. El tótem y la caverna, p. 95
2. Las estructuras sociales de las sociedades primitivas: reciprocidad, exogamia, unilateralidad, totemismo, p. 108
3. "El hombre" desde los "sistemas supremos de guía" al "totemismo", p. 121
4. Totemismo y antropología filosófica: transponerse a otro, imitación, oportunidad objetica secundaria, p. 137
5. Antrpología del totemismo y represantión imitativa, p. 148
6. Actuar figurativo y teoría de las instituciones, p. 158
7. Gehlen y el problema de la mímesis, p. 165
IV. Bibliografía, p. 173
1. Mímesis e imitación, p. 173
2. Antropología filosófica, p. 176
3. Helmuth Plessner, p. 180
3.1 Obras de H. Plessner, p. 180
3.2 Obras acerca de H. Plessner, p. 182
4. Arnold Gehlen, p. 185
4.1 Obras de Arnold Gehlen, p. 185
4.2 Obras acerca de Arnold Gehlen, p. 187
5. Otros textos citados, p. 192
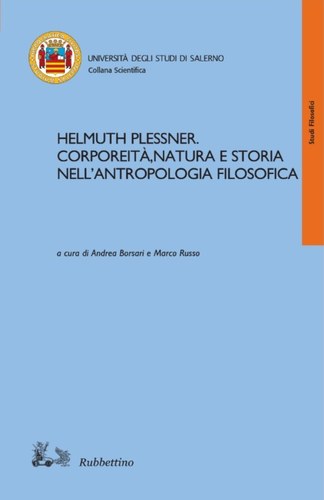
Helmuth Plessner
Corporeità, natura e storia nell’antropologia filosofica
Atti del Convegno internazionale di studi (Salerno, 27-28 novembre 2000)
a cura di Andrea Borsari e Marco Russo
Rubbettino, coll. Atti di convegni
2005, 286 pp.
È meno paradossale di quanto forse appaia il fatto che proprio quando si è cominciato a parlare di “post-umano” l’antropologia filosofica, dopo una fase di oblio, torni a suscitare interesse. Essa aveva avviato una nuova indagine sulla natura umana, sul senso da dare alla nostra identità, sicché molti aspetti oggi discussi riscoprono un ampio patrimonio di analisi e riflessione. Il volume raccoglie gli atti del primo Convegno internazionale in Italia su Helmuth Plessner (1892-1985) figura centrale dell’ antropologia filosofica del primo Novecento, la cui opera ben si presta al lavoro di comprensione e di riflessione sulla odierna condizione umana. Opera tanto articolata e stratificata nell’impianto teorico quanto suggestivamente agile nella varietà di temi che tocca: la logica del vivente e della sensorialità, la mimica, il riso e il pianto, il potere, lo spazio pubblico, i ruoli sociali. Originalità, spessore filosofico, penetrazione analitica ed ermeneutica fanno dunque di Plessner un autore chiave per alimentare il dibattito sull’antropologia, sul “personaggio uomo” nell’età che viene dopo, oltre l’umano. I contributi presenti in questo volume, fornendo una panoramica dell’opera plessneriana, ci mettono nel vivo di tale dibattito.
Indice
Introduzione
Marco Russo, p. 5
Sezione I: Filosofia della natura e critica dei sensi
«Posizionalità eccentrica»: La categoria fondamentale dell'antropologia filosofica plessneriana
Joachim Fischer, p. 21
Verkörperung: Considerazioni sul luogo dell'antropologia
Marco Rucco, p. 33
Il corpo essenziale: Un percorso di definizione del vivente e dell'uomo
Vallori Rasini, p. 51
Sviluppi eccentrici: Annotazioni su Plessner
Ubaldo Fadini, p. 67
Sezione II: Corporeità, espressione e mimesis
Il corpo mimetico: Helmuth Plessner e oltre
Christoph Wulf, p. 83
Mimica e antropologia dell'imitazione: Il problema della mimesis nella filosofia di Helmuth Plessner
Andrea Borsari, p. 93
Helmuth Plessner e il suo contributo alla filosofia dell'espressione
Renato Troncon, p. 135
Sezione III: Interpretazione della storia e antropologia della politica
Die verspätete Nation: Helmuth Plessner e i dislivelli della storia
Remo Bodei, p. 153
Coscienza storica e comprensione ermeneutica in Helmuth Plessner
Salvatore Giammusso, p. 161
Dalla metacritica dell'estraneazione all'antropologia retorica: A partire da Helmuth Plessner
Bruno Accarino, p. 177
Spiegare, comprendere, vedere «con altri occhi»
Luca Mori, p. 193
Ai confini della società: Öffentlichkeit e Macht nell'antropologia politica di Helmuth PLessner
Carlo De Rita, p. 203
Sezione IV: Teoria sociale e antropologia filosofica
L'antropologia filosofica di Plessner è una filosofia del performativa? Un confronto con Austin
Hans-Peter Krüger, p. 235
Il concetto di «limite» come categoria fondativa dell'antropologia filosofica: Un confronto fra Plessner e Simmel
Gregor Fitzi, p. 245
«Posizionalità» e «figurazione»: Teorie sociologiche e antropologiche incrociate in Helmuth Plessner e Norbert Elias
Karl-Siegbert Rehberg, p. 261
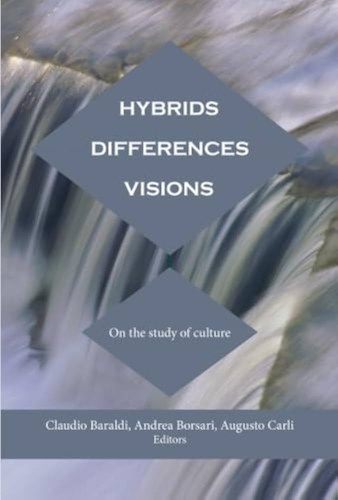
Hybrids, Differences, Visions:
On the Study of Culture
eds. Claudio Baraldi, Andrea Borsari, Augusto Carli
The Davies Group
2011, 286 pp.
>https://www.thedaviesgrouppublishers.com/baraldi.htm
This exploration of the various fields covered by the study of culture presents different approaches to the relationships between language, culture and society, and focuses on the importance of culture in modern and contemporary historical studies. By applying a variety of new analytical tools and concepts, the contributors demonstrate the usefulness of interdisciplinary approaches—based on anthropology, communication studies, cultural studies, history, linguistics, and philosophy—in understanding the multi-dimensionality of culture. The volume contains four sections, each representing a different theoretical approach. Each section is introduced by an interpretation of the theoretical background of the papers that summarizes the original spirit and contents of the conferences at which the papers were presented. The studies presented in this volume not only share a common theme (“study of culture”), but also imply openness to confrontation and negotiation between the different theoretical approaches that are represented.
Contents
Introduction: On the Study of Culture
Cesare Giacobazzi
Part I
Culture, Philosophy, Anthropology
Andrea Borsari
Human Adaptation to Culture
Michael Tomasello
Historico-cultural Anthropology as Centre of the Sciences of Culture
Christoph Wulf
One Thing Leads to Another: Material Culture, Anthropology and Evolution
Pier Giorgio Solinas
Part II
Intercultural Studies
Claudio Baraldi
Global Multiculture: Cultures, Transnational Culture, Deep Culture
Jan Nederveen Pieterse
Situating Cultural Studies in Communication: Cultural Discourse Theory
Donal Carbaugh
Death, Identity, and Discourse: Cultural Research at the Margins of Experience
John O’Regan
Part III
Languages and Culture
Augusto Carli
Other Languages, other Cultures
Marina Bondi
Ethnopragmatics and Beyond: Intentionality and Agency Across Languages and Cultures
Alessandro Duranti
Cultural Studies at “the Limits of Truth”
Bernard McGuirk
Part IV
Historiography and “Culture”
Michele Nani
Imperial Cultures and Cultures of Imperialism. The Case of India
Dietrich Harth
“Visual Culture” and Cultural Studies: Form, Genre and History in the Films of Yervant Gianikian and Angela Ricci Lucchi
Robert Lumley
Navigatio vitae
Saggi per i settant’anni di Remo Bodei
eds. Luigi Ballerini, Andrea Borsari, Massimo Ciavolella
Agincourt 2010, 555 pp.
Indice
Navigatio vitae
Luigi Ballerini, Andrea Borsari, Massimo Ciavolella, p. 13
A Philosophy of Impure Reason: Ethos between Rationality and Passions in Remo Bodei's Italy (1943-2006)
Andrea Borsari, p. 17
Passioni e persone
Roberto Esposito, p. 25
The Ordinary and Ita Discontents: Philosophy in Democratic Italy
Nadia Urbinati, p. 33
Hegel über Napoleon als Weltseele
Otto Pöggeler, p. 39
Desire
Adriaan Peperzak, p. 43
Invention et fabrication du vocable 'psychose'
Claude Bénichou, p. 48
Geometry of The Mind: A Jungian Analyst's Homage to Remo Bodei
Paolo Francesco Pieri, p. 76
Atto analitico atto giuridico: Paradossi, aporie, contraddizioni
Paola Mieli, p. 88
Self-Reprentation with and without Self-Portrait: Images of Self
Fausto Petrella, p. 107
Richard Wollheim on Art and Psychoanalysis
Efrain Kristal, p. 123
The creation of the human being through imagination
Christof Wulf, p. 135
La forza rivelatrice delle passioni: Circe e i teatri della memoria
Lina Bolzoni, p. 154
A la luz de la naturaleza muerta
Francisco Jarauta, p. 169
Iconologia e guerra: Questioni di metodo
Luigi Bonaparte, p. 177
Ordo passionis: Sul trinomio politica-potere-potenza
Giacomo Marramao, p. 189
Il potere tra sopravvivenza e riconoscimento: Per una critica dell'ideologia
Geminello Petrerossi, p. 200
Metafore del Potere tra violenza e ordine: Ovvero: del "volto della Gorgone"
Marco Revelli, p. 217
Storia e Destino
Massimo Cacciari, p. 233
Pensare per secoli? I tempi del tempo e i tempi della storia
Michelangelo Bovero, p. 241
Filosofia come istituzione?
Giuseppe Cacciatore, p. 257
Il lavoro e la conoscenza
Giovanni Mari, p. 268
Origini e significati del mito di Edipo
Umberto Curi, p. 287
La insensata fábrica del la vigilia: Nietzsche y el fenómeno del sueño
Sergio Sánchez
La teoria critica del mito
Mario Pezzella, p. 324
«Wo aber Gefahr ist, wächst Das Rettende auch»: Appunti da Heidegger e Bloch, a proposito di due versi hölderliniani
Tomaso Cavallo, p. 338
Tra l'ironia e l'umorismo: Pirandello e il problema dell'illusione
Alfonso M. Iacono, p. 359
Problemi connessi alle "identità plurime per soggetti plurali": Metafora e inventio
Vanna Gessa Kurotshka, p. 372
Snobbery: A Passion for Nobility
Barbara Carnevali, p. 384
Dell'incompletezza: La lezioni di Bernard Williams
Salvatore Veca, p. 407
John Rawls' A Theory of Justice
Sebastiano Maffettone, p. 416
Il contenuto repubblicano della Costituzione
Maurizio Viroli, p. 428
Verso una moralità liquida?
Remo Ceserani, p. 440
The de-thinging of the world
Francesca Rigotti, p. 456
Per una fenomenologia del vocativo
Roberta De Monticelli, p. 466
Vite pronominali: Divagazioni su Il noi diviso
Franca D'Agostini, p. 482
Remo Bodei: A Bibliography
p. 491
A Brief Biography
Remo Bodei, p. 548
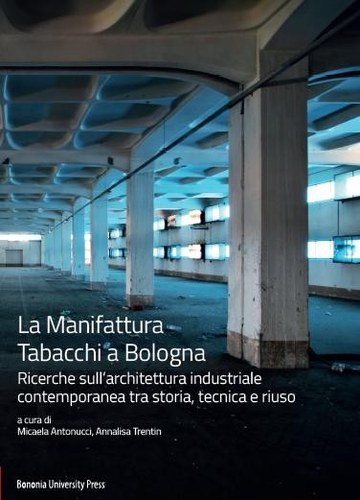
La Manifattura Tabacchi a Bologna
Ricerche sull’architettura industriale contemporanea tra storia, tecnica e riuso
Micaela Antonucci, Annalisa Trentin (cur.)
BUP, collana DA - Collana del Dipartimento di Architettura,
2019, 232 pp.
https://buponline.com/prodotto/la-manifattura-tabacchi-a-bologna/
Costruita in diverse fasi tra il 1949 e il 1963, la Manifattura Tabacchi di Bologna è stata uno dei simboli della rinascita di una città fortemente colpita dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Dopo decenni di intensa attività, nel 1998 inizia un periodo di graduale dismissione fino alla chiusura nel 2008. Quindi il degrado: finché nel 2011 la Finanziaria Bologna Metropolitana bandisce un concorso internazionale per la trasformazione del complesso in Tecnopolo della città. Il progetto di recupero della Manifattura Tabacchi rappresenta una grande sfida e una preziosa opportunità per recuperare alla città contemporanea un complesso architettonico e urbano così significativo, che questo volume si propone di conoscere in tutti i suoi aspetti: le vicende storiche, i caratteri costruttivi e tecnologici, il legame tra forma e funzione in una “estetica della fabbrica”, il rapporto tra architettura, produzione e contesto socio-urbano, il confronto con analoghe esperienze europee. Tra i protagonisti della storia della Manifattura emerge la figura di Pier Luigi Nervi (1891-1979), uno dei protagonisti dell’architettura e dell’ingegneria del Novecento che, nel corso della sua lunga carriera, ha progettato e costruito un grande numero di edifici per la produzione industriale mettendo a punto un modello originale in cui le necessità funzionali e strutturali trovano forma in soluzioni esteticamente innovative e fortemente espressive, del quale la Manifattura Tabacchi di Bologna rappresenta un caso tra i più significativi e interessanti.
Sommario
Presentazione
Sergio Pace, p. 7
Introduzione
Micaela Antonucci, Annalisa Trentin, p. 15
PARTE PRIMA: LA MANIFATTURA TABACCHI A BOLOGNA
Alle origini dell’architettura industriale a Bologna: la Regia Manifattura dei Tabacchi
Alessio Costarelli, p. 21
La Manifattura Tabacchi a Bologna di Pier Luigi Nervi: committenza, progetti, costruzione (1949-1957)
Sofia Nannini, p. 49
Building Machines: Process & Production in Pier Luigi Nervi’s Manifattura Tabacchi, Bologna
Thomas Leslie, p. 77
PARTE SECONDA: LA “FORMA DELLA FABBRICA”: PRODUZIONE INDUSTRIALE, ESTETICA E SOCIETÀ
Costruire per l’industria: Pier Luigi Nervi, la Manifattura Tabacchi di Bologna e i progetti per i Monopoli di Stato
Micaela Antonucci, p. 101
Città, lavoro, estrazione di valore: economia morale dello spazio urbano
Vando Borghi, p. 129
Ritorno a Coketown, la città della manifattura. Appunti per un’archeologia del decoro urbano
Pierpaolo Ascari, p. 155
PARTE TERZA: LA RIQUALIFICAZIONE DELLE ARCHITETTURE INDUSTRIALI: NOTE STORICHE E METODOLOGICHE
La riqualificazione delle fabbriche del tabacco: occasioni in sospeso tra vizi e virtù
Gabriele Neri, p. 173
Riflessioni per un riuso dell’ex Manifattura Tabacchi di Bologna
Annalisa Trentin, Tomaso Trombetti, p. 207
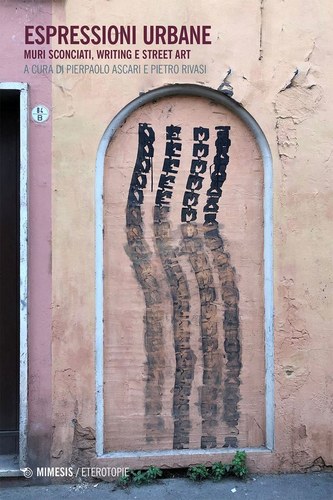
Espressioni urbane
Muri sconciati, writing e street art
Pierpaolo Ascari, Pietro Rivasi (cur.)
Mimesis, collana Eterotopie
2022, 146 pp.
https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857589398
Cosa stiamo realmente osservando davanti a un intervento di writing o a un’opera di street art? E qual è il rapporto che questi linguaggi intrattengono con un semplice muro imbrattato? Per tentare di rispondere a queste due domande, abbiamo convocato una serie di ambiti disciplinari che spaziano dagli studi culturali alla criminologia critica e al diritto, dall’educativa di strada all’antropologia, dalla storia dell’arte all’analisi degli stili, con l’obiettivo programmatico di alzare lo sguardo rispetto ai regimi discorsivi che trattengono la rappresentazione della città nel campo delle politiche securitarie e delle strategie di estrazione del valore.
INDICE
Nota editoriale
Pierpaolo Ascari, Pietro Rivasi, p. 7
Tensioni a Cyburbia: La città postfordista tra canoni estetici e stili di espressione
Pierpaolo Ascari, p. 9
Sul rapporto tra arte urbana spontanea ed istituzioni: un caso di studio
Pietro Rivasi, p. 33
Addomesticare la città: Consumo visuale e produzione di spazio
Sarah Gainsforth, p. 53
Sicurezza, decoro e pandemia
Tamar Pitch, p. 65
Lo scandalo dell’adolescenza nella città degli adulti
Giorgia Silvestri, p. 73
Ho fatto della mia casa il mondo: Street art, comunicazione, controcultura
Francesco Spagna, p. 81
Rovesciare la prospettiva: Arti visive e cultura visuale nel writing e nella street art
Claudio Musso, p. 89
Per una responsabilità “illegale” dell’artista
Fabiola Naldi, p. 101
Parole, immagini e muri: Il fumetto come scrittura dello spazio urbano
Stefano Ascari, p. 109
Profili di diritto d’autore nel graffiti writing e nella street art
Enrico Bonadio, p. 117
Sei scritture metropolitane
François Chastanet, p. 125
Per fare un tavolo: Competenze e municipalizzazione della creatività urbana in Italia
Luca Borriello, p. 133
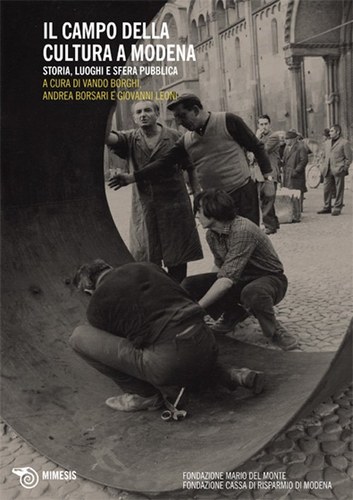
Il campo della cultura a Modena
Storia, luoghi e sfera pubblica
Vando Borghi, Andrea Borsari, Giovanni Leoni (cur.)
Mimesis, fuori collana
2011
https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857505251
Frutto di una ricerca pluriennale promossa dalla Fondazione Mario Del Monte con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, il libro è articolato in quattro parti. Nella prima sezione viene ricostruita la storia delle politiche culturali a Modena dall’inizio degli anni sessanta fino ai giorni nostri: storia delle istituzioni, ma anche delle trasformazioni sociali, delle iniziative e dei protagonisti che ne hanno caratterizzato gli orientamenti. La seconda sezione è dedicata allo studio dei rapporti tra il campo della cultura e la sfera pubblica, con particolare riferimento al problema dei mutamenti che sono intervenuti nella dimensione della publicness, attraverso l’analisi di alcuni casi esemplari. Nella terza parte gli spazi generati dalle attività degli istituti e dei centri di cultura sono stati rappresentati nella loro evoluzione storica e – contemporaneamente – nella chiave critica che nel tempo hanno assunto per la città. Come si è inscritta la cultura nel tessuto urbano? Che cosa ha spinto la politica modenese a occuparsi di cultura? Fino a che punto una politica culturale si può dire ancora pubblica? E quali sono le risposte che a queste domande possono dare gli archivi, la ricerca sociale e l’analisi dei luoghi? Nel tentativo di evitare qualsiasi semplificazione, il lavoro si completa con una quarta sezione dedicata all’approfondimento dell’apparato concettuale con cui ci si è confrontati nel corso della ricerca e della sua rielaborazione.
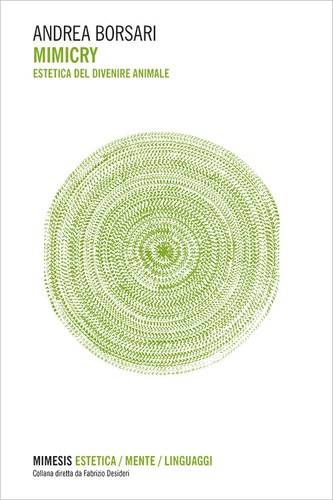
Mimicry
Estetica del divenire animale
Andrea Borsari
Mimesis, coll. Estetica/Mente/Linguaggi
2018, 154 pp.
https://www.mimesisedizioni.it/libro/9788857549132
Mimetismo (mimicry) o “lusso pericoloso tra natura e cultura”. Ciò che è in gioco nella famiglia di termini che, nel più vasto plesso mimesis, imitazione, mimetismo, delimita l’ambito in stretta connessione con il mondo animale è l’interesse per i fenomeni che in esso, o per analogia con esso nel mondo umano, si svolgono al di sotto, o comunque al limite, del livello della coscienza. Il “divenire animale” che si propone qui di indagare nelle sue implicazioni estetiche trova la sua posta conoscitiva nel rivendicare le ragioni di un sapere figurale e di una conoscenza “inconcettuale”. In particolare, tale sapere viene visto dispiegarsi, in maniera esemplare, nell’opera di Elias Canetti (1904-1994) e nella sua idea di metamorfosi, a proposito dei simboli della massa, dei deliri del potente, delle rappresentazioni pittoriche dell’orrore, delle riproduzioni imitative del copista e delle imagines agentes, fino a implicare un intero immaginario zoologico nei vari passaggi del suo riscatto creaturale. E nell’opera di Roger Caillois (1913-1978) e nella sequenza di immagini scaturita dalla sua tentazione mimetica, che va dall’identificazione zoomorfa con un principio aggressivo e distruttore illudendosi di poterne regolare il contagio, fino alla traduzione del mimetismo in principio di analisi dei fenomeni estetici e culturali, il gioco, il travestimento, la mimica, la mimetizzazione, le diverse gradazioni della somiglianza, l’imitazione e il mimo, la maschera e la metamorfosi.
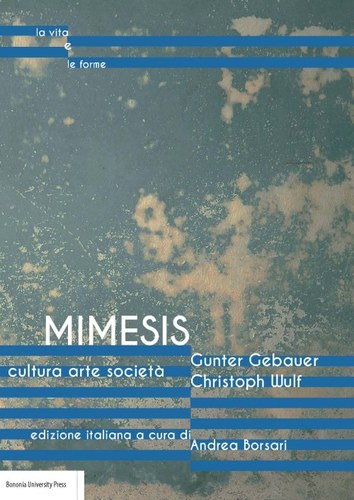
Mimesis
Cultura arte società
Gunter Gebauer, Christoph Wulf
edizione italiana a cura di Andrea Borsari
BUP, coll. La vita e le forme
2017, 416 pp.
https://buponline.com/prodotto/mimesis/
Testo di riferimento nella letteratura internazionale sull’argomento, tradotto nelle principali lingue di studio, Mimesis. Cultura, arte, società costituisce il lavoro di ricognizione d’insieme più esteso dedicato al problema della mimesis, dopo la monumentale opera di Erich Auerbach (1956) da cui prende esplicitamente le mosse, e ricostruisce le tappe principali dell’elaborazione della nozione dall’antichità classica, attraverso i teorici medievali, rinascimentali, sei e settecenteschi, fino al grande romanzo dell’Ottocento e alla filosofia contemporanea. Il termine “mimesis” non indica soltanto il processo di imitazione; oltre che all’ambito dell’estetica e dell’espressione artistica, si riferisce anche a una più ampia capacità di mimetismo, somiglianza, assimilazione, rappresentazione, simulazione, registrazione, espressione, anticipazione mimetica. La facoltà mimetica concerne le attività umane nel loro complesso e gioca un ruolo centrale nell’antropogenesi, nella nascita del soggetto e della socialità, nello sviluppo della personalità di ciascuno.
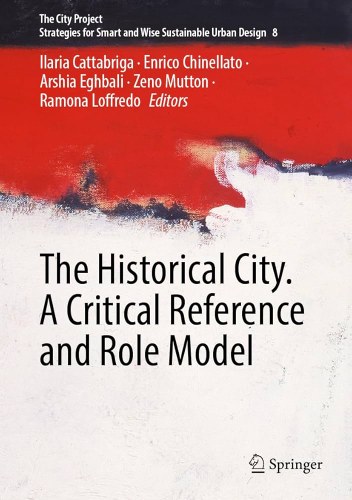
The Historical City
A Critical Reference and Role Model
Ilaria Cattabriga, Enrico Chinellato, Arschia Eghbali, Ramona Loffredo, Zeno Mutton (eds.),
Springer, The City Project series
2024, XI, 281 pp.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-71473-3.
This book offers a multivocal and interdisciplinary arena that brings together a wide range of thoughts and approaches addressing the intricacies of dealing with the historical city today. Spanning across a multitude of humanistic, sociological, and technological outlooks, it provides a multifaceted overview of current research on the city and its historicity. Based on revised and extended contributions presented at two international conferences, namely “The Historical City as a Critical Reference and Role Model for Innovative Urban and Metropolitan Development” (January 26-27, 2023) and “The Historical City as a Field for Critical Exercise. Criticism, Politics, Actors” (April 17, 2023), both held at the University of Bologna, this book is an insightful and thought-provoking read for researchers in Architecture, History, Urban Studies, Social Sciences, and the Arts, as well as professionals and policy makers dealing with historical cities.
Table of contents
Introductory Essays
Introduction
Ilaria Cattabriga, Enrico Chinellato, Arshia Eghbali, Ramona Loffredo, Zeno Mutton, pp. 3-7
The “Historical City” as Counter-Model and Urban History as Political Agent
New Urban Aesthetics and Historic City
Sensing the Historical City: Between Physical and Digital
Soma as and in Space: Public and Private
Postcards from the Pandemic: The Ghost Town
The Historical City in the Digital Age: On the Dynamic Relationships Among Seeing, Knowledge, and Power
Sensing the Inner City: A Conversation with Alex Rhys-Taylor
Zeno Mutton, Alex Rhys-Taylor, pp. 49-55
The City Between Geography and Aesthetics: A Conversation with Joe Blakey
Andrea Borsari, Arshia Eghbali, Joe Blakey, pp. 57-63
The Imperfect Citizenship of the Historical City
The New Life of the Old City. Museumification and Commodification as Dialectical Outcomes of Urban Modernity
Giacomo-Maria Salerno, pp. 67-72
For a Socio-Political Psychology of the City: Battles of Citizenship and the Historical City in Times of Change
Tourism-Led Development in the Cold War Era: Historic City as a Resource for the ‘Third World’
Student Life in the Historical University City: Bologna and Its Students
Transforming Urban Places: Political Participation of University Students in Bologna
Youth and Urban Citizenship: The ‘Youth Gang’ Phenomenon Between Conflict and Democratic Innovation
Alessandro Bozzetti, Nicola De Luigi, Ilaria Pitti, pp. 103-110
Urban Art as a Tool for Preservation/Innovation of the Historical City
Contemporary Forms of Urban Art in the Aesthetic Reinvigoration of the Historic City
Queering Public Art in the Historical City: Coming Out of “The Death of the Monument”
The Round Corner: Community Museology in the Bronx Street
Places of Remembrance: On Urban Aesthetics and Experiential Memories
Enacting the Traces of Change: Urban Artistic Practices as Memory Work in the Historic City
Enrico Chinellato, pp. 151-159
Critical and Historical Narratives on Historical Cities
Carlo Ludovico Ragghianti Politician and Intellectual. Defense and Development of the Historic City in Italy in the 40’s
Historical City, Metropolis, Continuity of Space: The Writings on the City by Fernando Távora (1952–1962)
Public History as Catalyst for Participation and Social Revitalisation: The Case of Vallette Estate in Turin
Histories of Historical Cities
The Conservative Restoration of the Historic City as Social Practice. The Study for the Historic Centre of Bologna by Leonardo Benevolo (1962–65)
Matteo Cassani Simonetti, pp. 195-205
The Construction of an Urban Imaginary: the Case-Study of the Cervellati Plan for the Historic Center of Bologna (1969)
Ilaria Cattabriga, pp. 207-217
Notes to the Social and Political Program for grandi contenitori the Historic Center of Bologna Taken from the Second Symposium of the Council of Europe (1974)
The Projects of the Ufficio Centro Storico After the Master Plans of Giovanni Astengo and Giuseppe Campos Venuti in Ancona in the Second Half of the Twentieth Century
Giovanni Bellucci, pp. 227-236
The Historic Center of Naples as a Paradigm of Urban Conservation: Conflicts and Contradictions, 1964–2024
The Conference on the Ancient Center of Salerno in 1967 in the Framework of the Italian Debate on Historic Centers
Valentina Allegra Russo, pp. 253-260
From Venice to Cusco, Leonardo Benevolo’s Urban Preservation Model in Latin America
Sphinx. Writing Urban Histories of Useless Objects
Urban and Cultural Policies. Matera and New Heritage Processes for Urban Regeneration
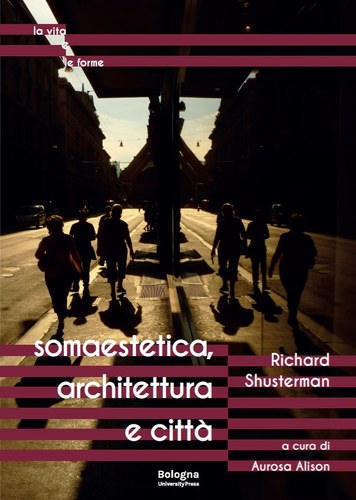
Somaestetica, architettura e città
Richard Shusterman
a cura di Aurosa Alison
BUP, coll. La vita e le forme
2024, 120 pp.
https://buponline.com/prodotto/somaestetica-architettura-e-citta/.
Consolidata come disciplina filosofica da oltre vent’anni, la Somaestetica si sviluppa attraverso il principio migliorativo dell’esperienza. Nel contesto di ridefinizione dell’estetica in termini percettivi e propriocettivi, Richard Shusterman rielabora negli anni Novanta l’estetica pragmatista attraverso il soma, inteso come corpo vivente, che allo stesso tempo percepisce e crea. Superando un’idea dell’estetica incentrata sull’apprezzamento, Shusterman si è concentrato soprattutto sull’aspetto applicativo e pratico che mette sullo stesso piano artista e fruitore. Viene così favorito il dialogo con discipline che si prestano ad un riscontro applicativo, come quelle dell’architettura e dell’urbanistica. Prendendo in considerazione gli aspetti progettuali, esperienziali e sociali, Shusterman interpreta l’architettura attraverso la partecipazione attiva del soma e, di conseguenza, i rapporti sociali, culturali e performativi con la città.

The Ecological Turn
Design, Architecture and Aesthetics beyond “Anthropocene”
Laura Succini, Loreno Arboritanza, Anna Chiara Benedetti, Karilene Rochink Costa, Simone Gheduzzi, Rosa Grasso, Ivano Gorzanelli, Simona Rinaldi, Ilaria Ruggeri, Ilaria Zedda
BK, CPCL series
2022, 435 pp.
https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/803
How does the ecological thinking affect architects, designers and the design culture itself? The Anthropocene is a geological event, but also a political one that lies in overcoming the idea of crisis. Acknowledging this change means rethinking the very ecology of the project in environmental and atmospheric terms. The changes we face don’t depend on missing balances, but on compromises reached between conservation and exploitation. The Anthropocene is in our suggested reading the time of the end of our representations and the time of the beginning of other narratives that belong to a non-linear dimension. Anthropocene is a category which has the merit of challenging our conventions in an oblique manner by reconnecting the history of mankind with the history of the Earth. In this respect, design visions can be the tool for activating new relations. Within this process of change, how do the figures of architects and designers rethink their role, their knowledge, experimenting with new design approaches? The conference wants to explore these issues from different points of view, in particular the “socio-bio-geosphere in its uncertain becoming by making the disciplines of the project communicate and by varying the scale of analysis, from the molecular scale of the environmental effects on our heritage, to that of the world’s flow of goods and capital.
Table of content
Introduction: Designing and representing the Anthropocene: a challenge for designers, planners and philosophers
Loreno Arboritanza, Anna Chiara Benedetti, Karilene Rochnik Costa, Simone Gheduzzi, Rosa Grasso, Ivano Gorzanelli, Simona Rinaldi, Ilaria Ruggeri, Laura Succini, Ilaria Zedda, p. 1
Call: The Ecological Turn
Loreno Arboritanza, Anna Chiara Benedetti, Karilene Rochnik Costa, Simone Gheduzzi, Rosa Grasso, Ivano Gorzanelli, Simona Rinaldi, Ilaria Ruggeri, Laura Succini, Ilaria Zedda, p. 13
SECTION .01 ECO-POLITICAL NARRATIVE DIVERSIFICATION
Reinhabiting. Eco-design, Care and Ecological Transition in the Permaculture Movement
Laura Centemeri, p. 18
The Anthropocene as a Regime of Visibility
Emanuele Leonardi, p. 32
Improving Mars: Elon Musk and the Promise of Salvation in Outer Space Environments
Miriam Tola, p. 56
Overlapping Narratives: Self-Representations of the Anthropocene
Stefano Ascari, p. 68
De-Sterilizing Design: Towards Non-Anthropocentric Strategies Beyond the Inert
Gabriel Alonso, Elena Brea, Pablo Ferreira Navone, María Buey González, p. 86
Mapping, Sensing and Hacking. Rethinking Architecture in the Era of the Anthropocene
Yael Eylat Van-Essen, p. 102
How to Fold Uncanny Valleys into Inhabitable Mountains
Andrej Radman, p. 118
SECTION .02 BEYOND THE DUALISM OF MAN - NATURE
Agency and Participation in a More-Than-Human Anthropocene: Reflections on Designing with Different Others
Gionata Gatto, Alessia Cadamuro, p. 133
The User in the Anthropocene
Tuğba Deringöl, Sema Serim, p. 149
Arks. Architectures of Retention
Alberto Petracchin, p. 162
Biodiverse Futures: Strategies for an Ecological Speculative Design Practice
Craig Jeffcott, p. 174
Natural Glitch
Luca Barbieri, Alberto Calleo, Giorgio Dall’Osso, Ludovica Rosato, p. 187
Energy Landscape, Escape the Petrolscape
Oscar Buson, p. 202
SECTION .03 THE TURNING POINT OF MATERIALS
Cambio
Formafantasma, p. 217
Syntropic Materials. Designing Forests to Design Natural Materials
Eugenia Morpurgo, p. 223
Carpentered Diegetic Things: Alternative Design Ideologies for AI Material Relations
Franziska Pilling, Paul Coulton, p. 240
Metabolic Architecture: Dialogues with Microbes
Rachel Armstrong, Rolf Hughes, p. 255
Material Preservation: Reuse of Man-made Capital as an Ecological Approach in Architectural Design
Elisa Zatta, p. 273
Bio-based Polymers for the Design of Temporary Structures through an Eco-Sustainable Construction Process
Marta Bonci, Davide Prati, Cecilia Mazzoli, p. 290
‘Making Kin’ in Fashion Design. From Agri-food Waste to Sustainable Materials in Italy
Ilaria Vanni, Alessandra Vaccari, Paolo Franzo, p. 305
SECTION .04 SHIFTING URBAN VISIONS
Neoanthropocene Augmented Cities
Maurizio Carta, p. 318
Towards Conviviality in Smart Territories
Federico Diodato, p. 332
Unblackboxing Waste Management in Practice. A Set of Actions Enabling Circular City Making
Saverio Massaro, p. 349
Pictures of Floating Grounds. Voluntary Exiles and Ecological Narratives: the Case of Oceanix Floating City Project
Matteo Vianello, p. 365
Cohabitation of Species and Design Cultures in Three Cemetery Areas in Berlin North-Neukölln
Elena Ferrari, p. 380
Towards a New Sublime? Designers Exploring the State of Indeterminacy and Facing the Unpredictable with Participatory Creativity and Through Common Research Actions
Elena Vai, p. 394
Design for Social Innovation in Italian Inner Peripheries
Dario Scodeller, Eleonora Trivellin, Davide Turrini, Marco Manfra, p. 408
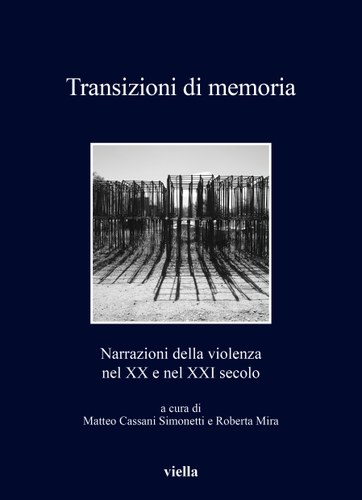
Transizioni di memoria
Narrazioni della violenza nel XX e nel XXI secolo
a cura di Matteo Cassani Simonetti, Roberta Mira
collana I libri di Viella
2025, 332 pp.
https://www.viella.it/libro/9791254697092
Indice
Matteo Cassani Simonetti e Roberta Mira, Introduzione. Ricordare la violenza: costruzioni e rappresentazioni della memoria
I. Rappresentazioni della memoria della violenza
Gaia Delpino, Rosa Anna Di Lella, Claudio Mancuso, Esporre la violenza. Memorie, conflitti e narrazioni nel Museo Coloniale di Roma
Xavier Gaillard, Prison Museums in Tehran and the Hegemonic-Populist Function: From Ebrat to Qasr
Federico Labanti, Nieves López Izquierdo, Archivi e luoghi digitali della memoria: Atlante interattivo dei rifugiati spagnoli in Francia (1939-40) – Progetto Carexil-Fr
Enrico Miletto, Confine di parole. La letteratura e la frontiera orientale d’Italia
Marco Sartor, Figurare il “confine”. La «zona grigia» nelle Storie naturali di Primo Levi
II. Memorie, rielaborazioni, rimozioni
Anne-Marie Broudehoux, Denied History and Contested Heritage: The Politics of the Memorialization of Rio de Janeiro’s Slave Past
Gianmarco Mancosu, La costruzione della memoria del colonialismo italiano tra omissioni, riscritture e una nuova presenza in Africa (1946-1970)
Thomas Ort, Remembering the Lidice Massacre, Forgetting What Caused It: Official Memory in Postwar Czechoslovakia, 1945-1967
Ugo Pavan Dalla Torre, Ricordare il trauma delle guerre del Novecento. L’esperienza dei reduci italiani e il ruolo dell’associazionismo nella creazione e nell’elaborazione della memoria dei conflitti
Elena Pirazzoli, Segreti di famiglia. Memoria intergenerazionale e rielaborazione narrativa e artistica della violenza del nazismo e della guerra tra i familiari di Täter e Mitläufer
Sara Ann Sewell, Echoes of Disembarkation at Auschwitz-Birkenau: The Sonic Memories of Survivors
Erika Silvestri, Un’ombra sulla famiglia: la difficile memoria del programma di eutanasia nazista nella società tedesca
III. Luoghi e memoria
Loreno Arboritanza, Narrazioni scomode. Architettura, memoria e politica
Ilaria Cattabriga, Un viadotto per dimenticare. Frammenti di memoria negli ex centri clandestini di detenzione, tortura e sterminio Club Atlético e Olimpo di Buenos Aires
Rafael De Conti Lorentz, The Impossibility of Representation: Peter Zumthor’s Design for the Topography of Terror
Mario Panico, Violence and Domesticity. Nazi Perpetrators’ Houses Between Preservation and Resemantisation
Arne Pannen, Luoghi della Memoria con una storia multipla: sfide e possibilità del lavoro didattico
Viktoriya Sukovata, Memory of Violence of the 20th Century in the Public Space of Kharkiv: Post-Socialist Transformations
Georgi Verbeeck, Afterword. Holocaust Memory as Moral Benchmark: Prospect and Challenges
Indice dei nomi
Autrici e autori
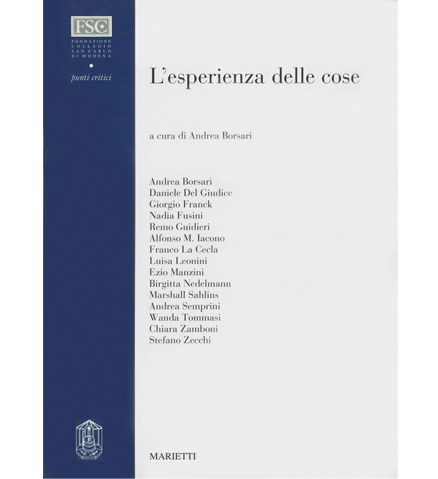
L'esperienza delle cose
a cura di Andrea Borsari
Marietti, PT
1992, 262 pp.
https://www.fondazionesancarlo.it/pubblicazione/lesperienza-delle-cose/
Un’immane distesa di cose si affolla nella nostra esperienza quotidiana. Sotto forma di oggetti tecnologici, di beni di consumo, di effetti personali, di arredi della casa e della città, oppure nella veste più ambigua di oggetti artistici o di presenze e desuete, proliferano a dismisura in ogni parte della nostra vita. Prodotti, scambiati, consumati, gli oggetti diventano parte integrante dell’identità degli individui e delle comunità. Incorporano i ricordi, le aspettative, i sentimenti e le passioni, le sofferenze e il desiderio di felicità. Attraverso di essi si mostrano concezioni, norme e valori del sistema culturale e, se costituiscono il canale mediante il quale gli individui si scambiano informazioni sulle definizioni che danno di loro stessi e sul mondo, nondimeno le stesse relazioni sociali li percorrono. La loro configurazione sensibile, il modo in cui sono progettati e costruiti, definisce gesti, comportamenti, modalità d’uso. Intorno a essi si produce comunicazione, le molte possibilità di significato che costituiscono il loro alone semantico vengono rese produttive dalla pubblicità. Oggetti del desiderio nel consumismo di massa, simboli di status nella società affluente, elementi di uno stile di vita nell’epoca del trionfo dell’immagine, strumenti di una consapevole inversione di tendenza nella cultura dei limiti dello sviluppo, comunque nella storia recente le cose hanno attratto su di sé il baricentro dell’agire umano. Attraverso il confronto con un’ampia scelta di campi disciplinari (filosofia, antropologia, sociologia, psicanalisi, semiotica, estetica, letteratura, scienza della progettazione) i quindici interventi del volume propongono una ricognizione, sullo statuto degli oggetti nella società contemporanea e sulle principali strumentazioni concettuali disponibili per l’interpretazione della nostra esperienza delle cose.
Indice
Introduzione
Andrea Borsari
Tra uomini e cose. A proposito di individualismo e olismo in Louis Dumont
Alfonso M. Iacono
Come stanno le cose. Il nuovo statuto degli oggetti
Franco La Cecla
Modernità, identità e consumi
Luisa Leonini
Oggetti, soggetti, testi. Aspetti semiotici della relazione oggettuale
Andrea Semprini
Il mondo che sembra. L'identità incerta del nuovo ambiente artificiale
Ezio Manzini
Gli oggetti, la letteratura, la memoria
Daniele Del Giudice
La cosa materna
Nadia Fusini
Le cose come segni, come idoli e come simboli. Il problema dell'immagine in Simone Weil
Wanda Tommasi
Le cose, i sentimenti e la realtà
Chiara Zamboni:
Esistenza e destino: L'uomo come cosa
Giorgio Franck:
L'arte salva le cose: Sul valore simbolico degli oggetti
Stefano Zecchi:
Chronique: Perdita di funzione degli oggetti e estetizzazione generalizzata.
Remo Guidieri
Oggetti d'arte- oggetti artigianali. Il problema dello stile di vita
Birgitta Nedelmann
L'economia del developman nel Pacifico.
Marshall Sahlins
Le cose e la memoria: Georges Perec
Andrea Borsari
Nota bio-bibliografica sugli autori
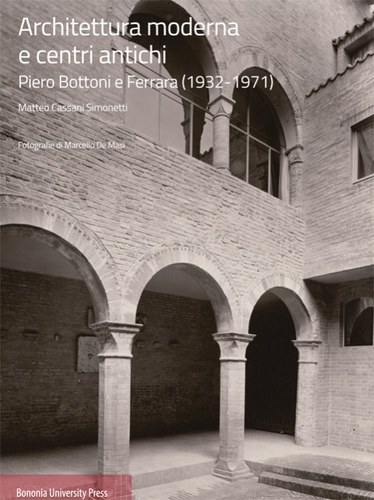
Matteo Cassani Simonetti
Architettura Moderna e Centri antichi
Piero Bottoni e Ferrara (1932-1971)
Bologna University Press
Collana DA - Collana del Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Architettura - DA
2016, 280 pp.
https://buponline.com/prodotto/architettura-moderna-e-centri-antichi/
All’interno dell’opera di Piero Bottoni (Milano, 1903-1973) la vicenda ferrarese occupa un posto di primo piano sia per la quantità di occasioni che per l’unitarietà dei problemi trattati; disposta lungo un arco temporale che copre quasi la totalità della vicenda professionale dell’autore, i progetti che la compongono sono tuttavia concentrati principalmente nel corso del secondo dopoguerra e nei primi anni Settanta e riguardano principalmente il tema della relazione tra progetto del nuovo e interpretazione dell’antico. I diciannove lavori che Bottoni elaborò, tutti situati all’interno del recinto murario della città estense, propongono soluzioni differenti – e a volte contraddittorie – rispetto al problema del «reinserimento dei monumenti storico-artistici nelle funzioni vitali della città». Ferrara vedeva in quegli anni coinvolte importanti figure della cultura italiana: da Bruno Zevi a Giovanni Michelucci, da Roberto Pane a Renato Bonelli, da Carlo Ludovico Ragghianti a Giorgio Bassani e la città e la sua architettura furono oggetto di approfonditi studi. In questo connubio di esperienze si svolse una vicenda che non può essere scissa in singoli episodi ma che nel suo insieme, invece, trova una dimensione corale: se poste in dialogo l’una con l’altra, le singole riflessioni acquistano significati maggiormente complessi configurando un ambito culturale peculiare per l’indagine sulla relazione tra modernità e storia.
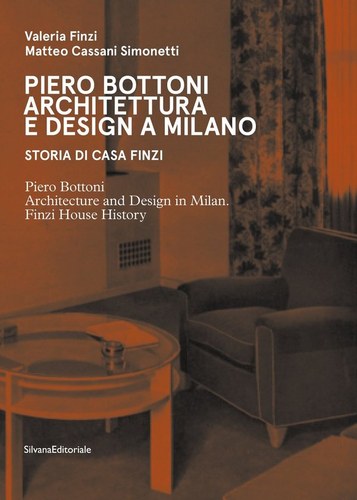
Valeria Finzi, Matteo Cassani Simonetti
Piero Bottoni
Architettura e design a Milano
Storia di casa Finzi
Pietro Bottoni. Architecture and Design in Milan. Finzi House History
SilvanaEditoriale, coll. Design & Designers
2018, 112 pp.
Protagonisti di questo volume sono la storia di una famiglia, della sua casa e dei suoi architetti nel corso del secondo Novecento. I Finzi, curiosi e innovativi professionisti internazionali, chiamarono Piero Bottoni (1903-1973) a disegnare i mobili e la sede dell’azienda di famiglia. I loro incarichi diventano così un campione significativo di quel momento storico. Successivamente all’intervento di Bottoni, casa Finzi è stata teatro dell’opera di Franca Helg, Vito e Gustavo Latis e Giovanna Franco Repellini, che ne hanno aggiornato il carattere in sinergia con i propri committenti. Questo libro permette di ricostruire alcuni episodi della stagione dell’architettura moderna degli anni trenta e quaranta relativi alla progettazione e alla produzione in serie di mobili e complementi d’arredo, che hanno gettato le basi del primo design milanese diffondendo uno stile, un modo di vivere, una moda.
Sommario
Introduzione
Valeria Finzi
Bottoni per casa Finzi
Giancarlo Consonni
Piero Bottoni e la famiglia Finzi. Architettura e arredamento a Milano tra il 1935 e il 1966
Matteo Cassani Simonetti
Storia e memoria di un’amicizia lunga quattro generazioni
Valeria Finzi
Storia di una casa e i suoi architetti: Franca Helg, Vito e Gustavo Latis e Gin Franco Repellini
Valeria Finzi
Appendici
Regesto degli arredi di casa Finzi
Nota biografica di Piero Bottoni
Giancarlo Consonni, Graziella Tonon, Lodovico Meneghetti
Bibliografia
Elenco delle immagini
Indice dei nomi
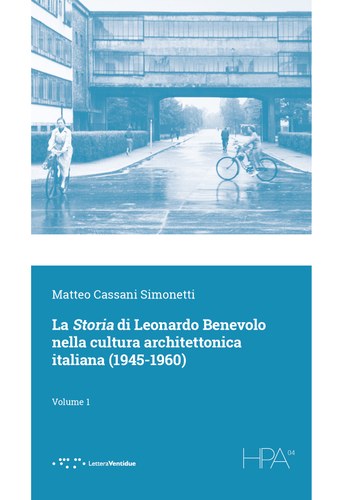
Matteo Cassani Simonetti
La Storia di Leonardo Benevolo nella cultura architettonica italiana (1945-1960), volume 1
LetteraVentidue, coll. HPA
2025, pp. 464
L’ipotesi della continuità del Movimento Moderno che sostiene la Storia dell’architettura moderna (1960) di Leonardo Benevolo vuole qui essere interpretata in due accezioni: nella prospettiva storiografica scelta dal suo autore e, soprattutto, nel modo in cui egli, posto di fronte ai problemi del suo agire pratico, sente il bisogno di stabilire una genealogia nella quale operare e alla quale aderire riconoscendo le qualità morali dei suoi protagonisti.
Indice
Prologo
Parte I. Profilo di un autore 1946-60
I. La formazione
Esordio. Nel quale si dà avvio a una vicenda
1. Leonardo Benevolo: tracce per una biografia della sua giovinezza
2. Note sull'insegnamento di Vincenzo Fasolo e ipotesi della sua impronta sull'opera di Leonardo benevolo studente
II. Alla ricerca di un progetto comune
Intermezzo. Nel quale il protagonista è specchio di una generazione
1. «I motivi dell'impegno sociale devono essere trovati nella natura stessa del lavoro tecnico». La dimensione tecnica come opera spirituale
2. Contro l'individualismo. L'ipotesi del teamwork della Ricostruzione al boom economico
3. «Nur belehrt von der Wirklichkeit, können wir Die Wirklichkeit ändern». Urbanistica e architettura come esperienza concreta
III. Tra storia e progetto
Intermezzo. nel quale si osserva una ipotesi
1. L'attività accademica e l'impostazione di un metodo storico
2. La conservazione dei centri storici come problema storico e come modello per la pianificazione della città moderna
Parte II. La costruzione della Storia dell'architettura moderna
IV. Il libro
Intermezzo. Nel quale si descrive un'opera
1. La Storia come opera totale. Concezione, individuazione del genere e realizzazione del volume
2. Addenda et corrigenda alla Storia: Una introduzione all'architettura e Le origine dell'architettura moderna
3. La Storia e le politiche editoriali della Editori Laterza nel campo dell'urbanistica e dell'architettura durante gli anni Cinquanta e Sessanta
V. «Method is more important than information»
Intermezzo. Nel quale si attraverso la Storia, deserto compreso
1. Sorgenti della Storia e strumenti per la sua costruzione
a. La bibliografia come atto dialogico
b. La fotografica come atto dialogico
2. Per una «continuità metodologica e ampliamento della rosa di esperienze». Una Storia sul metodo del Movimento Moderno
3. Tempi e geografia del Movimento Moderno
4. William Morris e Walter Gropius, i maestri di metodo. Per un'architettura come moto spirituale e pratica corale
5. Deformazioni, omissioni, invenzioni
VI. Figure
Intermezzo. Nel quale si dice di Benevolo quando ricevette la Storia
1. Le pagine della Storia
2. Album di viaggio
VII: La fortuna della Storia negli anni Sessanta
Intermezzo. Nel quale se ne tratteggiano gli sviluppi
1. Una storia condivisa e concreta. L'accoglienza della Storia e la sue traduzioni
2. Benevolo e la Editori dopo la Storia
Note
Regesto degli scritti
Bibliografia
Elenco delle figure
Indice dei nomi
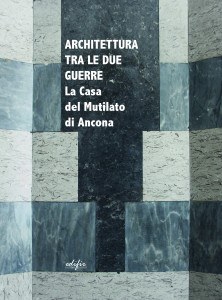
Donatella Biagi Maino, Matteo Cassani Simonetti e Alessandra Maltoni
Architettura tra le due guerre
La Casa del Mutilato di Ancona
edifir, coll. Arte
2019, 192 pp.
https://edifir.it/prodotto/architettura-tra-le-due-guerre/
Il volume descrive la Casa del Mutilato di Ancona, edificio di considerevole valore storico ed artistico. Costituisce una testimonianza tangibile e preziosa di un momento tragico della nostra storia, un momento che non va dimenticato.
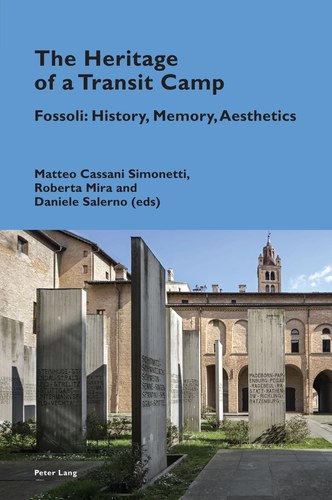
The Heritage of a Transit Camp
Fossoli: History, Memory, Aesthetics
eds. Matteo Cassani Simonetti, Roberta Mira and Daniele Salerno
Peter Lang, series Cultural Memories
2021, 328 pp.
https://www.peterlang.com/document/1140557
The former camp of Fossoli in northern Italy was established in 1942 by the Royal Italian Army as a camp for prisoners of war, later becoming a Nazi-Fascist concentration and transit camp for political opponents, Jews and forced labourers. After the war it became a Catholic community for orphans and a camp for refugees from the former Italian territories of Istria until 1970. A complex system of memory and heritage stems from the legacy of the former camp: its remains, the Museum and Monument to the Political and Racial Deportee by architects BBPR, and the synagogues of Carpi. The Fondazione Fossoli, created in Carpi in 1996, manages this legacy with the purpose of preserving and transmitting the historical memory of the Fossoli camp. Linking together the history of the Holocaust, the resistance to Nazi-Fascism and the political and civic commitment that inspired the birth of the Italian Republic after the dictatorship and the war, Fossoli lies at the very core of Italy’s contemporary cultural memory. The essays in this volume analyse, from different disciplinary perspectives, the material and immaterial heritage that constitutes a rich and articulated memorial system today.
Table Of Contents
Pierluigi Castagnetti, Foreword: The Heritage of a Transit Camp: Fossoli
1 Marzia Luppi, At the Roots of the Fossoli Foundation: The Fossoli Camp
2 Lorenzo Bertucelli, The Southern Terminal. Italy and the Memories of Deportation: A Transnational Perspective
3 Roberta Mira, The Fossoli Foundation and Its Heritage of History and Memory
4 Giovanni Leoni, In Memory of the Other Resistance: The Places and Architecture of the Fossoli Memorial
5 Robert S. C. Gordon, Pensaci, uomo!: Holocaust Memory, the Photo-Icon-Object and Licalbe Steiner at Carpi
6 Viviana Gravano and Patrizia Violi, Rethinking Trauma, Rethinking History: The Case of Fossoli-Carpi
7 Matteo Cassani Simonetti, Domesticity and Sacredness in Synagogue Architecture: The Oratory and Temple in Carpi (1722–1921)
8 Daniele Salerno, The Afterlife of the Fossoli Camp
9 Paolo Faccio and Andrea Ugolini, The Remains and the Landscape: Strategies for Active Conservation of the Former Campo di Fossoli
Essential Timeline
Notes on Contributors
Index
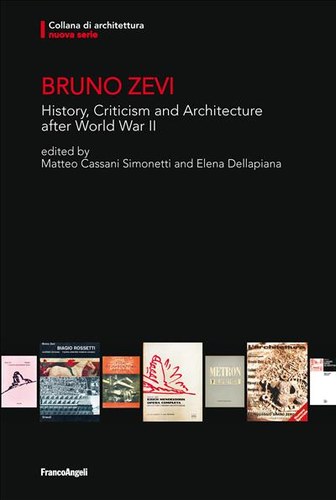
Bruno Zevi
History, Criticism and Architecture after World War II
eds. Matteo Cassani Simonetti and Elena Dellapiana
FrancoAngeli, coll. di architettura, n. serie
2021, 220 pp.
https://www.francoangeli.it/Libro/Bruno-Zevi?Id=27403
Sono spesso accusato di far troppe cose: L'Espresso, la rivista, i libri, l'insegnamento universitario, l'IN/ARCH, l'Istituto di Urbanistica. Ne sento io stesso il peso e mi domando se non sarebbe meglio tagliare la maggior parte di queste attività per dedicarsi con maggiore energia al lavoro scientifico. Il dubbio acquista spesso gli accenti di una "crisi" psicologica. Ma la mia, ch'io sappia, non è una crisi, oppure riveste origini remote e ha carattere permanente. Della fede dei miei avi sei milioni furono messi a morte senza ragione. [Bruno Zevi, 1960]
The book brings together critical updates on the figure of Bruno Zevi, considering his various facets as a historian, critic, journalist and reference point for design culture in Italy and abroad. These studies underline the attention to the urban dimension, which anticipates much of the Global History, the relationships with "other" cultural contexts that have declined alternative nuances to the Zevian adage of Organic Architecture. It also defined the connections - including the personal ones - with giants of architectural design and historiography, the contacts with disciplines that do not exactly coincide with the consolidated concept of architecture, and the operative effects on the practice of architecture and history: the result is a Bruno Zevi as a Transnational Cultural Mediator. This is not a monograph, therefore, but a meeting point for different, not necessarily homogeneous, perspectives, which seems to us to be of international interest, not only European, and useful for outlining further facets of Zevi's contribution to the design culture.
Table of contents
Ron Fuchs, Foreword
Fabio Mangone, Introduction
Dan C. Baciu, Questions and a Myriad Answers: Coming Together and Drifting Apart in the Historical Sciences
Donatella Calabi, Bruno Zevi: an Architectural Historian Looking to Urban Planning
Matteo Cassani Simonetti, "Assimilation" or "Diversity" of Jewish Architects and Jewish Architecture in Italy during the 20th Century. Notes on the Debate and the Reflection of Bruno Zevi
David M. Cassuto, "It is not incumbent upon you to finish the task, but neither are you free to absolve yourself from it". (Ethics of the Fathers)
Ilaria Cattabriga, Leonardo Ricci and Bruno Zevi: The Translation of "Anonymous" and "Organic" in the "Open Work"
Karine Daufenbach, The Brazilian Chapter: Brasilia as Highlight of Bruno Zevi's Narrative Verso un'architettura organica
Elena Dellapiana, "Inscape" beyond "Urba" and "Tecture". Zevi: Interior and Industrial Design. Critique and Dissemination
Luca Guido, Bruno Zevi and The Modern Language of Architecture
Ita Heinze-Greenberg, Heroic Narratives. Bruno Zevi and Eric Mendelsohn
Fabio Mangone, Bruno Zevi and Roberto Pane
Monica Prencipe, Organic Architecture, New Empiricism and the Modern Movement. Bruno Zevi's Polemic Use of Nordic Architecture within the Modern Discourse
Paolo Scrivano, Bruno Zevi, a Transnational Cultural Mediator
Tamar Zinguer, Bruno Zevi's Architecture Degree Zero
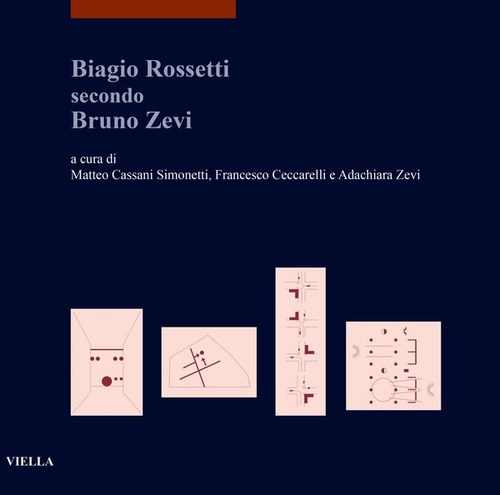
Biagio Rossetti secondo Bruno Zevi
A cura di Matteo Cassani Simonetti, Francesco Ceccarelli, Adachiara Zevi
Viella, coll. I libri di Viella. Arte
2021, 180 pp., ill. col.
Il volume riunisce due iniziative sul rapporto tra l’architetto ferrarese Biagio Rossetti, di cui nel 2016 ricorreva il cinquecentenario della morte, e lo storico dell’architettura Bruno Zevi, che nel 2018 avrebbe compiuto cento anni: una mostra, ospitata nella sede della Fondazione Bruno Zevi a Roma, e un convegno, svoltosi nel salone d’onore di Palazzo Tassoni a Ferrara, riuniti sotto il comune denominatore Biagio Rossetti secondo Bruno Zevi. Se la mostra aggiorna e rivisita quella eretica del 1956 – Identità di Biagio Rossetti, tenutasi nel Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara – curata da Zevi e allestita da Valeriano Pastor, il convegno riflette sul rapporto tra lo storico e la sua città di elezione.
Entrambe le iniziative ci guidano a «saper vedere Biagio Rossetti» e la sua Ferrara Nova che, grazie a quel filtro critico, sarebbe diventata la sorprendente metafora della città storica a misura di una diversa e altrimenti possibile contemporaneità.
Indice
Introduzione
La mostra
Sala 1. La mostra in mostra
Sala 2. Saper vedere Biagio Rossetti
Sala 3. Saper vedere l’urbanistica
Sala 4. Saper vedere la città
Il convegno
Roberto Dulio, Biagio Rossetti e il progetto storico di Bruno Zevi
Matteo Cassani Simonetti, Biagio Rossetti come pretesto
Elena Formia, L’editoria in Italia nel Dopoguerra e la Collana storica di Architettura di Einaudi
Matteo Iannello, Conoscere il passato per progettare il futuro. Bruno Zevi e gli allestimenti di mostre nell’Italia degli anni Cinquanta
Manuela Incerti, I rilievi per la mostra e il libro su Biagio Rossetti
Sergio Parussa, La dialettica dello spazio urbano. Per un confronto tra Bruno Zevi e Giorgio Bassani
Lucio Scardino, Mario Roffi, assessore illuminato (e non soltanto)
Testimonianze
Italo Zannier
Gianni Berengo Gardin
Valeriano Pastor
Bruno Zevi, Discorso inaugurale (Ferrara, 28 giugno 1956)
Didascalie
Abstracts
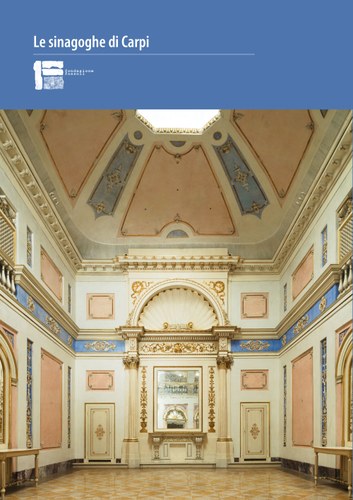
Le sinagoghe di Carpi
a cura di Matteo Cassani Simonetti
Bononia University Press, coll. Fondazione Fossoli
2023, 60 pp.
https://buponline.com/prodotto/le-sinagoghe-di-carpi/
La guida al complesso delle sinagoghe storiche offre uno strumento agile, ma curato ed esaustivo a quanti, sempre più, si avvicinano al patrimonio culturale e civile che la Fondazione Fossoli sta gestendo da anni. Un sistema di luoghi – e storie – differenti: importanti singolarmente, ma che costituiscono nel loro insieme un percorso speciale nella storia del XX secolo in grado di richiamare ogni anno un numero crescente di persone che per studio, interesse personale o altro fanno di Carpi una meta imprescindibile. Attraverso la storia del complesso delle sinagoghe storiche si propone un viaggio nella cultura ebraica, che a Carpi ha lasciato importanti testimonianze artistiche.
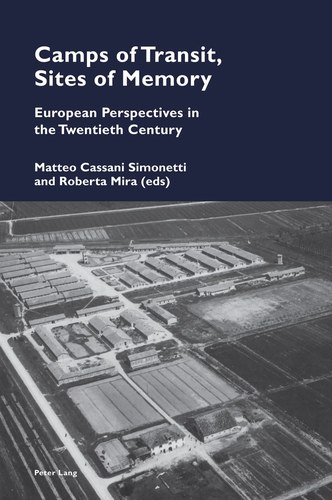
Camps of Transit, Sites of Memory
European Perspectives in the Twentieth Century
eds. Matteo Cassani Simonetti and Roberta Mira
Peter Lang, series Cultural Memories
2023, 324 pp.
https://www.peterlang.com/document/1300386
Summary
«Multidisciplinary and comparative, Camps of Transit, Sites of Memory brings new materials and approaches to the study of Fascist, wartime and postwar concentration and transit camps in Italy, as well as their legacies. An essential volume for the continuing study of this complex subject.» (Professor Mia Fuller, University of California, Berkeley)
Camps and places of transit assume relevance in certain contexts and in relation to specific events of the contemporary age: from genocide to voluntary or forced migration, from camps for prisoners of war to the management of refugees in conflicts or catastrophes. In the phases of transition to normality that follow such events, places of transit can be used for different, sometimes opposing purposes, such as the control and/or elimination of certain social groups, or as the protection of persons for humanitarian aims.
This volume investigates the relationship between camps and places of transit from three main perspectives: the history of transit camps in various countries and times; the relationship between such spaces, whose architectural characterization is fragile and difficult to recognize, and the great memorial and symbolic relevance of them; and, finally, the concepts of transit and camp, and changes in the meaning of such places and the memorial and educational practices related to them.
Table Of Contents
Matteo Cassani Simonetti and Roberta Mira, Introduction Transits: History, Memory and Spaces
PART I: Sites of Transit between History and Memory
1 Borbála Klacsmann, ‘It Was More Horrible than in Auschwitz’: A Comparative Analysis of the Transit Camps of Monor and Budakalász
2 Marco Minardi, Lives in Transit: Scipione Concentration Camp
3 Roberta Mira, Hunting for Manpower: Transit Camps for Forced Labour in Nazi-Occupied Italy
4 Francesca Rolandi, Camps for Foreign Refugees in Italy in the Central Decades of the Cold War
5 Laurence Schram, A Place in the Mist: The Mysterious Dossin Barracks in Mechelen
PART II: Spaces and Memory of Transit
6 John R. Barruzza, Countering Memory with Memorial: Remembering Indifference at the Shoah Memorial of Milan
7 Chiara Becattini, Memorial Sites at the Border: The Rice Mill of San Sabba and Natzweiler-Struthof
8 Matteo Cassani Simonetti, The Caserme Rosse Barracks, from Transit Camp to the Present: Notes about its Architecture and the Meanings of the Place
9 Andrea Luccaroni, Topography as a Memorial Shape: Learning from Transit Sites
10 Elena Pirazzoli, The Deviation of a Modernist Project: From Cité de la Muette to Drancy Internment Camp, up to Cité HLM
11 Claudio Sgarbi, The Concentration Camp and the Ideal City: Nomadelfia – a Camp-a-nomaly
PART III: Conceptualizations and Public Memorial Practices
12 Antonis Antoniou and Riki Van Boeschoten, The Spectre of the Yellow Warehouse: Transitions in Memory
13 Vando Borghi, The Camp Form and the Experience Infrastructures: A Counter-Fatal Research Perspective
14 Francesco Delizia and Andrea Ugolini, Fragile Memories: A Brief Historical Overview of Italian Conservation Laws on Fascist Concentration Camps
15 Ivano Gorzanelli, The Aporias of Civilization: An Itinerary between Images and Memory in Georges Didi-Huberman
16 Hans-Christian Jasch, The House of the Wannsee Conference as a Perpetrator Site
Robert S. C. Gordon, Afterword Transit
Notes on Contributors
Index
Series index
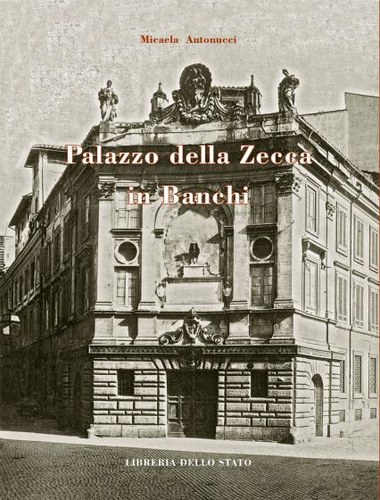
Micaela Antonucci
Palazzo della Zecca in Banchi a Roma
2008, 170 pp.
Libreria dello Stato, coll. Palazzi, Ville e Chiese di Roma
https://www.shop.ipzs.it/it/3000040110-1.html
L'opera prende in esame la storia del Palazzo della Zecca in Banchi non solo dal punto di vista architettonico ma anche per le questioni inerenti la monetazione e le tecniche del conio in quanto l'edificio era nato come una delle più importanti sedi della zecca di Roma. Il volume tratta poi le trasformazioni stratificatesi nel lungo arco di tempo tra il XVI e XIX secolo. Nonostante la frammentarietà progettuale e costruttiva, l'edificio mostra comunque una sua organicità e coerenza, frutto di un abile lavoro di ricucitura attraverso gli interventi attuati nel corso dei secoli. Il palazzo ha avuto una straordinaria seconda vita, legata sempre al denaro e al commercio, come sede del Banco di Santo Spirito.
Sommario
Abbreviazioni e misure, p. XVII
Da zecca a sede del Baci di Santo Spirito, p. 1
Il palazzo della Zecca in Banchi nella prima metà del XVI secolo, p. 2
Giulio II e la rifondazione della zecca pontificia, p. 2
La realizzazione della facciata monumentale nella Roma medicea, p. 7
Il palazzo sede del Banco di Santo Spirito (1665-1670), p. 15
Le trasformazioni ottocentesche: il progetto di Francesco Azzurri, p. 27
Architettura e città. Il quartiere dei banchi (1500-1550), p. 37
Gli interventi bramanteschi durante il pontificato di Giulio II (1503-1513), p. 38
La costruzione di San Giovanni dei Fiorentini e la sistemazione della zona dei Banchi da Leone X a Clemente VII (1513-1534), p. 47
Paolo III e il «piccolo tridente» di Ponte Sant’Angelo (1534-1549), p. 58
Antonio da Sangallo il Giovane e la facciata della Zecca, p. 65
Parole nuove con una lingua antica, p. 65
Il palazzo della Zecca e le fabbriche sangallesche nella Roma del primo Cinquecento, p. 82
Moneta e architettura nel XVI secolo, p. 95
Gli edifici di zecca in Italia, p. 95
La zecca di Roma, p. 100
Produzione monetaria e architettura. Una tipologia edilizia di «zecca»?, p. 106
Appendice documentaria, p. 115
Bibliografia, p. 135
Indice dei nomi, p. 145
Indice dei luoghi, p. 149
Referenze fotografiche, p. 153
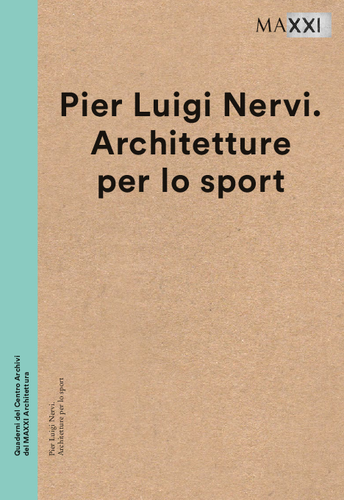
Pier Luigi Nervi. Architetture per lo Sport / Pier Luigi Nervi's Sports Facilities
a cura di Micaela Antonucci, con Annalisa Trentin e Tomaso Trombetti
Quaderni del Centro Archivi del MAXXI Architettura
2016, 96 pp.
La tipologia costruttiva delle architetture per lo sport percorre infatti tutta la lunghissima carriera di Pier Luigi Nervi, dallo stadio comunale “Giovanni Berta” di Firenze (1929-32) al Kuwait Sports Center (1968-69) passando per le opere realizzate per le celebri Olimpiadi romane del 1960. Una ricerca progettuale e tecnica che rappresenta un fil rouge esemplare, nella stretta connessione che vi si stabilisce tra forma, tecnica e funzione, dell’evoluzione delle idee e dell’opera di questo protagonista dell’ingegneria e dell’architettura italiane del Novecento. Sports architecture was present throughout Pier Luigi Nervi’s whole and very long career, from the Giovanni Berta Stadium in Florence (1929-32) to the Kuwait Sports Center (1968-69), and touching the projects executed for Rome’s 1960 Olympic Games. A technical and design research that represents an exemplary leitmotiv — because of the tight connection it establishes between form, technique and function — of the evolution of ideas and projects of this protagonist of Italian 20th century engineering and architecture.
Indice
Margherita Guccione, Perché una mostra su Pier Luigi Nervi e le architetture per lo sport • Why an exhibition about Pier Luigi Nervi’s Sports Facilities, p. 9
Carla Zhara Buda, L’Archivio Pier Luigi Nervi nelle collezioni del MAXXI Architettura • The Pier Luigi Nervi Archive in the MAXXI Architettura Collections, p. 13
Micaela Antonucci, Campione del cemento. Pier Luigi Nervi e le architetture per lo sport • Master of Concrete. Pier Luigi Nervi’s Sports Facilities, p. 17
Annalisa Trentin e Tomaso Trombetti, Pier Luigi Nervi – Master Builder, p. 41
Documenti in mostra • Material in Exhibition, p. 59
Benedetto Turcano, L’allestimento al MAXXI • Planning the Exhibition at the MAXXI, p. 73
Apparati • Appendixes, p. 80
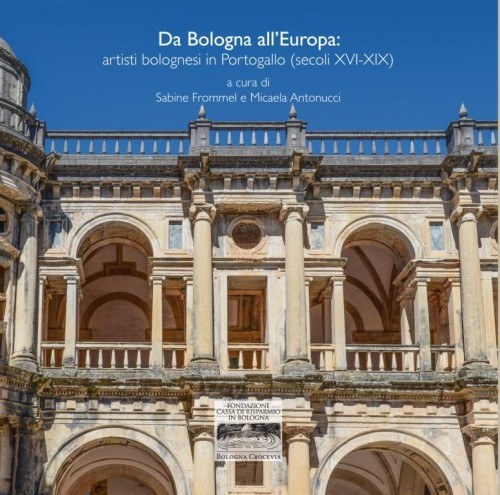
Da Bologna all’Europa: artisti bolognesi in Portogallo (secoli XVI-XIX)
a cura di Micaela Antonucci, Sabine Frommel
Bononia University Press
2017, 348 pp.
https://buponline.com/prodotto/bologna-crocevia/
I saggi raccolti in questo volume compongono un caleidoscopico, inedito racconto delle strette relazioni culturali e artistiche che si stabiliscono e crescono attraverso i secoli, dal XVI al XIX, tra Bologna e il Portogallo. Invisibili ma saldi ponti si stendono tra la città felsinea e la nazione lusitana, attraversati in entrambe le direzioni: Bologna è il luogo dove approdano molti artisti portoghesi, per formarsi presso il suo celebre Studium e per respirare le tendenze e gli stimoli che da tutta Europa in questa città si incontrano e si mescolano; e il Portogallo, terra di confine fra l’Atlantico e il Mediterraneo e dunque crocevia fra culture multiformi, è la meta preferenziale per un elevato numero di artisti bolognesi o che a Bologna si erano formati.
Bologna, attraverso questo nuovo sguardo, appare come un vero e proprio centro nevralgico europeo in molteplici ambiti, dal diritto alla letteratura fino alle arti, dall’architettura alle fortificazioni fino alle scienze: sempre di più questa affascinante città si conferma come un Crocevia e capitale della migrazione artistica, titolo di un ambizioso progetto di ricerca avviato nel 2009, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e dalla École pratique des Hautes Études (Paris-Sorbonne), che si è articolato in una serie di convegni e pubblicazioni di cui questo volume, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, è l’ultima tappa.
Sommario
Presentazioni
Fabio Roversi-Monaco, p. V
Claudio Leggio, p. VII
Sabine Frommel, Crocevia e capitale della migrazione artistica. Forestieri a Bologna e bolognesi nel mondo: le relazioni tra Bologna e il Portogallo, p. IX
I. Bologna, l ’ItalIa e il Portogallo nel rinascImento: Umanesimo e arte
Rafael Moreira, Bologna et le Portugal. Mille ans de rapports d’art et de culture, p. 3
Gian Mario Anselmi, Bologna crocevia, il Mediterraneo e l’Umanesimo portoghese , p. 11
Sylvie Deswarte-Rosa, Francisco de Holanda à Bologne, Pâques 1540. Les Portugais et Bologne durant le première moitié du Cinquecento, p. 21
II. Bologna e il Portogallo nel rinascimento: architettura
Daniele Pascale Guidotti Magnani, Filippo Terzi bolognese. Precisazioni biografiche e stilistiche, p. 71
Micaela Antonucci, Le due vite di Filippo Terzi, architetto e ingegnere dall’Italia al Portogallo, p. 83
Miguel Soromenho, Ricardo Lucas Branco, Te architectural career of Filippo Terzi in Portugal (1577-1597), p. 101
Francesco Ceccarelli, Da Filippo Terzi a Francesco Galli Bibiena. Una nuova attribuzione del codice 12956 della Biblioteca Nacional de Portugal, p. 125
III. Bologna e Il Portogallo neI secolI XVII-XVIII: arte e architettura
Marinella Pigozzi, Ogni opera d’arte si ritaglia tempi e spazi diversi , p. 139
Maria Isabel Braga Abecasis, Giovanni Carlo Bibiena, the Real Barraca and the old palace of Ajuda , p. 151
Giuseppina Raggi, Una lunga passione per l’opera in Portogallo: la regina-consorte Maria Anna d’Asburgo, l’arte dei Galli Bibiena e nuovi disegni per il Real Teatro dell’Ópera do Tejo, p. 159
IV. Bologna e Il Portogallo neI secolI XVIII-XIX: arte e architettura
Renata Malcher de Araújo, Antonio José Landi. «Egli solo restò nel Morticù», p. 191
Rui Lobo, Gian Giacomo Azzolini (1723-1791): a Bolognese architect between Lisbon and Coimbra, p. 203
Luís Soares Carneiro, Two theatres by Fortunato Lodi in Portugal, p. 227
Cátia Gonçalves Marques, Fortunato Lodi and the patronage of Joaquim Pedro Quintela: the Farrobo’s family mausoleum at the Convent of Castanheira, p. 243
Angela De Benedictis, Un problema storiografco: il Rinascimento bolognese in Italia e in Europa, p. 251
Tavole, p. 259
Abstracts, p. 271
Abbreviazioni, p. 279
Bibliografa, p. 281
Indice dei nomi, p. 307
Indice dei luoghi, p. 319
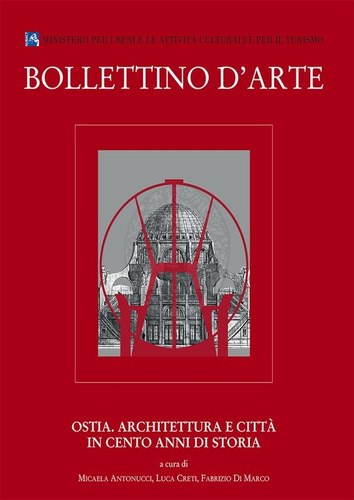
Ostia. Architettura e città in cento anni di storia
a cura di Michela Antonucci, Luca Creti, Fabrizio Di Marco
Bollettino d’Arte. Volumi Speciali, 2021
2021, XVIII-334 / 352 pp., 186 ill. col., 225 ill. b/n
Nel 1916 una sottocommissione dell’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura a Roma redige il primo piano regolatore di “Ostia nuova”, borgata marittima alla quale, nell’intenzione dei progettisti, è affidato il compito di fungere contemporaneamente da “ridente quartiere di abitazioni sul mare” e da scalo portuale, con un lungo canale navigabile che la collega direttamente con la prevista zona industriale della Capitale. Da quel momento in poi il piccolo e ameno insediamento delle origini che, nel corso degli anni, cambia molte volte denominazione (Ostia, Ostia nuova, Ostia mare, Ostia Lido, Lido di Roma, Lido di Ostia) riflettendo le diverse funzioni urbane progressivamente attribuitegli, inizia il suo sviluppo: da piccola città giardino — a bassa densità edilizia e nella quale le componenti “ambientiste” sono prevalenti, essendo dotata di ampie aree verdi e di strade sinuose che rispettano l’orografia del triplice sistema dunale su cui è impostata — a quartiere marino di Roma: con l’avvento del regime fascista si rinuncia infatti al porto e si vuole creare un vero e proprio brano di città, degna conclusione sul Tirreno di quella che deve essere la Capitale di una nazione che punta alla supremazia nel Mediterraneo. Da quel momento in poi, cambia tutto: il delicato assetto urbanistico primigenio viene stravolto e, con i successivi piani regolatori, Ostia — ribattezzata, non a caso, “Lido di Roma” — viene dotata di tutte le infrastrutture necessarie a un insediamento la cui popolazione, nelle previsioni dei tecnici e dei demografi, deve superare in pochi anni la soglia dei 100.000 abitanti. Sorgono in breve tempo numerosi edifici pubblici, mentre nelle costruzioni private, anticipate da rilevanti opere “di transizione”, prendono il sopravvento nuove architetture — alcune delle quali di livello internazionale — che, favorite anche dalla peculiarità del luogo, si ispirano ai dirompenti principi del Movimento Moderno. Il secondo conflitto mondiale rappresenta un brusco e doloroso spartiacque nella forma della città: nel dopoguerra, e fino ai nostri giorni, l’insediamento si uniforma infatti alle zone periferiche di Roma, sebbene non manchino, anche in questo periodo, episodi architettonici di riconosciuta valenza progettuale. La ricorrenza dei cento anni dalla stesura del primo piano regolatore di Ostia è stata celebrata con un Convegno, i cui contributi, ai quali se ne sono aggiunti altri — come quelli che hanno preso in esame un interessante, e poco noto, intervento sul “verde” negli scavi di Ostia Antica — sono stati raccolti nel presente numero monografico del “Bollettino d’Arte”. Preceduti da due introduzioni generali che, ripercorrendo in maniera dettagliata le vicende urbanistiche e architettoniche della città in un secolo di vita, fungono da indispensabile cornice, i di-versi saggi, curati da studiosi provenienti da prestigiosi atenei italiani, offrono una sintesi critica originale su alcuni dei temi più noti e indagano su opere e fasi storiche fino a oggi poco o per niente approfondite.
Ostia. Architecture and the town across a century
In 1916 a subcommittee of Rome’s Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura drew up a first general urban development plan for “New Ostia”. The intention of those that worked on the project was to give the seaside suburb, “a smiling residential quarter by the sea”, a dual role. It was to act as a maritime hub for the capital. A long navigable canal would connect it with what was projected as Rome’s industrial estate. It was from this moment that this small and pleasant town, which had had a myriad of names since its foundation, Ostia, Ostia nuova, Os-tia mare, Ostia Lido, Lido di Roma, Lido di Ostia, began to develop. Its changing names reflected the variety of urban roles it played at the time. It originated as part of the garden city movement, with low density housing and an emphasis on environmentally friendly features, open green spaces and winding streets, which respected the natural triple layout of the dunes it lay on. From this it developed into Rome’s seaside resort. With the arrival of the Fascist regime, the idea of a port was abandoned and instead the town was to become a self re-specting branch of the city. This was the proud conclusion on the Tyrrhenian Sea of the capital city of a nation poised to dominate the Mediterranean. From that moment everything changed. The original, sublime, town plan was turned on its head by subsequent general urban development plans. Ostia became “Lido di Roma”, with an urban infrastructure capable of sustaining a population that technical and demographic research suggested would exceed 100,000 in the course of the next few years. Numerous public service buildings soon went up. The architecture of the private housing, following some significant constructions during the transitional period, soon embraced the modern style, in some cases of international prestige. Facilitated by the natural landscape, the new buildings were inspired by the vola-tile principles of modernist architecture. The Second World War was to be a brusque and painful watershed in the formation of the town. After the war and right up to the present day, Ostia fell in line with the other districts in Rome’s hinterland. It has to be said though that some of its architectural projects are still worthy of note. The hundredth anniversary of that first general urban development plan for “New Ostia” was celebrated with a convention. The contributions have been collected in this number of the “Bollettino d’Arte”. Others, not present at the convention, have been added, such as an in-teresting and little known project for the “green” areas of the Ostia Antica excavations. There are two general introductions that go into the details of the urban development and the architecture of the town over its one hundred years. They provide a fundamental frame for the various papers, written by a variety of scholars from some of the most prestigious Italian academies. These sum up, in an original fashion, some of the better known topics, and investigate projects and historical phases that until now have been subject to little research
Sommario
Federica Galloni, Presentazione, p. VII
Micaela Antonucci, Luca Creti e Fabrizio Di Marco, Premessa, p. IX
Giovanni Carbonara, Introduzione, p. XI
Luca Creti, Architettura e urbanistica a Ostia Lido tra le due Guerre, p. 1
Micaela Antonucci, «Un riflesso argentato sulla sabbia»: Ostia e il litorale romano, nel secondo Novecento tra crisi e rinascite, p. 29
I – Da Roma Marittima a Ostia nuova
Maria Clara Ghia, Ostia: le ragioni di un insediamento, p. 47
Maria Grazia Turco, L’Associazione Artistica fra i Cultori di Architettura e i progetti per Ostia, p. 57
Francesca Romana Stabile, Ostia Nuova, il Piano Regolatore Generale del 1916 e i quartieri romani modellati sulla città–giardino, p. 71
Claudio Varagnoli, La chiesa della Regina Pacis a Ostia nei progetti di Giulio Magni, p. 81
Giovanni Duranti, L’eco dei rioni lungo il litorale di Ostia. Le Case Popolari di Camillo Palmerini, p. 95
II – Roma verso il mare
Gian Paolo Consoli, La ferrovia Roma–Lido e i progetti di Marcello Piacentini per le sue stazioni, p. 105
Marco Fasolo, La Colonia Marina Vittorio Emanuele III, p. 113
Rinaldo Capomolla, Rosalia Vittorini, Angiolo Mazzoni e la costruzione della Ricevitoria Postelegrafonica del Lido di Roma. Cronache di cantiere, p. 125
Rosalia Vittorini, Rinaldo Capomolla, Ostia moderna: la Casa del Balilla di Paolo Benadusi (1933–1935), p. 139
Fabrizio Di Marco, Ignazio Guidi e la Scuola Fratelli Eugenio e Giuseppe Garrone , p. 149
Luca Creti, Progetti e disegni di Adalberto Libera dagli archivi comunali, p. 165
III – Dal Dopoguerra al oggi
Micaela Antonucci, Il Lido di Roma come Cannes e Coney Island: i progetti per Castelfusano da Marcello Piacentini a Pier Luigi Nervi, p. 189
Stefania Mornati, I percorsi del recupero: gli stabilimenti balneari La Vecchia Pineta e il Kursaal , p. 207
Cesare Valle, Tommaso Valle, La “dimensione umana” dell’abitare in un prototipo di edilizia intensiva. Le residenze per dipendenti Alitalia a Ostia Lido (1965–1970), p. 219
Piero Ostilio, Rossi, «Densificare Demolire Riconfigurare». Roma tra il fiume, il bosco e il mare, p. 229
IV – Un sogno lasciato a metà: Il progetto di MIchele Busiri Vici per le sistemazioni arboree e per i giardini nella zona di Ostia Antica Scavi (1939–1941)
Massimo De Vico Fallani, Il progetto di Michele Busiri Vici per la sistemazione a verde degli scavi di Ostia nel quadro delle vicende del giardino italiano contemporaneo, p. 239
Marta Pileri, Guida alla lettura delle schede di analisi comparativa dei progetti di sistemazione a giardino di Michele Busiri Vici, p. 261
Carlo Pavolini, Alcuni contesti archeologici ostiensi fra il “grande scavo Calza”, il progetto del verde di Michele Busiri Vici e la situazione attuale, p. 285
Elizabeth Jane Shepherd, Prima di Busiri Vici: storia di tre giardini ostiensi e di un parco , p. 299
Indice dei nomi, a cura di Daniela Miano e Federica De Romanis, p. 315
Abstracts, p. 323
Contatti degli Autori, p. 332

Micaela Antonucci, Gabriele Neri
Pier Luigi Nervi in Africa
Evoluzione e dissoluzione dello Studio Nervi 1964-1980
Quodlibet, coll. Quodlibet Studio. Città e paesaggio. Saggi
https://www.quodlibet.it/libro/9788822906083
Nelle molte storie finora scritte su Pier Luigi Nervi, uno degli ingegneri e architetti più celebri del XX secolo, l’Africa è rimasta un contesto totalmente inesplorato. Eppure, tra il 1964 e il 1980 lo Studio Nervi – diretto insieme ai figli Antonio, Mario e Vittorio – sviluppa una fitta rete di contatti in questo continente, che portano al coinvolgimento del gruppo in quasi quaranta progetti. Vi sono edifici costruiti (tra i più significativi, il Good Hope Centre a Cape Town, la sede della Banque Africaine de Développement ad Abidjan e la cappella presidenziale di Yamoussoukro), ma anche tante iniziative che, seppur rimaste sulla carta, svelano un sorprendente mosaico di relazioni con i committenti più disparati, in Sudafrica, Costa d’Avorio, Libia, Congo, Nigeria, Repubblica Centrafricana, Tanzania e Algeria. Indice Ana Tostões, Introduzione. Nervi in Africa, la diaspora moderna Micaela Antonucci e Gabriele Neri, «Cerchi concentrici che si creano e si annullano dinamicamente». Lo Studio Nervi negli anni Settanta e la sua opera in Africa Micaela Antonucci, «A world record building». Il Good Hope Centre a Cape Town di Pier Luigi e Antonio Nervi (1964-1977) Gabriele Neri, Nervi in Costa d’Avorio: l’architecture italienne alla conquista della Françafrique (1970-1980) Ringraziamenti Progetti dello Studio Nervi in Africa 1964-1980 Bibliografia Indice dei nomi
Le vicende delle opere africane gettano inoltre luce sul sofferto passaggio dalla fase epica – ormai in fisiologico esaurimento – dello Studio Nervi a quella contrassegnata dall’autonomia manageriale ed espressiva dei figli, sullo sfondo di una profonda trasformazione della pratica professionale. Un passaggio che avrebbe potuto, forse, traghettare lo Studio verso nuovi orizzonti, ma che rimase un sentiero interrotto, per la prematura morte del primogenito Antonio nel 1979, sei mesi dopo il padre. Grazie a un’approfondita ricerca archivistica e a indagini sul campo, il presente volume può illustrare, per la prima volta in maniera organica, l’attività dello Studio Nervi in Africa, analizzandola attraverso diverse lenti storiografiche. Emerge così in controluce l’intreccio di rapporti professionali, politici, economici e culturali tra Italia e Africa, nel momento in cui si ridefinisce l’identità postcoloniale del grande continente. Come scrive Ana Tostões nell’introduzione, «oggi abbiamo la consapevolezza di dover includere l’Africa tra le geografie dei nostri sforzi per raggiungere una comprensione globale della “diaspora moderna”».
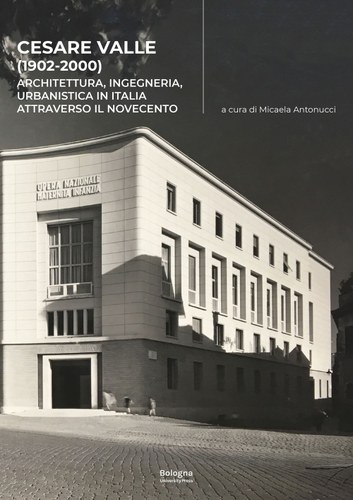
Cesare Valle (1902-2000)
Architettura, ingegneria, urbanistica in Italia attraverso il Novecento
a cura di Micaela Antonucci
2023, 208 pp.
https://buponline.com/prodotto/cesare-valle-1902-2000/
L’ingegnere-architetto-urbanista romano Cesare Valle (1902-2000) ha attraversato tutto il Novecento con la sua multiforme esperienza professionale, didattica e istituzionale. La sua lunghissima carriera si può dividere in due parti nettamente distinte, caso alquanto singolare nel panorama italiano contemporaneo, separate dalla Seconda guerra mondiale. Durante la sua “prima vita”, tra il 1926 e il 1941, l’esperienza professionale di Valle matura prima nell’ambiente romano per poi espandersi alla scena nazionale (in particolare in Romagna e in Sardegna) e internazionale (nelle “Terre d’Oltremare” conquistate dal regime fascista), collaborando con personaggi di primo piano come Marcello Piacentini, Gustavo Giovannoni, Giuseppe Pagano, Pier Luigi Nervi, Ignazio Guidi, Riccardo Morandi. Nell’Italia fascista, egli si afferma come uno dei pochi professionisti capaci di conciliare paradigmi e linguaggi diversi, muovendosi con eguale abilità in ambito architettonico, tecnico e urbano. Tra la fine del 1941 e l’inizio del 1942 si apre la “seconda vita” di Valle, in cui lavora come urbanista nel Ministero dei Lavori Pubblici. Nella sua doppia veste di accademico e di funzionario ministeriale, egli è stato uno dei protagonisti dell’opera di costruzione delle politiche urbanistiche pubbliche e di una nuova legislazione nazionale, collaborando anche con prestigiose istituzioni italiane e internazionali (Coni, Anas, Mec, Onu). Nell’ultimo decennio, numerose pubblicazioni, mostre e iniziative hanno acceso i riflettori su molte delle opere di Valle degli anni Trenta e Quaranta; mentre la sua attività nel dopoguerra, sia nell’ambito dei ruoli istituzionali che in quello delle ricerche sulla pianificazione e sulla legislazione urbanistica, è stata invece sinora quasi completamente trascurata. In questo volume si è voluto dunque ricomporre un racconto completo e unitario delle “vite” di Cesare Valle, raccogliendo gli esiti di nuove ricerche e dedicando spazio agli aspetti della sua opera sinora poco o per nulla approfonditi, in modo da ricostruire un ritratto a tutto tondo di questo personaggio che ha lasciato un segno indelebile nell’architettura e nell’urbanistica italiana.
Ulisse Tramonti, Presentazione. Cesare Valle o della “modernità contestuale” , p. 7
Micaela Antonucci, Introduzione. Cesare Valle “architetto integrale” , p. 11
1924-1941
Giuseppe Bonaccorso, L’allievo e il maestro: Cesare Valle e Gustavo Giovannoni, p. 19
Riccardo Renzi, Cesare Valle. Le Rovine ed il tema della Memoria , p. 33
Fabrizio Di Marco, Il sodalizio professionale tra Cesare Valle e Ignazio Guidi , p. 45
Simonetta Ciranna, Cesare Valle e l’ingegneria-architettura sanatoriale, p. 63
Antonella Sanna, Cesare Valle e la Sardegna: realizzazioni e progetti incompiuti, p. 75
Micaela Antonucci, «L’urbanistica è l’arte dei regimi d’autorità». Cesare Valle, gli studi sulle città coloniali e i progetti per l’Africa Orientale Italiana, p. 91
1942-2000
Luca Gullì, Cesare Valle e lo sviluppo dell’urbanistica statale nell’Italia del secondo dopoguerra, p. 109
Antonello Alici, Cesare Valle e lo studio dell’urbanistica dei Paesi Nordici, p. 125
Leila Signorelli, Il riuso dell’ex sede dell’Opera Nazionale per la protezione della Maternità ed Infanzia a Trastevere. Permanenza e trasformazione, p. 133
Cesare Valle jr, Matilde Bolla, L’eredità: lo Studio Valle, p. 149
Indice
Galleria fotografica, p. 159
Apparati a cura di Micaela Antonucci, Cesare Valle jr
Cesare Valle (Roma, 1902-2000). Profilo biografico, p. 179
Regesto dei progetti e delle opere di Cesare Valle, p. 185
Pubblicazioni di Cesare Valle, p. 195
Pubblicazioni su Cesare Valle e la sua opera, p. 197
Gli Autori, p. 203
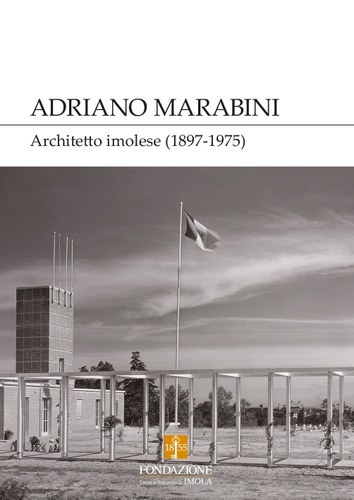
Adriano Marabini
Architetto imolese (1897-1975)
a cura di Micaela Antonucci e Luigi Bartolomei
Bononia University press, coll. I Quaderni di Tracce
2022, 216 pp.
https://buponline.com/prodotto/adriano-marabini/
Nonostante il suo significativo ruolo nell’architettura non solo imolese e bolognese, ma anche in una dimensione regionale ed extra-regionale, la figura dell’architetto imolese Adriano Marabini (1897-1975) è rimasta sino ad oggi in ombra nella storiografia e nelle ricerche. Nel 2018 il Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna e il Centro Studi Cherubino Ghirardacci hanno avviato, in collaborazione con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola, una ricerca sulla figura e sull’opera di Marabini volta ad esplorare le molte dimensioni della sua produzione e a mettere in luce il suo profilo biografico e professionale. Questo volume ricostruisce dunque per la prima volta a tutto tondo l’opera marabiniana, in un percorso che si dipana attraverso il Novecento lungo rotte locali e secondarie nell’architettura italiana, ma non per questo meno importanti: al contrario, rappresenta un prezioso contributo per comprendere i caratteri e le vicende di una professione che si muove tra le pieghe della società italiana e del mondo artistico e architettonico emiliano-romagnolo, legando insieme istanze locali e cambiamenti nazionali in una storia finora non raccontata.
Rodolfo Ortolani, Presentazione, p. 7
Micaela Antonucci, Luigi Bartolomei, Introduzione, p. 9
Saggi
Sofia Nannini, «Un tirocinio aspro e ininterrotto». Architettura e vita di Adriano Marabini, p. 15
Matteo Cassani Simonetti, Opere pubbliche e pratica professionale a Imola tra le due guerre, p. 37
Micaela Antonucci, «Un’impronta inconfondibile del tempo fascista nel cuore della città»: la Casa del Fascio di Imola, p. 59
Luigi Bartolomei, Lorenzo Fecchio , L’architettura religiosa nell’opera di Adriano Marabini, p. 83
Luca Gullì, Pier Giorgio Massaretti, Architettura e città. L’attività urbanistica di Adriano Marabini nel contesto emiliano del secondo dopoguerra, p. 101
Pasquale Fameli, Uno sguardo innocente. Adriano Marabini tra pittura e illustrazione, p. 119
Alessio Costarelli, Amleto Beghelli e Adriano Marabini: una postilla alla scultura architettonica d’età fascista, p. 135
Valter Balducci, Adriano Marabini e la costruzione della colonia elioterapica Andrea Tabanelli a Imola (1918-1945), p. 149
Maria Beatrice Betazzi, Modernità ed antimodernità nell’opera di Adriano Marabini, p. 169
Apparati
Regesto delle opere e dei progetti di Adriano Marabini, a cura di Sofia Nannini, p. 185
Bibliografa generale, p. 189
Indice dei nomi di persone, istituzioni e movimenti artistici, p. 197
Indice dei luoghi, p. 205
Profli degli autori, p. 209
Crediti fotografici, p. 212
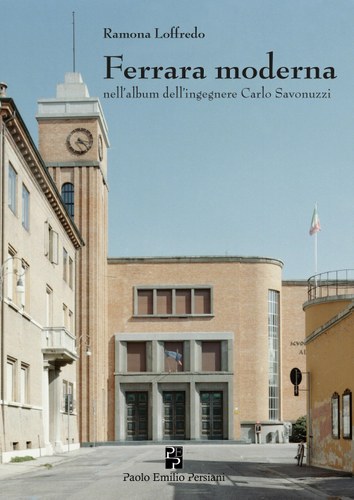
Ramona Loffredo
Ferrara moderna nell’Album dell’ingegnere Carlo Savonuzzi
Casa editrice Persiani
2018, 240 pp.
https://www.persianieditore.com/book/ferrara-moderna-nellalbum-dellingegnere-carlo-savonuzzi/
Questo libro ripercorre, seguendo il fil rouge che lega una raccolta di circa un centinaio di scatti fotografici in bianco e nero, parte della storia professionale dell’ingegnere Carlo Savonuzzi. Le vicende del progettista, dei committenti, degli edifici si intrecciano, si sovrappongono fino a delineare prima e a svelare poi il volto novecentesco di Ferrara. L’ingegnere e la sua città sono al centro del racconto che si sviluppa attorno a questo straordinario album, preziosa e insostituibile autobiografia per immagini. Le quasi 100 fotografie in bianco e nero dell’album di Carlo Savonuzzi testimoniano momenti salienti dell’architettura del ‘900 ferrarese e diventano l’occasione per restituire, arricchita di nuovi e inediti approfondimenti, la storia dell’ingegnere che ha avuto un ruolo fondamentale nel disegno del volto di Ferrara moderna. Oltre alle principali opere pubbliche, fra cui spiccano la scuola Alda Costa e il serbatoio monumentale dell’Acquedotto comunale, ampio spazio è dato a opere meno note o addirittura sconosciute ascrivibili all’attività di ingegnere comunale e a quella di libero professionista.
Le storie dei singoli edifici si intrecciano con quella del loro progettista offrendo uno spaccato significativo della cultura architettonica novecentesca ferrarese.
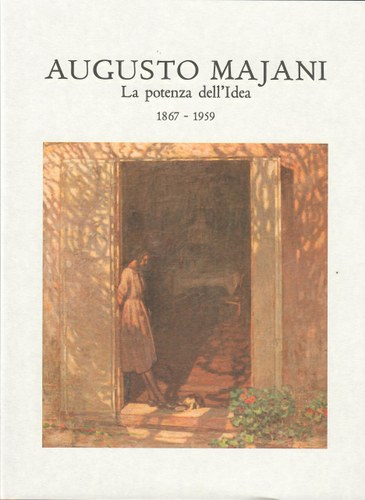
Augusto Majani
La potenza dell’Idea | 1867-1959
Associazione Bologna per le Arti
Casa editrice Persiani
2021, 186 pp.
https://www.persianieditore.com/book/augusto-majani/
“AUGUSTO MAJANI (1867-1959). LA POTENZA DELL’IDEA”
Palazzo d’Accursio, Bologna
4 dicembre 2021 – 30 gennaio 2022
In occasione della mostra “Augusto Majani (1867-1959). La potenza dell’Idea” viene pubblicato il relativo Catalogo: un volume in formato A4, rilegato con copertina rigida e sovraccoperta, di oltre 180 pagine, con 90 illustrazioni a colori e testi di Francesca Sinigaglia, Ilaria Chia, Ramona Loffredo, Elisa Spilinga. L’opera (a cura di Francesca Sinigaglia) si propone di aggiornare e indagare la produzione pittorica dell’artista attraverso dipinti caratterizzanti il suo intero periodo di attività. Augusto Majani nacque a Budrio nel 1867, scelse Bologna per la propria formazione per poi approdare anche a Roma, avviando così una carriera poliedrica che attraversò momenti legati al simbolismo e proseguì verso un interessamento per il dato umano, la storia locale e la semplicità legata a scene di vita quotidiana. Majani lavorò su dipinti di ispirazione storico-sociale e sviluppò un vivo interesse legato alle questioni dei lavoratori (I disoccupati), al concetto di appartenenza sociale e infine al tema religioso (Consummatum est e L’ombra della Croce).
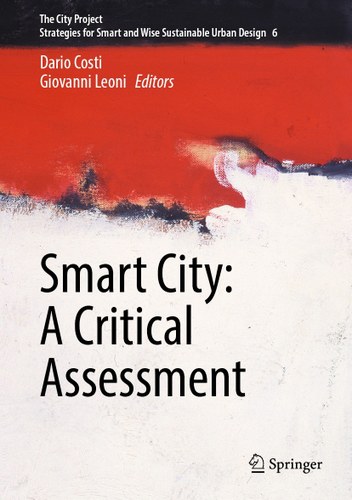
Smart City
A Critical Assessment
eds. Dario Costi and Giovanni Leoni
Springer, series "The City Project: Strategies for Smart and Wise Sustainable Urban Design"
2024, 117 pp.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-51288-9
This contributed volume reports on a multidisciplinary collective work on the topic of Smart City, merging scientific reflections and operational issues. Here, current Smart Cities concepts are subjected to criticism, while the related terminology has been updated to contemplate a model of urban development capable of integrating technical and humanistic culture by fostering an open dialogue between different stakeholders. Upon an introduction to the state of the art, this book presents a glossary of definitions and concepts around the contemporary city, and five interviews with researchers and scholars of different background. The last chapter summarizes current challenges in designing the city of the future, highlighting new research directions in home-infrastructure, small smart city, energy transition, connectivity, digitalization and autonomous and connected mobility.
Written by the members of the Scientific Committee of the Smart City 4.0 Sustainable LAB ResearchLaboratory, an inter-university network including research groups from the University of Parma, University of Modena and Reggio Emilia, University of Bologna, University of Ferrara, the Polytechnic University of Milan, and the Catholic University of Milan with its Piacenza campus, this book offers a source of inspiration for other researchers and stakeholders, and it is intended to foster collaborations between different stakeholders - and possibly countries – to develop future cities that are wise, green, sustainable and inclusive.
Table of contents
Dario Costi, Smart City Myth and Challenge. An Open Laboratory to Promote a Debate Based on Six Key Concepts, pp. 1-10
Federico Diodato, Andrea Fanfoni, Emanuele Ortolan, Glossary of Contemporary City Terms. A Critical Selection of Definitions in the Literature Towards the City of People 4.0, pp. 11-35.
Dario Costi, Federico Diodato, Andrea Fanfoni, Emanuele Ortolan, Smart City or Wise Town? Conversations on the City of the Fourth Industrial Revolution, pp. 37-76.
Giovanni Leoni, Andrea Borsari, Guya Bertelli, Michele Roda, Dario Costi, Gabriele Lelli et al., Research Finding and Directions Identified by the Smart City 4.0 Sustainable LAB, pp. 77-102.
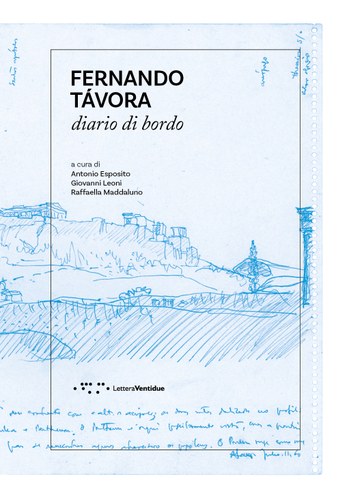
Fernando Távora
Diario di bordo
a cura di Antonio Esposito, Giovanni Leoni, Raffaella Maddaluno
letteraVentidue
2022, 512 pp.
https://letteraventidue.com/it/prodotto/622/fernando-tvora
Nel 1960 Fernando Távora parte per un viaggio attorno al mondo che dura quattro mesi. Ha 36 anni ed è assistente di ruolo presso la Scuola di Architettura di Porto. Scopo ufficiale del viaggio è una visita ai principali Dipartimenti statunitensi sulle tracce dell’“insegnamento moderno” dell’architettura e dell’urbanistica. Tiene un dettagliatissimo diario dell’intero viaggio – rimasto inedito per oltre cinquant’anni – in cui annota soprattutto le impressioni che riceve dal contatto diretto con civiltà e costumi di cui arrivavano in Portogallo solo i riflessi. Molti sono gli incontri, di persona o attraverso le opere, programmati o casuali: Wright, Mies, Gropius, Kahn, Sert, Saarinen, Rudolph, Lynch e, naturalmente, l’America – le grandi città, i musei, i modelli di vita – che Távora sottopone a una costante, ironica e sottile critica. Critica che si arricchisce, per contrappunto, nel racconto dell’altro paese visitato per ragioni istituzionali, il Giappone, ma che diviene spietata, per confronto, nella trasgressiva “fuga” in Messico. Il viaggio si chiude con due visite che si riveleranno decisive nella sua formazione, anche progettuale:
le piramidi egizie e l’Acropoli di Atene.
Questa edizione in italiano è basata su una lettura commentata del Diario che i curatori hanno raccolto da Fernando Távora nei primi anni Duemila e ne riproduce tutti i disegni, gli schizzi tracciati tra le pagine manoscritte e nei due quaderni da disegno che lo accompagnano.
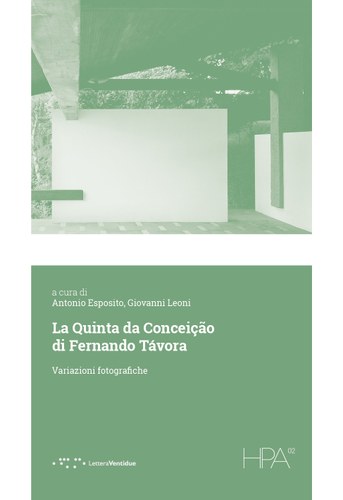
La Quinta da Conceição di Fernando Távora
Variazioni fotografiche
a cura di Antonio Esposito, Giovanni Leoni
letteraVentidue, collana HPA
2024, 128 pp.
https://letteraventidue.com/it/prodotto/785/la-quinta-da-conceio-di-fernando-tvora
Nel 1956 la Municipalità di Matosinhos incarica Fernando Távora di realizzare un parco pubblico in un’area residua dei lavori di ampliamento del porto, in cui sorgevano due ville rurali con le relative tenute. Nel momento in cui Távora interviene sul terreno vi sono solamente i resti del chiostro di un convento quattrocentesco mai completato, alcune fontane monumentali e una cappella. Távora decide di non affrontare l’immagine perduta del convento, di cui non propone una restituzione, ma di indagare il “rituale spaziale” dell’esistente e tale indagine, che di fatto genera il progetto, avviene camminando, attraversando ripetutamente, “viaggiando” all’interno del luogo.
La Quinta da Conceição è dunque un progetto fondativo del metodo progettuale tavoriano che ne rivela gli aspetti più sottili, legati alla esperienza dei luoghi piuttosto che alla loro rappresentazione.
Il volume propone un esercizio di lettura affidato allo sguardo fotografico di diversi autori – Roberto Collovà, Alessandra Chemollo, Ivana Barbarito, Sebastiano Raimondo – in diversi tempi. La diversità degli sguardi su un’opera al tempo stesso sfuggente ed esemplare offre occasione per una riflessione, anche di carattere generale, riguardo a temi quali il rapporto tra l’architettura e le sue rappresentazioni, gli aspetti performativi del progetto, la conoscenza della dimensione.
con un testo di Álvaro Siza
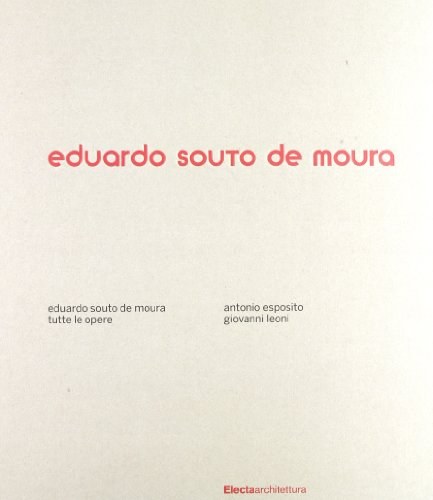
Antonio Esposito, Giovanni Leoni
Eduardo Souto De Moura. Tutte le opere
fotografie di Alessandra Chemollo, Fulvio Orsenigo
Electa, Electaarchitettura
2003, 20122, 552 pp.
https://www.electa.it/prodotto/eduardo-souto-de-moura/
L'edizione ampliata e aggiornata della monografia edita nel 2003 sull'opera del maestro portoghese. Ogni capitolo è introdotto da scritti dell'architetto portoghese, atti ad illustrarne i contenuti. Il libro si apre con la trascrizione di una conversazione tra Souto de Mura, Álvaro Siza e Fernando Tavora, i primi due allievi del secondo, tutti e tre legati da un sodalizio unico all’origine di esperienze progettuali nutrite da un medesimo sostrato culturale, ma dagli esiti diversi. Seguono i saggi di Leoni ed Esposito e i progetti e le costruzioni, ordinati in differenti capitoli tematici.
Ogni capitolo è introdotto da scritti dell’architetto portoghese, atti ad illustrarne i contenuti. Questi testi, supportati dai contributi storico-critici, consentono di apprezzare le motivazioni poetiche e ideologiche sottese al lavoro svolto dal protagonista di questo volume.
Un ultimo capitolo raccoglie le opere realizzate dall’architetto dal 2003, anno di uscita della prima edizione del volume a oggi; tra le opere di spicco le due case unifamiliari a Ponte de Lima, la torre per uffici Burgo a Boavista, il Centro d’arte contemporanea a Bragança, la Casa del Cinema Manoel de Oliveira a Porto, lo stadio municipale di Braga, le nuove stazioni della metropolitana di Porto, il museo Paula Rego a Cascais, il crematorio di Kortrijk in Belgio.
Il volume è corredato da un regesto completo, dalla biografia e dalla bibliografia e illustrato dale fotografie appositamente realizzate da alessandra Chemollo e Fulvio Orsenigo.
Il libro illustra ogni risvolto della personalità di un protagonista dell’architettura contemporanea e offre notevoli spunti per capire le ragioni del successo che la cultura progettuale portoghese si è conquistata negli ultimi anni.
L’edizione ampliata e aggiornata della monografia edita nel 2003 da electaarchitettura sull’opera del maestro portoghese.
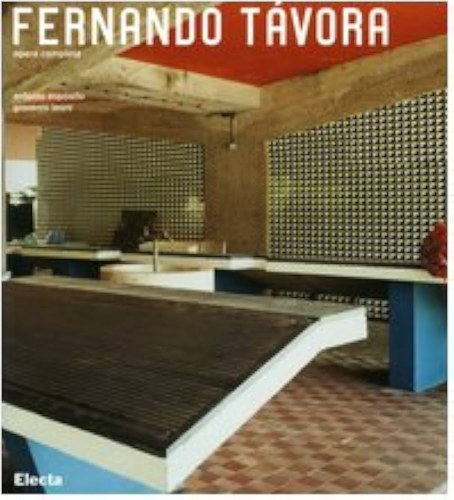
Antonio Esposito e Giovanni Leoni
Fernando Távora
Opera completa
fotografie di Alessandra Chemollo e Fulvio Orsenigo
Electa, Electaarchitettura
2005, 400 pp.
https://www.electa.it/prodotto/fernando-tavora/
Dopo i volumi sull'opera degli architetti portoghesi Alvaro Siza e Eduardo Souto de Moura la prima monografia dedicata al loro maestro: Fernando Távora.
Il volume documenta la complessità dell’opera architettonica di Távora dagli anni cinquanta a oggi mediante un percorso che incrocia i luoghi e le città oggetto del suo lavoro: Porto, Aveiro, Guimaraes, Viana do Castelo, Coimbra, Lisbona.
Una nutrita antologia della critica, oltre a numerosi suoi scritti inediti, delineano la figura di Távora, che fu protagonista dello scontro tra tradizione e tendenza innovativa nel dibattito che attraversa lo sviluppo dell’architettura europea a partire dalla metà del Novecento.
L’apparato iconografico del volume è arricchito dalle fotografie di Alessandra Chemollo e Fulvio Orsenigo realizzate appositamente per la monografia.
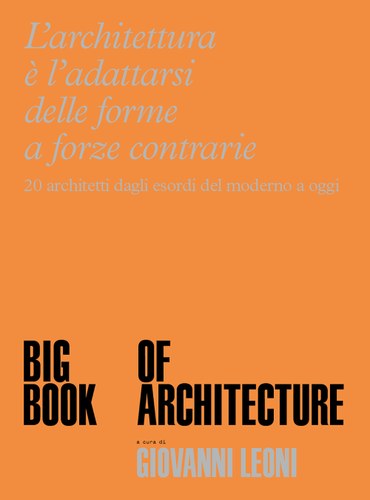
BIG BOOK OF ARCHITECTURE
L'architettura è l'adattarsi delle forme a forze contrarie
20 architetti dagli esordi del moderno a oggi
24 ORE Culture, 384 pp.
https://www.24orecultura.com/libri/catalogo/big-book-of-architecture/
L’architettura è l’adattarsi delle forme a forze contrarie
Riprendendo la struttura e il concept del fortunato BBD di Andrea Branzi dedicato al design, un’essenziale storia dell’architettura del ‘900 e di inizio millennio attraverso 20 grandi autori, sistemati in 4 macrosezioni: i maestri del Movimento Moderno (Le Corbusier, Wright, van der Rohe, Gropius e Aalto), i grandi interpreti del suo superamento (Kahn, Tange, Tavora, Coderch e Aldo Rossi), la rilettura dei compiti dell’architettura da parte dei professionisti colti (Foster, Piano, Gregotti, Ando e Moneo), i protagonisti della generazione nata dopo la guerra (Koolhaas, Hadid, Souto de Moura, Kuma e Chipperfield).
Quattro controstorie ricostruiscono la complessa dialettica storica di ogni periodo, attraverso il racconto dell’apporto decisivo di figure e movimenti non inclusi nelle sintesi monografiche.
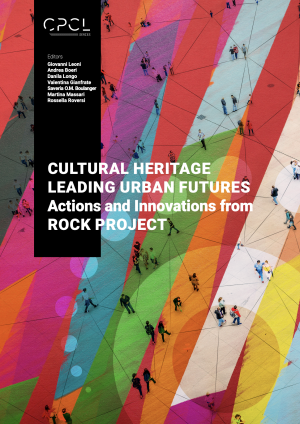
Cultural Heritage Leading Urban Futures: Actions and Innovations from ROCK Project
eds. Giovanni Leoni, Andrea Boeri, Danila Longo, Valentina Gianfrate, Martina Massari, Saveria Olga Murielle Boulanger, Rossella Roversi
TU Delft, CPCL series
2020, 248 pp.
DOI: https://doi.org/10.7480/ISBN.9789463664172
https://books.bk.tudelft.nl/press/catalog/book/787
The ROCK project sees historic city centres as laboratories to demonstrate how Cultural Heritage can be an engine of regeneration, sustainable development and economic growth. ROCK approach foresees the systemic and flexible application of a series of role-model practices in the testing sites of three Replicator cities, to turn historic city centres afflicted by physical decay, social conflicts and poor life quality into Creative and Sustainable Districts. This book provides an overview of the project, extracting themes, material and final remarks from the Open Knowledge Week “Cultural Heritage Leading Urban Futures”, held on 27-30 October 2020. Over the past three years, ten ROCK cities — Athens, Bologna, Cluj-Napoca, Eindhoven, Lisbon, Liverpool, Lyon, Skopje, Turin, and Vilnius — together with service providers and knowledge brokers have tested and advanced numerous soft and hard tools, collaborative approaches aimed at shaping sustainable, heritage-led urban futures. This book shows their shared results, best practices and lessons learnt from interdisciplinary research, innovative action, dissemination of knowledge and creation of new synergies at European level.
Table of content
INTRODUCTION
Andrea Boeri, Saveria Olga Murielle Boulanger, Valentina Gianfrate, Giovanni Leoni, Danila Longo, Martina Massari, Rossella Roversi, p. 9
ROCK PROJECT
Francesca Bruni, Osvaldo Panaro, Presentation of the Project, p. 15
Silvia Bartoloni, Pamela Lama, Giuliana Mazzocca, A Great Team-Play for a Great Challenge: the ROCK Project from the Management Perspective, p. 19
Giovanni Leoni, Cultural Heritage as a Common, p. 23
ACTING IN THE CITIES
Andrea Borsari, Potential City and Concrete Utopia. Figures of Thought for an Action Research, p. 29
Vando Bortghi, Culture in the City. Infrastructures and Concrete Utopias, in Six Steps, p. 35
Danila Longo, Andrea Boeri, Contribution of Co-Creation in Urban Regeneration Processes, p. 41
Valentina Orioli, Martina Massari, Rossella Roversi, A Pathway from Research-Action-Research to Integrated Management Plan, p. 51
Cécile Houpert, Miruna Draghia, Martina Massari, Introduction to Cities from Role-Replicator Exchange to Mutual Learning, p. 60
AA.VV., A Shared Framework for ROCK Cities, p. 73
Valentina Gianfrate, Jacopo Gaspari, Giovanni Ginocchini, Accessibility to Cultural Heritage: ROCK Design Approach, p. 77
Roberto Falanga, Alessandra Bonoli, Sustainability and Cultural Heritage, p. 82
Saveria O.M. Boulanger, Raffaella Gueze, Rossella Roversi, Alessandra Vaccari, Collaborations and Cultural Heritage, p. 91
Miruna Draghia, Cecile Houpert (eds.), A Catalogue of ROCK Cities Actions, p. 98
FUELLING THE FUTURE OF CITIES' INNOVATION
Iwona Maciejewska, Alexandru Roja, ROCK Innovation: a Brief Overview, p. 154
AA.VV., ROCK Innovation Portfolio, p. 158
Antonella Fresa, Fast-Forward to the Future. ROCK Innovations in Perspective, p. 216
Ernesto Antonini, Saveria O.M. Boulanger, Jacopo Gaspari, Technologies in the Research-Action-Research Perspective, p. 221
Cristina Garzillo, Stephania Xydia, Ane Izulain Alejos, Shifting from a Physical Event to a Virtual Conference: the ROCK Open Knowledge Week, p. 225
CONCLUSIONS
Cristina Garzillo, Cristina Sabbioni, The Role of Cultural Heritage in Urban Sustainability, p. 237
BIOGRAPHIES, p. 240
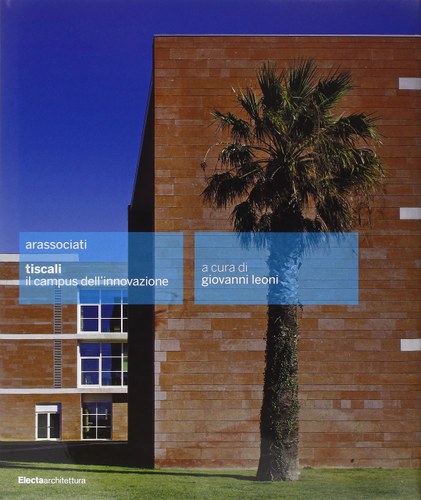
Tiscali
Il campus dell'innovazione
a cura di Giovanni Leoni
Electarchitettura, coll. Storie di impresa
2008, 104 pp.
https://www.electa.it/prodotto/tiscali/
Un campus tecnologico a servizio della comunità e della sua economia costruito con attenzione all'ambiente, ai materiali e alle maestranze locali. Schizzi, disegni, fotografie di cantiere e dell'opera finita documentano il progetto architettonico della sede chiamata a rappresentare l'impresa Tiscali.
Il volume documenta tutte le fasi di progettazione e realizzazione del Campus Tiscali a Cagliari.
Il complesso è costituito da cinque importanti corpi di fabbrica in forte relazione con l’ambiente naturale nel quale sorgono. I progettisti si sono formati a partire dal 1982 nello Studio di Architettura di Aldo Rossi, e sono diventati nel corso degli anni i suoi più stretti collaboratori. Costituito nel 1997, lo studio Arassociati ha progettato e realizzato numerosi edifici in Italia e all’estero. Incaricati della progettazione esecutiva e della direzione artistica nella ricostruzione del Teatro La Fenice a Venezia, hanno ricevuto il Premio Internazionale di Architettura Teatrale. Tra i progetti più significativi: il nuovo palazzo dello Sport nell’area ex Philips a Leuven, Belgio (1998-2005); il progetto per la nuova sede del DAMS a Bologna; la ristrutturazione e l’ampliamento del Teatro Nazionale Popolare di Villeurbanne a Lione
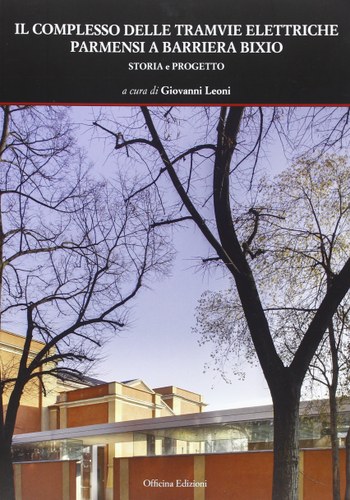
Il complesso delle tramvie elettriche parmensi a barriera Bixio
Storia e progetto
a cura di Giovanni Leoni
Officina, coll. Architettura e arti
2012, 156 pp.
ISBN 978-88-6049-099-5
Il libro coglie l'occasione del progetto di "Piazza delle scuole," realizzato a Parma all'interno del complesso delle Tramvie elettriche di Barriera Bixio, per aprire un dialogo sul rapporto tra storia e progetto d'architettura articolato in due fasi. La prima racconta il confronto attivato sul campo in occasione dell'intervento dello studio di architettura MC2, mentre la seconda svolge un'azione critica a posteriori dai due punti di vista, con interessi scientifici e sensibilità differenti. A partire da un'esperienza specifica, i contributi raccolti, nella loro diversa impostazione e finalità, assumono, così, il significato di una riflessione metodologica a più voci sul ruolo e l'atteggiamento progettuale dell'architettura contemporanea nel rapporto con i centri storici e con la città del Novecento.

Architettura e impegno sociale
Emilia-Romagna 2000 | 2020
a cura di Giovanni Leoni
letteraVentidue, coll. BIANCO
2021, 169 pp.
https://letteraventidue.com/it/prodotto/498/architettura-e-impegno-sociale
“Il tema più urgente e complesso è ritrovare per l’architettura un ruolo specifico e una specifica efficacia nel campo esteso del progetto ovvero in quello che viene a definirsi nel momento in cui si incentra l’azione progettuale non tanto sulla ricerca formale e linguistica quanto sulla specifica complessità dei luoghi. Per l’architettura non si tratta semplicemente di ritrovare o intensificare una attenzione per il programma, per le ragioni della committenza intesa come l’ampia comunità su cui l’opera impatta, oppure di sviluppare una maggiore sensibilità per i temi che assediano l’Antropocene. Si tratta di modificare radicalmente il modello di creatività della architettura abbandonando la sua doppia matrice moderna, da un lato la matrice artistica che ritiene in sé salvifica la bellezza formale, dall’altro la matrice tecnologica che pretende per la disciplina del progetto uno statuto di scientificità che non le è proprio. In parole più semplici, un ritorno alla essenza politica della architettura”.
Indice
Tommaso Manfredi, Quale architettura? L'essenza di una domanda nell'Italia di oggi, p. 6
Giovanni Leoni, Un campo esteso per il progetto d'architettura, p. 11
Massimo Ferrari, Piacenza: Architetture per la cultura, p. 22
Dario Costi, Parma: Memoria progettuale di crisi, p. 40
Andrea Zamboni, Reggio Emilia: Riscrivere la città, p. 60
Matteo Agnoletto, Modena: Progetti di pianura, p. 78
Annalisa Trentin, Bologna: Riuso e città, p. 96
Gabriele Lelli, Ferrara: Architettura e benessere ambientale, p. 114
Andrea Luccaroni, Imola | Faenza | Ravenna: Il luogo comune, p. 132
Giorgio Liverani, Michele Vasumini, Forlì | Cesena | Rimini: Lo spazio condiviso: il fermento dei margini romagnoli, p. 150