“Why we can’t wait”: Martin Luther King Jr. e l’urgenza della disobbedienza civile
Federica Fontanesi
Dedicato alle vittime di discriminazione razziale
Certe ricorrenze hanno la capacità di catalizzare intorno a esse ideali, speranze e conquiste che vanno ben al di là degli specifici avvenimenti che le hanno contraddistinte. Quella che in un primo momento può sembrare solo una fredda data in un libro di storia, si presenta in realtà come un evento emblematico all’interno dell’immaginario collettivo, specialmente per tutte quelle comunità la cui identità si fonda, almeno in parte, sulla lotta per il diritto a una libertà troppo a lungo negata.
Questo è il caso del Juneteenth, il 19 giugno, un anniversario molto importante per la comunità afroamericana, nonché simbolo di una lotta culturale contro la discriminazione e contro ogni forma di oppressione.
1. Freedom Day
2. Free at Last?
3. On the Duty of Civil Disobedience
4. The Negro Can’t Wait
5. Bibliografia
6. Sitografia
1. Freedom Day
Il 19 giugno del 1865 il generale Gordon Granger si trovava a Galveston, in Texas, nel quartier generale dell’esercito assieme alle truppe dell’Unione. Erano già passati più di due mesi dall’assassinio del presidente Abraham Lincoln e dalla fine della guerra civile, e ancora più tempo era trascorso dall’approvazione del tredicesimo emendamento alla Costituzione, ma di quest’ultimo erano ancora assai pochi i cittadini americani a conoscerne il contenuto.
Affacciandosi dal balcone di Ashton Villa, il generale Granger lesse a gran voce le ordinanze del giorno. Tra queste, il General Order No. 3 informava tutti i cittadini del Texas che, in conformità con il Proclama di emancipazione promulgato dall’esecutivo degli Stati Uniti più di due anni prima, «all slaves are free» e che il legame dapprima esistente tra padrone e schiavo era, da quel momento, da considerarsi come un rapporto tra datore di lavoro e lavoratore assunto (Gates, 2013).

Le parole pronunciate quel 19 giugno dal generale Granger hanno acquistato nel tempo più importanza di quanta realmente ne avessero al momento della loro enunciazione. Di fatto, il gesto da lui compiuto aveva primariamente l’obiettivo di sancire la sconfitta degli Stati Confederati e il prevalere dell’Unione sull’ultimo stato secessionista, il Texas.
In questo panorama bellico, l’abolizione della schiavitù non era stata altro che un pretesto per coinvolgere più combattenti tra le schiere dell’Unione. Scrive Howard Zinn:
Il governo americano aveva intrapreso nel 1861 la guerra contro gli stati schiavisti non per porre fine alla schiavitù, bensì per conservare un territorio nazionale, mercato e risorse. Per vincere, tuttavia, c’era bisogno di una crociata, il cui slancio portò forze nuove alla ribalta della vita politica nazionale: neri decisi a dare un significato alla loro libertà e bianchi che avevano a cuore l’uguaglianza razziale; funzionari dell’Ufficio schiavi affrancati, insegnanti delle Sea Islands, piccoli politicanti in cerca di fortuna caratterizzati da una miscela variabile di preoccupazioni umanitarie e ambizioni personali. (Zinn 2005, 139)
Inoltre, a dire il vero quel 19 giugno non fu affatto il giorno in cui gli afroamericani furono liberati, ma piuttosto quello in cui gli fu detto che erano liberi, sebbene su questo punto le opinioni siano contrastanti.
Varie testimonianze documentano che molti dei proprietari di piantagioni temporeggiarono per mesi prima di comunicare ai propri schiavi che non erano più tali, alcuni aspettarono addirittura fin dopo la mietitura (Gates 2013). Ciò nonostante, l’apparente riconquista di una libertà perduta spinse comunque la comunità afroamericana a consacrare questa data come il giorno dell’emancipazione degli schiavi d’America, un quattro luglio «nero», che dal 1866 in poi sarebbe stato celebrato con il nome di Juneteenth, una parola macedonia nata dalla fusione dei due termini June e nineteenth.
Tuttavia, nella seconda metà dell’Ottocento la comunità afroamericana era ancora molto lontana dall’ottenere un vero e proprio riconoscimento dei suoi diritti.
Nonostante fossero state approvate delle leggi per stabilire «l’uguaglianza tra bianchi e neri», queste persero ben presto di significato e così le politiche di ricostruzione vennero vanificate, mentre con il mutare dell’equilibro militare tra l’Unione e gli ex-Stati Confederati, «l’oligarchia bianca del Sud si servì del proprio potere economico per organizzare il Ku Klux Klan e altri gruppi terroristici. […] Era solo questione di tempo prima che i neri fossero riportati a una condizione non troppo dissimile dalla schiavitù» (Zinn 2005, 144).
2. Free at Last?
La fine della Guerra di Secessione non portò in realtà a quel cambiamento tanto agognato, al contrario, come sostiene lo storico e sociologo W. E. B. Du Bois nel suo celebre libro Black Reconstruction (1935), «nel 1876 in America cominciò l’ascesa di un nuovo capitalismo e di una nuova schiavitù dei lavoratori», che riguardava non soltanto i neri, ma tutte le classi sociali più povere a prescindere dall’etnia.
Il fallimento delle politiche di ricostruzione si tradusse rapidamente in una nuova forma di discriminazione nei confronti della comunità afroamericana, con un crescendo di violenza bianca che influenzò la condotta del governo (in particolare sotto la presidenza di Grant) e della Corte suprema che, arroccatasi su posizioni conservatrici, pian piano «cominciò a interpretare il Quattordicesimo emendamento, approvato in nome dell’uguaglianza razziale, in modo tale da renderlo inadeguato a garantirla» (Zinn 2005, 145).
A partire dalla fine degli anni Settanta dell’Ottocento, le leggi Jim Crow regolamentarono la segregazione razziale, rendendo a tutti gli effetti possibile la separazione fisica tra white e colored people in zone distinte negli spazi pubblici, tra cui treni, sale d’aspetto, ristoranti e tanti altri luoghi (Encyclopædia Britannica 2019).
Come venne poi confermato dalla sentenza Brown v. Board of Education negli anni Cinquanta del Novecento, la dottrina del «separati ma uguali» non faceva altro che generare tra gli afroamericani un senso di inferiorità, oltre che un sentimento di ingiustizia, che si sarebbe progressivamente trasformato in una inconscia amarezza e in un profondo risentimento nei confronti della popolazione bianca.

Ancora una volta la comunità nera era da considerarsi tutt’altro che libera e il peso della discriminazione condannava queste persone a vivere in una condizione forzata di totale miseria. Durante tutta la prima metà del Novecento circa sei milioni di afroamericani si spostarono dagli stati rurali del Sud verso le città del Nord e del Midwest nella speranza di ritrovare, assieme alla libertà perduta, anche aspettative di vita migliori.
È interessante sottolineare come questo fenomeno, che venne successivamente definito con il nome di Grande migrazione afroamericana, facilitò la nascita di nuove forme di espressione culturale e artistica nelle aree urbane che andavano riempiendosi di abitanti neri proprio in quegli anni. In particolare New York, tra la fine della Prima Guerra Mondiale e gli anni Trenta, divenne il fulcro di un movimento rivoluzionario che avrebbe inciso profondamente anche sul mondo della musica e della letteratura statunitense e che prese il nome di Harlem Renaissance , dal nome del ghetto nero di questa città.
In una società che si regge su sistemi di controllo complessi – alcuni brutali, altri sofisticati – spesso i pensieri segreti si esprimono attraverso l’arte, e così avveniva nel mondo dei neri. Forse il blues, per quanto toccante, nascondeva la rabbia, e il jazz, per quanto gioioso, preannunciava la ribellione. (Zinn 2005, 308)
Alla base di questa vivace e coinvolgente esperienza culturale e artistica c’era soprattutto la volontà da parte della comunità afroamericana di ridefinire la propria identità etnica, esaltare la dignità e la creatività nera non solo come espressione della propria storia di afroamericani, ma anche come parte integrante del più vasto panorama culturale americano.
La scoperta di una «nuova identità nera» condusse sempre più persone verso la presa di coscienza della condizione di subordinazione del popolo afroamericano e servì anche al Movimento per i diritti civili come principio fondante per la comunità che avrebbero poi costruito a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta.
In questo più recente contesto d’oppressione, la comunità nera sembrò finalmente ritrovare uno spiraglio di luce, ma era ancora ben lontana dal guadagnare l’autonomia a cui aspirava. «Che cosa succede a un sogno differito?» si chiedeva Langston Hughes nella poesia intitolata “Harlem” della sua celebre raccolta Montage of a Dream Deferred (1951), che cosa succede al sogno di libertà degli afroamericani? «Avvizzisce, oppure esplode?» (Zinn 2005, 325).
What happens to a dream deferred?
Does it dry up
like a raisin in the sun? Or fester like a sore-- And then run? Does it stink
like rotten meat? Or crust and sugar over--like a syrupy sweet?
Maybe it just sags
like a heavy load.
Or does it explode?
(Hughes 1990, 268)
3. On the Duty of Civil Disobedience
All’epoca, «la memoria profonda della schiavitù» era costantemente ravvivata dall’esperienza quotidiana dell’umiliazione e dell’ingiustizia e «per gente che aveva ricordi del genere […] la rivolta era sempre imminente, come un congegno a orologeria nel quale nessuno aveva fissato l’ora, ma che poteva essere messo in moto da una sequenza imprevedibile di eventi» (Zinn 2005, 313).
A cosa pensava Rosa Parks quando nel 1955 venne arrestata dopo essersi rifiutata di cedere il suo posto sull’autobus a un bianco? Forse non si aspettava che il suo atto di disobbedienza avrebbe scatenato un movimento di protesta popolare, o forse sì. In uno dei suoi scritti, la sarta di Montgomery, in Alabama, ricorda come accolse con rassegnazione la sua incarcerazione:
I had been pushed around all my life and felt at this moment that I couldn’t take it anymore. When I asked the policeman why we had to be pushed around? He said he didn’t know. “The law is the law. You are under arrest.” I didn’t resist. (Library of Congress n. d.)
Ma questo gesto segnava soltanto l’inizio di una serie di azioni che avrebbero portato la questione dei diritti degli afroamericani al centro del dibattito pubblico negli Stati Uniti d’America. Nei mesi successivi all’arresto di Rosa Parks, i neri di Montgomery si organizzarono in un sistematico boicottaggio dei mezzi pubblici a cui partecipò anche un giovane pastore della chiesa battista di Dexter Avenue originario di Atlanta, il cui nome era Martin Luther King Jr.
Grazie all’aiuto dei Freedom Riders e dei tassisti, che avevano adeguato le loro tariffe a quelle degli autobus, a Montgomery il boicottaggio durò circa un anno, finché «nel novembre 1956 la Corte suprema dichiarò illegale la segregazione nei trasporti urbani» (Zinn 2005, 315).
L’efficacia di questa protesta convinse alcuni tra gli attivisti del Movimento per i diritti civili che la resistenza non violenta fosse la strada da percorrere nella lotta contro la segregazione razziale e per la libertà. Il pastore battista Martin Luther King Jr. abbracciò questa filosofia della non violenza, facendosi portavoce delle istanze di un popolo nelle manifestazioni pacifiche che negli anni seguenti si diffusero in tutti gli stati del Sud.

L’esperienza di Montgomery era stata fondamentale nel definire il suo pensiero sulla non violenza. In un articolo che apparve sul settimanale «Christian Century», il 13 aprile 1960, con il titolo Pellegrinaggio verso la non violenza, King esortò gli afroamericani a usare «l’arma dell’amore» rimarcando l’importanza che aveva rivestito la disobbedienza civile durante le proteste in Alabama.
Non voglio dare l’impressione di credere che la non violenza faccia miracoli dall’oggi al domani. Non è facile far uscire gli uomini dalle loro consuetudini mentali, oppure liberarli dai loro pregiudizi o sentimenti irrazionali. […] L’approccio non violento non muta immediatamente il cuore dell’oppressore. Per prima cosa, opera qualche cambiamento nel cuore e nell’anima di coloro che l’hanno adottato. Dà loro un nuovo rispetto di sé; mette in moto risorse di energia e di coraggio che essi non sapevano di possedere. Infine, mette in moto qualcosa nella loro coscienza così che la riconciliazione diventa realtà. (King 1993, 59-60)
Circa tre anni dopo, in seguito a una nuova serie di proteste scoppiate in un’altra città dell’Alabama, King si ritrovò a scrivere uno dei brani più significativi di tutta la sua produzione in quanto esponente della Southern Christian Leadership Conference (SCLC).
Il contributo, passato alla storia con il titolo di Letter from Birmingham Jail, fu diffuso e pubblicato in numerosi periodici e incluso l’anno seguente nel suo libro Why We Can’t Wait (1964). Nella lettera, indirizzata ai white clergymen di Birmingham, King sottolineava l’urgenza di agire contro la segregazione razziale e nel farlo rimarcava la necessità della disobbedienza civile come mezzo per sopraffare un sistema che costantemente umiliava e denigrava i neri d’America.
4. The Negro Can’t Wait
Si racconta che, durante la detenzione nel carcere di Birmingham nell’aprile del 1963, Martin Luther King cominciò a scarabocchiare sui margini di un giornale una lettera in risposta a otto rappresentanti «moderati» della chiesa locale.
Su quello stesso quotidiano, il Birmingham News, gli otto white clergymen in questione avevano pubblicato qualche giorno prima una lettera aperta che rimproverava a King e alla SCLC di aver promosso una campagna per i diritti civili in tempi troppo prematuri e in una città a loro estranea. Questa aspra critica offrì a King, che andava ormai perfezionando le sue doti di oratore, la possibilità di identificarsi nel suo discorso con un preciso pubblico di riferimento, cioè quello dei bianchi moderati, senza tuttavia apparire artificioso (Leff & Utley 2004, 41).
La lettera si apre con un’esortazione ai suoi «cari colleghi ministri della Chiesa», ai quali King si proponeva di spiegare la pertinenza delle sue attività di protesta considerate «poco sagge e intempestive».
I motivi che avevano indotto King a collaborare alla Campagna di Birmingham erano fondamentalmente due: in primo luogo, il pastore originario di Atlanta era stato invitato a collaborare con la filiale locale dell’Alabama Christian Movement for Human Rights e perciò intratteneva importanti rapporti organizzativi con questa città; in secondo luogo, egli affermava di trovarsi a Birmingham perché «qui si trova l’ingiustizia» e, proprio come l’apostolo Paolo, sentiva di essere «costretto a portare il vangelo della libertà al di fuori della [sua] città natale» (King 1993, 82).
Nei paragrafi successivi si apprestava così a descrivere il funzionamento delle campagne per i diritti civili:
In qualunque campagna non violenta bisogna fare quattro passi fondamentali:
1) raccogliere i fatti per determinare dove si radichi l’ingiustizia;
2) negoziare;
3) autopurificarsi
4) intraprendere un’azione diretta.
Qui, a Birmingham, abbiamo fatto tutti e quattro questi passi. Non c’è dubbio che l’ingiustizia è dovunque in questa comunità. (Ibid., 83)
Ma l’ingiustizia, ovunque essa fosse, rappresentava per King una minaccia contro il fondamento stesso di «giustizia». Per questa ragione era essenziale cercare di sovvertire «lo stato di cose che [aveva] generato queste dimostrazioni» al fine di sradicare l’odio razziale che ormai da troppo tempo costringeva i neri a una condizione vergognosa di subalternità. A coloro che gli intimavano di attendere tempi migliori, King non poteva far altro che rispondere:
Sono anni che sento la parola «Aspettate!» Risuona nelle orecchie di ogni negro; gli è acutamente familiare. Questo «Aspettate!» ha quasi sempre significato di «No! Mai!» Ha funzionato da tranquillante come il talidomide, alleviando per un momento la tensione solo per generare le malformazioni della frustrazione. Dobbiamo capire insieme con l'illustre giurista di ieri che «la giustizia amministrata con ritardo è una giustizia negata». (Ibid., 86)
Nel 1964, in quello stesso anniversario simbolico del 19 giugno, il Senato sancì ufficialmente la fine legale della segregazione razziale approvando il Civil Rights Act dopo settimane di ostruzionismo ed esattamente un anno dopo l'invio della proposta al Congresso da parte del presidente Kennedy. Il 2 luglio la Camera dei rappresentanti accolse gli emendamenti presentati dal Senato e lo stesso giorno il presidente Lyndon Johnson vi appose la sua firma.
Tuttavia il Paese rimase profondamente spaccato in due e il razzismo continuò a sopravvivere nonostante le riforme. Lo si comprese palesemente a Selma e a Montgomery, in Alabama, durante le marce del marzo 1965, e a Memphis, in Tennessee, quando il 4 aprile del 1968 Martin Luther King venne brutalmente assassinato.
La strada per la piena integrazione era ancora lunga e in salita.
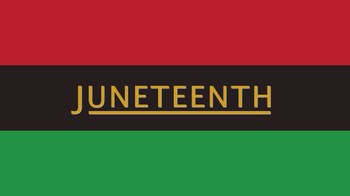
Le parole che Martin Luther King scrisse con tanto fervore nella Lettera dal carcere di Birmingham risuonano al giorno d’oggi più attuali che mai. A mezzo secolo di distanza dalle grandi proteste che hanno segnato gli anni Sessanta, gli afroamericani continuano a essere oggetto di una sistematica discriminazione nelle corti di giustizia.
Uno studio redatto dall’organizzazione Sentencing Project (qui), sostiene che un afroamericano su tre finirà presumibilmente in galera nel corso della sua vita, con pene più dure rispetto a quelle inflitte ai bianchi o ai latinos. Guardando al presente, le disuguaglianze non sembrano essere state debellate, ma sembrano essersi riconfigurate all’interno del sistema giudiziario americano.
Negli ultimi trent'anni, gli Stati Uniti si sono trovati più volte a fare i conti con l'irrisolta questione razziale, che ha portato numerosi attivisti, cittadini neri e bianchi, a organizzarsi in movimenti di protesta ispirati alla non violenza predicata da King.
Questi gruppi si battono contro il pregiudizio che vede nel colore della pelle un certo grado di criminalità e chiedono giustizia per tutte le vittime della violenza delle forze dell'ordine, che inesorabilmente colpisce cittadini afroamericani e di altre minoranze in modo eccessivo e senza giustificazione alcuna.
Oggi ricordare l’anniversario dell’emancipazione degli schiavi degli Stati Uniti d’America è più importante che mai. Questa ricorrenza ci permette di ripercorrere una storia dolorosa, ma altrettanto fondamentale per riuscire a comprendere e a riconoscere l’origine della disparità sociale che affligge una delle più grandi democrazie dell’Occidente.
Come sostiene Lockhart, in un certo senso il Juneteenth offre un’emblematica rappresentazione di come la giustizia sia sempre stata rimandata per la popolazione nera (Lockhart 2018).
Commemorare il Juneteenth nel ventunesimo secolo significa perciò anche rimettere in discussione quegli ideali di libertà e uguaglianza che sono alla base della Costituzione, riscoprendo in una ricorrenza così carica di significato l’essenza di una lotta comune a tutti gli individui, quella contro l’ingiustizia.
5. Bibliografia
Gates, Henry Louis, 2013, “What Is Juneteenth? African American History Blog.” Public Broadcasting Service (PBS.org), September 19, 2013, Web. (26.05.20)
Hughes, Langston 1990, “Selected Poems”, New York: Vintage Books.
King, Martin Luther, 1993, “Io ho un sogno. Scritti e discorsi che hanno cambiato il mondo”. Torino: SEI.
Leff, Michael & Utley, Ebony A. 2004. “Instrumental and Constitutive Rhetoric in Martin Luther King Jr.’s ‘Letter from Birmingham Jail’.”
Lockhart, P. R, 2018, “Why Celebrating Juneteenth Is More Important Now than Ever”, Vox, June 19, 2018. vox.com (07.06.20)
Zinn, Howard, 2005, “Storia del popolo americano dal 1492 a oggi”, Milano: il Saggiatore.
---. 2013. Report of The Sentencing Project to the United Nations Human Rights Committee: Regarding Racial Disparities in the United States Criminal Justice System. Sentencing Project.org Web. (05.06.20)
6. Sitografia
“King Encyclopedia.” 2017. The Martin Luther King, Jr., Research and Education Institute, Stanford University, Web. (29.05.20)
“Montgomery Bus Boycott.” (29.05.20)
“Civil Rights Cases.” 2019. Encyclopædia Britannica, britannica.com (29.05.20)
“Jim Crow law.” britannica.com (30.05.20)
“Rosa Parks Papers.” n. d. Library of Congress, log.cov (30.05.20)
“Rosa Parks’s reflections on her bus arrest, ca. 1956-1958.” log.cov (29.05.20)
Foto 1 da history.com (data ultima consultazione 23/07/21)