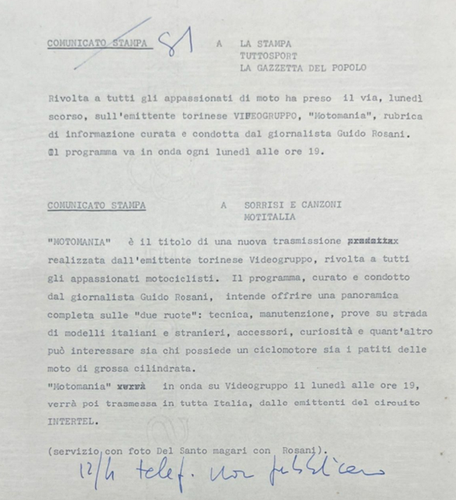8. Sport
Percorso 8. Lo sport sulle televisioni locali, tra commenti in diretta e invenzioni formali
“Ahia, qui c’è un buco nero da coprire”. È con queste parole che Michele Plastino ricorda la sua intuizione di proporre un programma sportivo nuovo, che facesse spazio per quelle “piazze che avevano bisogno di sentir parlare delle proprie squadre”, andando così a coprire i buchi informativi sulle squadre di calcio “minori” lasciati dall’iconica, eppure troppo nazionale, Domenica sportiva della Rai.
INSERIRE DI SEGUITO
Embed item: ATLas_TeleRoma56_interv-MichelePastino181124_000002 / Intervista a Michele Plastino, La nascita di “Goal di Notte” /
https://historica.unibo.it/bitstreams/b2d68d2c-8c00-476e-bc23-d24d3f6b3906/download
È il 1979, gli schermi sono quelli dell’emittente romana TeleRoma56, e il programma è Goal di notte, un talk show di commento sulle partite, di recente premiato dal comune di Roma per la longevità nell’aver mantenuto la stessa conduzione e denominazione per oltre quarant’anni. La storia delle tv locali è una storia che, per molti aspetti, ha intersecato la mediatizzazione televisiva dello sport, non solo perché la programmazione sportiva ha rappresentato il perno economico su cui molte tv private si sono rette, ma anche e soprattutto per l’enorme ruolo che le emittenti locali hanno avuto nell’ideare nuovi formati televisivi e nuovi modi di rappresentare e parlare di sport in tv. Come evidenziano i due giornalisti sportivi Sandro Piccinini e Giancarlo Dotto nel loro libro dedicato all’esperienza delle tv locali, relativamente allo sport, “i palinsesti Rai lasciavano ampi varchi per gli infiltrati”. In questi varchi, molte emittenti si insinuano con notevole profitto e originalità, talora fin dal lancio della propria messa in onda, come nel caso di Antenna 3. L’emittente lombarda inaugura le trasmissioni, nel novembre 1977, con un evento sportivo: lo scontro di pugilato tra l’americano Dave Adkins e l’italiano Sandro Mazzinghi, tornato per l’occasione sul ring alla veneranda età di 39 anni. Il match, commentato da Walter Chiari e presentato da Enzo Tortora, vede gli studi della neonata tv gremiti di spettatori. Come ricorda Wally Giambelli, la vedova del fondatore Renzo Villa, la decisione di coinvolgere il celebre pugile italiano deriva dalla necessità di “essere convincenti perché i giornali parlassero di questa nuova esperienza”, e quindi di sfruttare la visibilità garantita dal personaggio sportivo per ottenere “una risonanza mediatica su tutti i giornali”.
INSERIRE DI SEGUITO
Embed item: atls_antenna3_interv-wallygimbelli230424_000002 / Intervista a Wally Giambelli, Sandro Mazzinghi all’inaugurazione di Antenna 3 /
https://historica.unibo.it/bitstreams/d669b215-3334-4a5c-bf55-107fcba47291/download
In generale, l’attenzione che da subito le tv locali riservano alla programmazione sportiva non è solo funzionale a sfruttarne la visibilità, ma risponde a una duplice esigenza: lo sport si presta bene a coniugare l’informazione con l’intrattenimento, oltre che a veicolare un radicamento sul territorio. Se, come suggerito da Umberto Eco, tra le maggiori innovazioni della neotelevisione vi è quella di capovolgere il cannocchiale televisivo per “puntare la telecamera sulla provincia”, lo sport vi trova spazio sia come forma di intrattenimento popolare, sia nella sua dimensione di collante di forme di socialità locali. È così che, per esempio, il calcio fa la sua comparsa in Caffè doppio, il programma di Antenna 3 ideato da Beppe Recchia e Renzo Villa con l’idea di presentare “la realtà tipica e regionale” dei bar italiani. Nella puntata del 25 giugno 1983, la messa in onda di una competizione tra le squadre di calcio femminili di due bar della provincia parmense, “Al Cavallino” e “Bar Roma”, fornisce l’esempio perfetto di quella finestra che le tv commerciali aprono sul mondo sociale della provincia italiana, proponendo programmi in cui gli spettatori possano riconoscersi e prendere parola.
INSERIRE DI SEGUITO
Embed item: ATLas_antenna3_caffedoppio260683_000001 / “Caffè doppio”, Match tra squadre calcistiche locali e saluti finali /
https://historica.unibo.it/bitstreams/5ec762d9-7df3-4de7-bff9-6599346cc7d9/download
Le manifestazioni sportive – persino quelle iper-amatoriali – diventano parte attiva del tentativo di mettere al centro dell’interesse televisivo tutto ciò che il monopolio pubblico della Rai ha lasciato ai margini, dagli sport “minori” alla vita culturale delle realtà provinciali e cittadine. Ne deriva un vero e proprio moltiplicarsi di rubriche dedicate agli sport più vari, con lo scopo tanto di rivolgersi a un pubblico di appassionati, quanto di portare l’attenzione su un preciso contesto territoriale. Il servizio dedicato dalla torinese Videogruppo, nel giugno 1985, alla rievocazione storico-automobilistica organizzata al Parco del Valentino per l’anniversario del dismesso circuito di Formula 1 diventa l’occasione sia per catturare l’attenzione degli amanti dei motori, che per esplorare angoli di città e valorizzarne le iniziative culturali.
INSERIRE DI SEGUITO
Embed item: Videogruppo_autoalValentino_000001 / Ritorno al Valentino: rievocazione storica automobilistica /
https://historica.unibo.it/bitstreams/264396b5-104d-46f0-b1be-84673b26cecb/download
La stessa emittente, già dal 1981, manda in onda una rubrica d’informazione, Motomania, rivolta “agli appassionati motociclisti”. Grazie all’adesione al circuito Intertel, la trasmissione, curata e condotta dal giornalista Guido Rosani, viene trasmessa in tutta la penisola.
Programmi dedicati ai motori compaiono contestualmente anche su altre emittenti: sin dai primi anni Ottanta, l’attore Daniele Formica cura un editoriale sulla Formula 1, ogni lunedì su TeleRoma56. Entrano nello schermo anche le discipline sportive che – come commenta il campione motociclistico italiano di velocità in salita, Stefano Pagnozzi, in un’intervista per Videogruppo del 1984 – sono “quasi ignorate dai giornali”, nonostante siano più “abbordabili” per chi ha pochi mezzi economici ma molta passione sportiva.
INSERIRE DI SEGUITO
Embed item: Videogruppo_serviziomotociclismo_000001 / Stefano Pagnozzi, campione motociclistico italiano di velocità in salita /
https://historica.unibo.it/bitstreams/03a7e1f9-e276-4f0f-854a-06935c3685f6/download
“Infiltrarsi” nei varchi lasciati dal palinsesto Rai non significa quindi semplicemente andare a coprire i “buchi neri” lasciati dalla Domenica sportiva o da 90° Minuto, con la loro attenzione privilegiata sulle grandi squadre come Juve, Milan e Inter, o (è il caso del secondo) la messa in onda del secondo tempo di una singola partita di Seria A ogni settimana. È tuttavia senza dubbio il calcio che, anche sulle tv locali, domina la programmazione sportiva. L’intuizione di Michele Plastino si rivela, in tal senso, una premonizione di successo: dando spazio alle squadre di serie A regionali, come ai campionati minori dalla serie B in giù, molte emittenti locali si garantiscono un bacino d’utenza tale da assicurare proficui contratti pubblicitari e, quindi, la loro tenuta economica. A farsi spazio sugli schermi delle tv private sono gli esclusi della tv pubblica, con inedita attenzione perfino per il campionato di calcio femminile. Nella lunga rubrica dedicata allo sport dal telegiornale di Sardegna 1, nell’aprile 1987, il presentatore Sandro Angioni si spende in un lungo commento sulla partita di Serie B della squadra femminile Delfino di Cagliari, mostrando le immagini della trasferta contro il Club Provinciale Tarquinia.
INSERIRE DI SEGUITO
Embed item: Sardegna1_TGS1sport_000004 / “Sardegna 1 Sport”, Il calcio femminile
https://historica.unibo.it/bitstreams/1f534fb0-1425-46a6-884a-add4c9d00674/download
La stessa trasmissione, nel passaggio al commento sui campionati regionali maschili, intreccia componente informativa e dimensione narrativa, anticipando alcuni aspetti dell’evoluzione che il linguaggio televisivo sul calcio assumerà soprattutto a partire dagli anni Novanta. È il caso della centralità attribuita a quelli che ancora non si chiamano highlights, ma già sono al cuore dei servizi sulle giornate sportive. Nel rilanciarsi la parola tra una redazione cittadina e l’altra, i conduttori di Sardegna 1, Sandro Angioni, Ignazio Artizzu e Pinuccio Saba, commentano i momenti clou delle partite regionali.
INSERIRE DI SEGUITO
Embed item: Sardegna1_TGS1sport_000003 / “Sardegna 1 Sport”, il commento delle partite di calcio regionale /
https://historica.unibo.it/bitstreams/ba159a12-0fa2-43b1-b76a-a20b984ad05f/download
L’importanza del calcio aumenta man a mano che progredisce l’evoluzione commerciale delle tv locali: garantendo introiti, questi programmi assumono un rilievo e una popolarità sempre maggiore, spesso sconfinando, sia per trasmissione sia per interesse, oltre i confini locali. Non solo le trasmissioni sulla serie A arrivano talvolta a occupare l’intero palinsesto domenicale, ma, in corrispondenza dei mondiali, diverse tv private organizzano una loro contro-programmazione alternativa alla Rai, dalle riprese rocambolesche dello speciale realizzato da Valentino Tocco (il cameraman di TeleRoma56) e Michele Plastino in occasione dei mondiali del 1982 alle sette ore che l’emittente romana legata al PCI, Videouno, dedica ai mondiali del 1986. Un programma come Goal di Notte arriva addirittura a ottenere una dimensione sovra-regionale, esportato su più canali e in più città, grazie all’incredibile energia del suo autore e conduttore che diventa presto un’icona sportiva nazionale. Oltre a Roma, Plastino ottiene fama soprattutto a Napoli, assecondando la logica di un ribaltamento di prospettiva sul calcio: mettere al centro le principali squadre di ogni regione, lasciando ai margini le cosiddette “strisciate del Nord”. Il programma, nel corso degli anni Ottanta, ospita in studio figure di alto profilo sportivo come Boniek, Platini, Falcao e, addirittura, Maradona. È negli studi di TeleRoma56 che, nel 1985, “El pibe de oro” concede una storica intervista in cui parla del carattere innanzitutto popolare di uno sport come il calcio. Al termine del breve scambio di battute con Plastino, Maradona si prodiga nel palleggio di un’arancia passatagli da uno spettatore, nella sorpresa generale del pubblico in studio.
INSERIRE DI SEGUITO
Embed item: ATLas_ TeleRoma56_GoalDiNotte_000001 / “Goal di Notte”, Intervista a Diego Armando Maradona /
https://historica.unibo.it/bitstreams/3de97d65-7118-4ddc-b46f-1bda2a20651b/download
Nel farsi strada nei cuori degli spettatori, che spesso favoriscono i programmi calcistici delle tv locali a quelli proposti dal servizio pubblico, le emittenti private somigliano quasi a quell’Hellas Verona a cui, nel novembre 1984, Fuorigioco – programma ideato per Videogruppo da Marco Bernardini e Darwin Pastorin – dedica il servizio d’apertura. Dopo la sigla del programma, sono mostrate riprese dal campo della squadra veronese, mentre il commentatore sottolinea con toni celebrativi la capacità di una piccola squadra provinciale di “mandare in crisi il sistema istituito dalle grandi potenze tipo Juventus, Inter, Roma, Fiorentina e Torino”. Segue quindi una breve intervista a Boniek, ancora una volta a conferma del sempre maggiore rilievo riconosciuto alle tv locali da parte del mondo stesso del calcio.
INSERIRE DI SEGUITO
Embed item: Videogruppo_fuorigioco_000001 / “Fuorigioco”, Sigla del programma e commenti sull’Hellas Verona /
https://historica.unibo.it/bitstreams/54e193fa-282f-4811-a459-c7e658b94a5d/download
È innanzitutto per far fronte all’impossibilità (prima tecnica e poi anche legale) di mostrare le immagini delle partite che le tv locali mettono in atto disparate soluzioni innovative, ricorrendo a espedienti al limite della legalità. Ricorda in proposito Valentino Tocco le sue piratesche incursioni con la telecamera negli stadi: pur senza avere uno straccio di accredito, lui e Plastino si avventurano sotto gli spalti, arrivando a posizionare il microfono sotto la porta e mostrando “punti di vista che nessuno aveva mai visto”, dalle parole arrabbiate dei portieri alle riprese sul tifo organizzato.
INSERIRE DI SEGUITO
Embed item: ATLas_TeleRoma56_interv-ValentinoTocco190124_000006 / Intervista a Valentino Tocco, TeleRoma56 la tv del calcio /
https://historica.unibo.it/bitstreams/3a76f372-3cca-4722-b289-bc9d28a668a2/download
In modo simile, Piccinini e Dotto menzionano le radiocronache fatte in avvistamento dai balconi delle case in prossimità degli stadi, o le raccolte dei gettoni telefonici per realizzare le radiocronache dalle cabine, con un commentatore in collegamento telefonico con la tv di turno e un altro a fare la spola con lo stadio. Un genere tipicamente radiofonico è così esportato sugli schermi televisivi, con la messa in onda delle radiocronache a garantire la possibilità della diretta, pur senza immagini, delle partite. Ne consegue il prevalere di una dimensione narrativa, se non addirittura immaginifica, del commento sul calcio, che è destinata a fare scuola: “Se le cose non le vedi, fai finta di averle viste”, commenterà alcuni anni dopo Pato, uno dei giornalisti sportivi di TeleRoma56, nel proprio decalogo per i posteri. Anche grazie a queste intuizioni sovversive, le tv locali entrano in una ritualità domenicale collettiva. Ricorda Alberto Gangichiodo (tecnico e giovane spettatore di TeleRoma56) il “rito importantissimo” delle visioni di In campo con Roma e Lazio, il programma di Lamberto Giorgi avviato nel 1983 e rapidamente divenuto la trasmissione di maggiore successo della capitale. Gangichiodo sottolinea il carattere ipnotico e innovativo del software con cui il conduttore faceva la cronaca delle partite, mostrando una pallina che si spostava in base al movimento del pallone in campo: una prodezza tecnica per l’epoca.
INSERIRE DI SEGUITO
Embed item: ATLas_TeleRoma56_interv-AlbertoGangichiodo061223_000005 / Intervista a Alberto Gangichiodo, “In campo con Roma e Lazio” e altri programmi iconici di TeleRoma56 /
https://historica.unibo.it/bitstreams/927d86a3-e22f-4390-b97d-6f6d4743f0b7/download
In modo ancora più significativo, le tv private sperimentano e propongono formati nuovi che, se da un lato traggono origine dal bisogno di attrarre spettatori, dall’altro hanno l’importante effetto di estendere la fruizione dello spettacolo-calcio non solo oltre i confini dello stadio, ma anche oltre il tempo e la dimensione della partita. È in seno alle emittenti locali che sono proposti servizi in cui, per ovviare all’impossibilità della diretta, si mostrano i presentatori in studio intenti a guardare e commentare la partita in tv, mescolando cronaca e intrattenimento e anticipando programmi come Quelli che il calcio. Soprattutto, sono le tv locali le prime a introdurre forme televisive in linea con la volontà di creare un legame diretto con il pubblico, avviando i fili diretti con gli spettatori e favorendone il coinvolgimento nelle trasmissioni. Programmi come A botta calda, ideato da Enzo Scala per TVR Voxson e considerato il primo talk show di calcio parlato, soddisfano quel bisogno di partecipazione e protagonismo del pubblico di cui le tv private sono considerate la massima espressione. Seguono una simile impostazione anche altri programmi calcistici del decennio, da Meeting di Giulio Galasso (sempre per TeleRoma56) a Qui studio, a voi stadio su Telelombardia e Cuore di calcio, condotta da Fabio Alescio su Gbr. Tra gli effetti di questo fermento televisivo-calcistico va incluso il crescente protagonismo dei presentatori sportivi. Le tv locali costituiscono una sorta di laboratorio di nuove professionalità, da cui sono usciti alcuni tra i più importanti conduttori e commentatori televisivi di calcio, da Fabio Caressa e Sandro Piccinini a Mario Mattioli e Simona Ventura. Ancora nei primi anni Novanta, il giornalista Riccardo Luna sottolinea in un articolo su “La Repubblica” come i conduttori dei programmi sportivi locali siano “vere e proprie star, ascoltate, contestate e inseguite dalle telefonate dei tifosi”. Tutto questo inasprisce, chiaramente, la competizione con la Rai, determinando tanto uno stimolo per le continue innovazioni, quanto ripetuti ostacoli alla sopravvivenza stessa delle emittenti locali. Ricorda in proposito Sandro Piccinini la dura “guerra con la Rai” relativamente alla radiocronache di calcio, con continue denunce, oscuramenti e cause legali avviate dall’azienda pubblica contro le tv private.
INSERIRE DI SEGUITO
Embed item: ATLas_TeleRoma56_interv-SandroPiccinini190624_000007 / Intervista a Sandro Piccinini, La pessima relazione con la Rai /
https://historica.unibo.it/bitstreams/fdc3c057-48ca-4d2e-9600-a42639bf9770/download
D’altronde, che il calcio giochi un ruolo determinante nella concorrenza con la Rai è evidente sin dalle prime fasi di vita delle televisioni commerciali, tanto di più di quelle con ambizioni di allargamento: non a caso, a segnare il primo traguardo verso l’estensione nazionale delle reti di Berlusconi è la vittoria ottenuta nel contenzioso con la Rai sui diritti di trasmissione del cosiddetto “Mundialito”, il torneo internazionale lanciato dall’Uruguay nel 1980. La competizione intorno alla cronaca calcistica si estende a tutte le tv locali nel corso del decennio, inasprendosi, in particolare, nel corso del 1987. In quell’anno, la Rai chiude un accordo con la Lega per impedire alle tv private non solo di trasmettere le immagini delle partite, ma finanche di comunicare in tempo reale i risultati. È Piccinini a spiegare come, nel far fronte alla situazione, le tv locali facciano innanzitutto appello al diritto di cronaca. Rivendicando di offrire un servizio pubblico al cittadino-spettatore-tifoso, le emittenti private configurano il calcio come una forma di intrattenimento che, in virtù del suo radicamento sul territorio, può essere presentata nei termini della difesa di un diritto all’informazione. Questa visione trova riscontro, almeno in parte, nella rappresentazione della contrapposizione Rai-tv private proposta dalla stampa dell’epoca. In un articolo del luglio 1987, il quotidiano Italia Oggi descrive l’accordo tra la Lega calcio e la Rai come “un’azione di killeraggio verso le tv private”, ma soprattutto come “un colpo ai tifosi”. A riprova di ciò, si sottolinea l’incapacità della Rai di “fornire al popolo dei tifosi, così articolato e così legato al proprio campanile, quei servizi che le emittenti minori possono oggi assicurare, uno spazio con precise connotazioni sociali perché rivolto principalmente a soddisfare esigenze popolari”. Una situazione simile si ripropone cinque anni dopo, nel 1992, quando di nuovo la Lega e la Rai prendono l’iniziativa congiunta di limitare la cronaca delle partite sulle tv private. Anche in questo caso, a difesa delle emittenti locali, si rivendica il loro contributo a democratizzare la fruizione del calcio, mescolando il diritto del pubblico all’intrattenimento con quello dei tifosi all’informazione. In un comunicato ufficiale, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana argomenta come “le tv locali sono le sole a poter svolgere un’azione capillare approfondita sulla propria realtà”, riconfermando il forte legame tra programmazione sportiva e territorio che ha caratterizzato l’esperienza delle televisioni locali sin dalle origini. Nel frattempo, l’approvazione della legge Mammì e la nascita delle prime pay-tv hanno dato un duro colpo tanto alle capacità di sopravvivenza di molte emittenti locali, quanto alla possibilità di fare leva sul calcio per assicurarsi contratti pubblicitari. A fronte, tuttavia, del loro lento crepuscolo, rimane l’enorme ruolo che le tv locali hanno giocato nel cambiare il linguaggio televisivo sul calcio, facendone un vero e proprio genere televisivo a sé. La logica produttiva e le costrizioni legali delle tv private, imponendo la sperimentazione di nuovi format e artifici retorico-comunicativi, hanno dato un contributo essenziale, senza dubbio, a fare della televisione lo strumento chiave della spettacolarizzazione del calcio.
Percorso a cura di Giulia Crisanti (Sapienza Università di Roma)