6. Politica
Percorso 6. La dimensione politica delle reti locali, nel passaggio da tv libere a tv private
È il 6 aprile 1972 quando l’emittente piemontese TeleBiella, fondata da Giuseppe Sacchi l’anno prima, avvia le trasmissioni via cavo. Un paio di mesi prima, dalle pagine de “L’Espresso”, Eugenio Scalfari lancia un’invocazione a sostegno della “libertà d’antenna”, aprendo ufficialmente le porte alla contestazione del monopolio Rai. Per quanto il primato di TeleBiella sia stato contestato su più fronti, la stazione piemontese è la prima a conferire un valore deliberatamente politico alla sua attività, ponendosi alla testa della battaglia per un sistema televisivo alternativo a quello Rai. Da lì a quattro anni, una serie di sentenze della Corte Costituzionale danno sanzione giuridica alla liberalizzazione, per quanto entro i limiti di un non ben definito territorio “locale”, prima delle trasmissioni televisive via cavo (1974) e poi anche di quelle via etere (1976). La tv privata nasce quindi “locale” non solo per motivi giuridici, ma anche per scelta. La visione da cui molte delle prime emittenti originano è ben sintetizzata da un piccolo volume pubblicato da Roberto Faenza nel 1973, Senza chiedere il permesso, in cui si oppone alla “televisione centralizzata e burocratizzata” della Rai un modello di “televisione alternativa”, che serva alle masse per “comunicare le proprie esigenze e i propri desideri”. In tal senso, l’emergere di centinaia di emittenti locali, da inizio anni Settanta in poi, si inserisce nell’onda dell’ideologia comunicativa dei movimenti della fine del decennio precedente. Per quanto il passaggio dal cavo all’etere sia letto da molti come un tradimento di questo spirito iniziale, l’idea di una “tv comunità dal basso” continua ad animare la proposta di molte emittenti anche negli anni successivi al 1976. Se ne trova espressione, per esempio, in una delle prime trasmissioni conservate dalla stazione torinese Videogruppo: l’intervista-dibattito realizzata a commento del “convegno contro la repressione” tenutosi nel settembre 1977 a Bologna. Le immagini, in bianco e nero, mostrano uno studio scarno, in cui siedono i tre ospiti, Piero Fassino, Steve Della Casa e Claudio Valeri, e il conduttore, Sergio Rogna, che è anche il fondatore dell’emittente. Dopo aver introdotto l’edizione e riassunto i fatti dei giorni precedenti, Rogna annuncia la messa in onda di alcune scene del convegno appositamente registrate da una troupe inviata sul posto e comprensive dell’intervista rilasciata da Felix Guattari per Radio Alice.
Mettendo insieme immagini di repertorio e voci raccolte dalle radio libere, il breve estratto lascia una traccia importante tanto del clima politico-culturale da cui l’esperienza delle tv locali ha avuto origine quanto di una trasformazione del panorama politico italiano. Il convegno di Bologna, seguito dall’uccisione del militante di Lotta Continua Walter Rossi, è generalmente considerato l’evento crepuscolare del cosiddetto lungo Sessantotto italiano: un passaggio simbolico che segna l’esaurirsi della spinta del movimento del Settantasette e l’avvio di una nuova fase di “riflusso”. Due anni dopo, un altro dibattito trasmesso dalla stessa emittente mostra come i tempi siano, almeno in parte, cambiati. L’idea di una televisione come spazio e megafono per le forze sociali e politiche del Paese non è completamente venuta meno. Il servizio, realizzato nel quadro del programma Cronache torinesi, presenta un’intervista a due operai licenziati dalla Fiat, che si alternano nel contestare le motivazioni della dirigenza e dare voce alle rivendicazioni del sindacato. Sono tuttavia mutati sia il formato che le finalità della trasmissione: le immagini appaiono a colori, a testimonianza di un avanzamento tecnico ma anche professionale dell’emittente; soprattutto, la parziale contestazione delle argomentazioni dei lavoratori da parte dell’intervistatore segnala una cambiamento di concezione rispetto al ruolo della tv.
Con la progressiva crescita di molte tv locali via etere, si genera una sempre maggiore tensione tra l’appello alla libertà d’informazione e quello alla libertà d’impresa. Già nello speciale che la rivista “Tv Sorrisi e Canzoni” dedica nel 1978 alle centinaia di nuove antenne non si manca di notare come “private o libere, ma non è la stessa cosa”. Mentre le radio della fine degli anni Settanta mantengono una chiara prospettiva di contestazione politica, la gran parte delle tv locali sembra progressivamente ribaltare i propri presupposti iniziali, a favore di una riorganizzazione aziendale delle proprie attività, in linea con il parallelo passaggio da un desiderio di partecipazione a una ricerca di protagonismo da parte degli spettatori. Questa evoluzione non è tuttavia da considerarsi né repentina né lineare, ma segnata da una serie di ambivalenze. L’intreccio tra rivendicazioni contro-informative e ricezione dei desideri di consumo del pubblico è ben sintetizzato dalla testimonianza di Francesco Arcieri, socio fondatore di TeleRoma56. Nel ricostruire la propria esperienza, sul finire degli anni Settanta, tra radio e tv private, Arcieri sottolinea soprattutto il dato per cui “la gente voleva parlare, voleva essere coinvolta”. Questo desiderio di coinvolgimento si traduceva tanto nella ricerca di una fonte d’informazione alternativa alla Rai (è il caso del ruolo delle tv e delle radio libere in occasione del rapimento di Aldo Moro), quanto nel “mostrare cosa era veramente popolare”, e quindi nella continua richiesta, da parte degli spettatori, di mandare in onda le canzoni leggere e disimpegnate di Domenico Modugno.
Nel giro di pochi anni, la crescente concorrenza e la continua assenza di una legislazione sull’emittenza privata accentuano la dipendenza delle nuove televisioni dagli introiti pubblicitari, alimentando una progressiva concentrazione in pochi circuiti nazionali gestiti da grandi gruppi finanziari o editoriali. È la fine – commenta Aldo Grasso – del “sogno rivoluzionario di una comunicazione alternativa”. In questo contesto, prevale una programmazione televisiva dominata da trasmissioni di spettacolo: una sorta di “televisione sogno” – secondo l’interpretazione di Peppino Ortoleva – sganciata dalla realtà, spoliticizzata sul piano dei contenuti, vocata all’intrattenimento e gestita da imprenditori, in contrapposizione alla parallela lottizzazione delle reti Rai. Uno sguardo dettagliato sulle esperienze delle singole stazioni televisive mostra, tuttavia, come né la tendenza verso la commercializzazione, né quella verso l’intrattenimento abbiano significato il completo abbandono di spinte alternative sia politiche che contro-informative. Al contrario, gli anni Ottanta mostrano diversi esempi di una convivenza, se non addirittura una contaminazione tra pratiche di sistematizzazione aziendale e la continua rivendicazione di una vocazione politica al pluralismo. Se ne trova espressione tanto nell’esistenza di una serie di tv private di proprietà di un partito politico, quanto nella presenza della politica nella produzione e programmazione delle emittenti locali. Il caso più significativo di tv “politica” è senza dubbio quello di TeleRoma56, l’emittente fondata da Bruno Zevi e Guglielmo Arcieri nel 1976 e acquistata dal Partito Radicale nel 1979. L’esperienza di TeleRoma56 offre una buona sintesi non solo della divergenza di traiettorie tra radio e televisione, ma anche del tentativo di coniugare dimensione commerciale e informazione politica. Come spiega bene Paolo Vigevano – ex tesoriere del partito –, alla “differenza sostanziale” tra le “esigenze pubblicitarie” della televisione e l’assoluta indipendenza di Radio Radicale fa da contrappunto una ricorrente collaborazione e condivisione della programmazione, soprattutto per la realizzazione dei fili diretti e delle “trasmissioni di iniziativa politica”.
Supportando sia la radio che la televisione attraverso i fondi del finanziamento pubblico ai partiti, i radicali presentano entrambe come un servizio pubblico e vi ricorrono, spesso in forma combinata, nel corso delle varie tornate elettorali. È il caso dei molti e ripetuti fili diretti condotti da Pannella ma anche delle dirette sul voto, come in occasione delle elezioni europee del 1984, quando Emma Bonino, Gianfranco Spadaccia e Roberto Cicciomessere conducono una lunga trasmissione televisiva in collegamento con la radio per registrare le dichiarazioni elettorali degli spettatori.
Pur rappresentando l’esempio forse più famoso di televisione privata di partito, il caso TeleRoma56 non è tuttavia isolato. In un lungo articolo del 1982, il giornalista Nanni Riccobono sottolinea, sulle pagine de “L’Unità”, l’esistenza di una serie di “tv politiche” che dedicano ampi spazi all’informazione e usano la tv come megafono, secondo logiche simili a quelle della Rai.
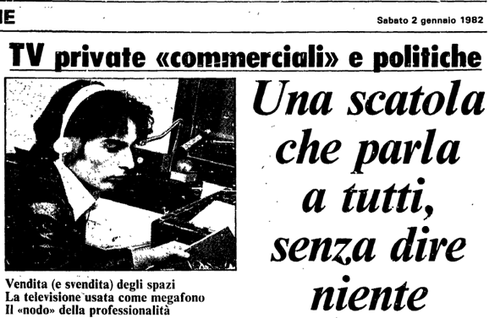
Articolo di approfondimento de “l'Unità” sulle televisioni private romane, 1982
Entro la metà degli anni Ottanta, le principali tv romane sono quasi tutte direttamente o indirettamente legate a un partito: Videouno è di proprietà del Partito Comunista Italiano, Tele Roma Europa è di proprietà dei fratelli Rebecchini (figli dello storico sindaco democristiano Salvatore Rebecchini), mentre Gbr presenta una traiettoria addirittura opposta a quella convenzionale. Nata nel 1976 come televisione fondamentalmente commerciale, l’emittente fallisce nel 1985 e viene rilevata dalla Cine TV, un’azienda collegata al Partito Socialista. La prossimità con “il palazzo” fa sì che la caratterizzazione politica sia particolarmente evidente nel caso delle tv della capitale. La politica è tuttavia presente e suscita interesse in diverse emittenti lungo tutta la penisola. Nella maggior parte dei casi, più che un legame con un partito, le tv locali esprimono una vicinanza ad un’area politica. È così, per esempio, per TeleSanterno, la tv emiliana fondata nel febbraio del 1976 da Domenico Berti. Secondo la testimonianza di Fabio Orsi, ex tecnico per l’emittente, il primo direttore di TeleSanterno, Demo Spalladini, “era un esponente della Democrazia Cristiana imolese”, così come di area democristiana erano i sacerdoti ospitati nelle “trasmissioni di carattere religioso”. Orsi chiarisce tuttavia la volontà di non darsi “uno schieramento netto” per poter trarre profitto dalle tribune elettorali e “giocare a fare la Rai”.
La presenza della politica nelle tv locali non riguarda, inoltre, il solo assetto proprietario, ma coinvolge anche la programmazione, seppure in forme e con modalità profondamente diverse tra un’emittente e l’altra. I contenuti politici non mancano anche laddove prevale la dimensione dell’intrattenimento, come nel caso di Antenna 3. La tv lombarda si caratterizza per un forte taglio generalista, con programmi d’evasione per tutta la famiglia, in apparentemente perfetta adesione all’idea di una “televisione sogno”. Eppure, anche qui la politica penetra, talora in modo sotteso. Nella puntata della trasmissione Pomofiore del 25 gennaio 1979, la notizia politica, ossia la visita in Italia del ministro degli esteri sovietico Gromyko, diventa il pretesto per una gag comica del presentatore Lucio Flauto, che finisce per far intonare marce sovietiche all’enorme pubblico in sala.
Ancora più significativa è la presenza, sempre su Antenna 3, di trasmissioni che intrecciano in modo esplicito spinta contro-informativa, esigenze commerciali e proposta di intrattenimento. Un ottimo esempio è l’intervista “contropelo” realizzata da Enzo Tortora ad Aldo Aniasi nel novembre 1980, nel programma Aria di Mezzanotte. L’intervista prende origine dalla sponsorizzazione pubblicitaria offerta da Braun, che ne fa uso per promuovere i propri rasoi; e Tortora incalza il parlamentare socialista con domande pungenti sui suoi rapporti con Craxi e sulle scelte politiche messe in atto dal governo, in uno scambio di battute che tutto sembra tranne che funzionale a distrarre gli italiani dalla crisi in corso.
Ne emerge un quadro di attenzione delle reti private nei confronti della politica che sconfessa, almeno in parte, l’idea di una televisione commerciale spoliticizzata e sganciata dalla realtà. In proposito, vale la pena segnalare come, in corrispondenza dell’approvazione dei decreti Berlusconi e per tutta la seconda metà del decennio, le reti locali costruiscano la propria retorica di opposizione al duopolio facendo leva sul loro ruolo di garanti del pluralismo d’informazione. Anche in questo caso, TeleRoma56 fornisce un esempio contemporaneamente eccezionale e paradigmatico dell’intreccio tra dimensione politica ed esigenze commerciali: in un’intervista televisiva del 1985, Sergio Stanzani (membro della Commissione di Vigilanza Rai, nonché presidente dell’emittente) contesta il tentativo di porre dei limiti alla pubblicità televisiva, sottolineando il rischio di “far saltare le emittenti locali” e con esse “l’unico vero contributo al cosiddetto pluralismo o comunque al dibattito politico e culturale del Paese”.
L’appello al diritto d’informazione rimane, dunque, una costante del discorso pubblico sull’emittenza privata, in combinazione piuttosto che in antitesi con un conclamato diritto all’intrattenimento. Questa rivendicazione di essere l’unico baluardo a tutela del pluralismo d’informazione fa peraltro leva sul forte radicamento delle emittenti locali sul territorio. Un’altra risposta delle tv locali all’affermazione del duopolio è, infatti, l’accentuazione dell’attenzione sulla politica locale, soprattutto in corrispondenza delle tornate elettorali. In occasione delle amministrative del 1985, per esempio, l’emittente torinese Videogruppo propone un servizio di Primo piano dedicato alla manifestazione socialista tenutasi nei giorni precedenti presso il cinema Lux, con le dichiarazioni sia del sindaco della città che di Craxi.
In altri casi, le tv locali si trasformano in piazze per presentare le liste e i candidati dei vari partiti. Se già nel 1979 a convincere i radicali dell’opportunità di avere una propria televisione è il risultato elettorale ottenuto grazie alla campagna condotta su TeleRoma56, ancora dieci anni dopo gli studi dell’emittente ospitano i candidati del partito all’elezioni comunali, tra cui l’attore e figura di spicco della scena romana Urbano Barberini. In un’intervista realizzata nel contesto di Campidoglio 89, Barberini mescola l’analisi politica locale con commenti sulla politica nazionale, invitando a votare la lista antiproibizionista come “gesto di opposizione a un sistema che ha massacrato l’Italia”.
Quello stesso anno, un articolo de “La Repubblica” dedicato alla diretta elettorale organizzata da quattro emittenti romane sottolinea come “la politica nelle tv locali resta di casa”. Peraltro, l’uso elettorale delle tv locali riproduce talora pratiche mutuate dalla pubblicità. Nel settembre 1987, il giornalista Michele Smargiassi segnala sulle pagine de “L’Unità” l’emergere di “pubblicitari militanti” che usano la tv per “vendere politici come lavatrici”. Un ottimo esempio di questa tendenza arriva dallo speciale televisivo A colpi di spot, condotto da Maria Luisa Busi e trasmesso da Sardegna 1 in occasione della campagna per le elezioni regionali del 1989. Mentre scorrono estratti degli spot prodotti dai vari partiti, la giornalista spiega come la televisione sia diventata “la nuova piazza, il nuovo modo di chiedere un voto”, evidenziando “l’affollamento mai visto” di spot “a tutte le ore, tra telegiornale e telenovelas, mischiati agli spot commerciali dei detersivi, in un’ammucchiata da nevrosi collettiva”.
Nei primi anni Novanta, in chiara risposta alla legge Mammì, molti commentatori riaffermano la funzione politica della tv locali tanto a tutela del pluralismo, quanto per scopi elettorali. In un comunicato ufficiale diffuso da Adnkronos nel 1992 e ripreso dalle maggiori testate, si argomenta come “le tv locali sono le sole a poter svolgere un’azione capillare di approfondimento sulla propria realtà”. Un anno dopo, simili argomentazioni sono ribadite in un articolo pubblicato su “Il Tempo”, in cui si sottolinea come le tv locali garantiscano “un filo diretto con i cittadini che non si trova di certo nelle reti nazionali”. Parallelamente, il passaggio, nelle elezioni politiche del 1994, a un sistema elettorale uninominale induce alcuni a sostenere il potenziale “ruolo determinante” – secondo un editoriale pubblicato dal giornale “Il Mondo” – delle “antenne elettorali” locali. Come ben noto, le elezioni del 1994 vedono in realtà il trionfo politico di Silvio Berlusconi e delle sue tre reti nazionali, a sanzionare la definitiva chiusura della Prima Repubblica e, con essa, anche delle tv private legate direttamente o indirettamente a quei partiti politici. Tuttavia, il tentativo messo in atto da molte emittenti locali di coniugare esigenze commerciali e impegno rimane a testimonianza del loro ruolo sociale centrale.
Percorso a cura di Giulia Crisanti (Sapienza Università di Roma)
