1. Breaking news
Percorso 1. Le breaking news sulle televisioni locali, tra eventi e calamità naturali
Specchio e interprete sensibile delle paure e dei sogni del pubblico, tra la fine degli anni Settanta e l’inizio dei Novanta l’emittenza locale intercetta l’attenzione della sua utenza anche grazie a un marcato contatto con l’attualità. In Italia, infatti, la televisione privata non si sviluppa solo come distrazione, fuga o protezione dalla cronaca: persino le reti più votate all’intrattenimento, come Antenna 3 in Lombardia o TeleSanterno in Emilia-Romagna, non esitano all’occorrenza a destinare ampie porzioni dei palinsesti alla copertura di fatti o eventi ritenuti significativi per spettatrici e spettatori. Uno dei fili rossi che lega i canali al centro del progetto ATLas riguarda la messa in onda di segmenti straordinari di informazione, che in caso di avvenimenti di eccezionale rilievo occupano spazi di palinsesto assegnati in origine ad altro. È un’esondazione dagli slot di solito riservati alle notizie, a partire dal telegiornale, che comporta lo stravolgimento delle normali griglie di programmazione, di norma meno rigide rispetto a quelle del broadcasting nazionale, e di conseguenza più facilmente passibili di revisioni e rimaneggiamenti. Speciali, flash informativi, collegamenti con inviati in loco, aggiornamenti dell’ultim’ora: quando una breaking news irrompe in diretta, non è un tabù interrompere le trasmissioni per fare un annuncio o dar conto degli ultimi sviluppi, sperimentando estetiche e registri che non sempre si accordano al tenore di quanto raccontato. Per le reti locali non è solo una notevole prova di mobilitazione di risorse tecniche e giornalistiche, ma anche un’occasione per fare di necessità virtù, sfruttando notizie di sicura presa sul pubblico per assicurarsi ascolti (e introiti pubblicitari, pur con qualche eccezione). Che siano maratone una tantum o appuntamenti ricorsivi messi a punto per seguire gli sviluppi di un’emergenza, non deve sorprendere che nella costruzione di questi racconti si rinvengano spesso tentativi di drammatizzazione dei fatti riportati, con cronache dominate da un potente carico emotivo e spettacolare.
In una tragica e del tutto imprevedibile circostanza, nel caso di Videogruppo è il disastroso incendio divampato presso il Cinema Statuto di Torino il 13 febbraio 1983 a offrire all’emittente la possibilità di manifestare e rafforzare la sua vicinanza alla popolazione cittadina. È il tardo pomeriggio di una nevosa domenica d’inverno, e le fiamme, innescate da un cortocircuito, invadono la galleria e la platea della sala, causando la morte per asfissia di 64 persone. La notizia del rogo giunge nella redazione del canale, che prontamente invia una troupe sul posto, allestendo una diretta straordinaria; poco dopo l’intervento dei vigili del fuoco, le riprese all’esterno del cinema, inframezzate dalle voci incredule di tecnici e operatori e dal rumore dei mezzi di soccorso, documentano l’orrore dell’incidente, con decine di salme accatastate sui marciapiedi. Il materiale visivo si offre al telespettatore con una scarsissima mediazione giornalistica, come se il pubblico diventasse testimone oculare dell’evento e delle sue conseguenze.
INSERIRE DI SEGUITO
1.Inserire video Servizio sull’incendio del cinema Statuto. Ripresa delle salme all’esterno del cinema
https://historica.unibo.it/bitstreams/871ea0eb-774c-434f-a52f-dce961c81b20/download
Le telecamere di Videogruppo, per mezzo di alcuni gruppi elettrogeni messi a disposizione dalle forze dell’ordine, riescono persino a varcare uno degli ingressi, sotto ciò che rimane dell’insegna retroilluminata: poltrone di velluto disintegrate, tendaggi inceneriti, vie d’uscita bloccate o prive di maniglioni antipanico. Le polemiche, relative soprattutto all’obsolescenza degli impianti, giungono puntuali, tanto che l’“incendio allo Statuto” segna una svolta nella revisione delle normative in materia di sicurezza nei locali pubblici anche grazie al reportage del canale piemontese, che batte sul tempo i colleghi della sede regionale Rai. Come confermato da numerosi testimoni, per il servizio pubblico non c’è altra alternativa che richiedere a Videogruppo qualche estratto di quella lunga diretta da integrare nei propri telegiornali: si ripresenta quanto avvenuto il 9 maggio 1978, quando il video del ritrovamento del corpo di Aldo Moro in via Caetani reca il logo di una piccola emittente romana, GBR, oppure, poco dopo, con il filmato dell’attentato al Papa in piazza San Pietro, raccolto da PIN – Primarete Indipendente. Pochi giorni dopo il rogo, il 16 febbraio, è la volta dei funerali delle vittime, che Videogruppo segue in una lunga diretta no-stop che modifica la sequenza abituale di trasmissioni. È un momento di grande dolore: la catastrofe ha una vasta eco emotiva (c’è chi arriva a paragonarla alla tragedia di Superga), e alle esequie presenzia anche il Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Federico Peiretti raccoglie i commenti dei torinesi all’arrivo dei feretri.
INSERIRE DI SEGUITO
Inserire video Servizio sull’incendio del cinema Statuto. L’arrivo delle bare in Duomo e i commenti dei torinesi
https://historica.unibo.it/bitstreams/ec89777c-4458-4164-b38d-33252f60cfb6/download
Urla strazianti accompagnano il lungo corteo funebre all’ingresso del Duomo, mentre Laura Cerro punta il microfono sui tanti cittadini accorsi per un attimo di raccoglimento, che non sempre accolgono con benevolenza l’intrusione delle telecamere. Lo zoom indugia sui loro volti, mentre è la stessa giornalista a comparire in video, nel tentativo di donare credibilità ed empatia al servizio.
INSERIRE DI SEGUITO
Inserire video Servizio sull’incendio del cinema Statuto. Impressioni dei torinesi
https://historica.unibo.it/bitstreams/a3b93760-49ab-4b64-89d4-58f3170d2118/download
Cambiano la congiuntura storica e la localizzazione geografica, ma restano validi molti meccanismi qui individuati quando nell’aprile 1987 un altro fatto di cronaca locale occupa ore di diretta su Sardegna 1: il mercantile Ricky Lift, 565 tonnellate di stazza, si incaglia nel tratto di mare davanti a Capo Carbonara, in prossimità dell’Isola dei Cavoli. L’equipaggio è in balia delle onde, mentre l’imbarcazione sbatte sugli scogli e la sala macchine è irrimediabilmente allagata: l’emittente cagliaritana attribuisce da subito grande considerazione alla notizia, che ben si presta a essere approfondita nel suo svolgersi, con gli aggiornamenti sulle condizioni dei marinai e i tentativi di soccorso. Parte l’SOS verso la capitaneria, sono lanciati i primi razzi di segnalazione, mentre alcuni pescherecci provano invano a raggiungere l’imbarcazione in panne prima che venga dichiarata l’emergenza. L’equipaggio è tratto in salvo grazie all’intervento degli elicotteri militari. Le immagini delle manovre di recupero, così rocambolesche, sono di forte impatto, e Sardegna 1 copre ogni fase della vicenda con lunghi moduli straordinari che dilatano la tenuta dell’evento, secondo una strategia mutuata dai network all news a stelle e strisce.
Il 7 aprile 1987 sono passati tre giorni dalla messa in sicurezza del personale di bordo, ma l’edizione flash del telegiornale del mattino continua a dare ampio risalto all’accaduto, enfatizzandone il portato. In studio c’è Maria Luisa Busi, poi volto di spicco del Tg1, che con il suo stile garbato ed essenziale tiene anzitutto a rassicurare il pubblico: il carico di 560 tonnellate di resina sintetica riversatosi in mare non costituisce pericolo di inquinamento, mentre gli inquirenti sono già al lavoro per “chiarire dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità”. Gli inserti grafici in chroma key aiutano il pubblico a orientarsi in questo sguardo sugli avvenimenti più importanti di quel lunedì di aprile.
INSERIRE DI SEGUITO
Inserire video Prima edizione del tg flash
https://historica.unibo.it/bitstreams/b4ed0d91-059c-4f5a-824c-54aa47f64646/download
Non tutte le notizie giungono a bassa intensità nelle redazioni per poi “crescere” nel giro di qualche ora: talvolta, gli accadimenti sono talmente significativi da spezzare il flusso tv e imporsi subito all’attenzione degli addetti ai lavori e del pubblico. È il caso, per esempio, dell’assassinio di Walter Tobagi, annunciato in diretta da TeleRoma56 durante una rubrica informativa curata da Lino Jannuzzi, il 28 maggio 1980. In pochi minuti, l’emittente romana stabilisce un collegamento telefonico con un giornalista della carta stampata, che fornisce il primo resoconto di quanto successo nella tarda mattinata in via Salaino, a Milano – la notizia, infatti, è inizialmente tenuta riservata, e diffusa dalle agenzie solo nel pomeriggio.
INSERIRE DI SEGUITO
Inserire video Collegamento di Lino Jannuzzi sull’attentato a Walter Tobagi
https://historica.unibo.it/bitstreams/f77dcb58-42ec-4de1-93ae-6222447a0d03/download
Dieci anni dopo, a poche settimane dallo scoppio della prima guerra del Golfo che TeleRoma56 segue sin dalle primissime fasi, l’emittente propone uno speciale Dossier sulla crisi mediorientale e sul leader del regime di Baghdad, Saddam Hussein. Il programma consiste in un approfondimento realizzato da Carlo Romeo, con puntate monotematiche, spesso preparate ad hoc in presenza di fatti dell’ultim’ora. Qui alcune sequenze raccontano l’avvio delle operazioni militari nell’area, con materiale di repertorio trovato sui circuiti esteri e interviste a rappresentanti di Iraq e Kuwait (19 settembre 1990).
INSERIRE DI SEGUITO
Inserire video “Dossier”, Servizio sulla crisi del Golfo Persico e su Saddam Hussein
https://historica.unibo.it/bitstreams/9b43920a-9287-45c4-a2e9-2fbbcc811cbf/download
L’istantaneità rappresenta la chiave di lettura di una copertura giornalistica così impostata, che consente alla rete televisiva della capitale di superare i confini dell’informazione locale, aprendo anche a notizie di carattere internazionale. Come ricorda nel 1994 lo stesso Romeo in un intervento su “la Repubblica”, “durante la Guerra del Golfo, mentre tutte le troupe televisive in Israele se ne stavano in posti tranquilli, TeleRoma56 era l’unica tv a trasmettere collegamenti in diretta telefonica sotto i bombardamenti di Tel Aviv”, confermando ancora una volta l’impegno della rete nell’offrire un’informazione tempestiva, pur con mezzi ridotti.
Il 23 novembre 1980 un sisma devastante colpisce l’Irpinia, tra Campania e Basilicata: 280.000 sfollati e oltre 3000 vittime, secondo le stime dell’epoca. L’intero apparato informativo nazionale mette in campo un ampio dispiegamento di strumenti e capacità professionali per seguire le notizie provenienti dalle zone colpite dal terremoto, che per lungo tempo attraversano tutti i canali e i mezzi di comunicazione, inclusa Antenna 3 in Lombardia: la catastrofe porta infatti la rete a rivelarsi sotto una luce inedita, abbandonando la sua tradizionale inclinazione ai generi più leggeri per concentrarsi interamente sui resoconti dell’emergenza. A poche ore dall’evento va in onda il consolidato appuntamento settimanale con il Bingooo: la struttura del gioco a premi è completamente rivista, mentre gli aggiornamenti sul sisma vengono trasmessi in tempo reale, delineando l’evento nel suo farsi, considerato che lo sciame sismico perdura per diversi giorni. Si tratta del primo adattamento dei palinsesti dell’emittente, che si estenderà per alcune settimane, con strisce quotidiane, programmi speciali e persino un documentario auto-prodotto che sostituiranno l’offerta abituale delle trasmissioni, comportando peraltro un’ingente perdita di ricavi pubblicitari, a riprova della buona fede alla base della scelta editoriale.
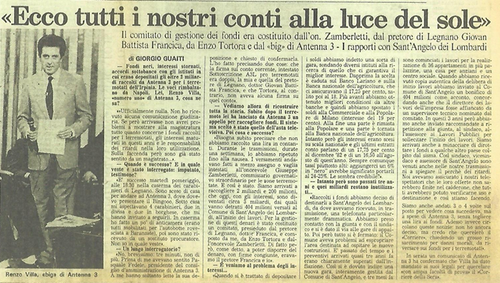
Le polemiche sulla gestione della raccolta fondi di Antenna 3 sulla stampa nazionale
Gli studi di Antenna 3 ospitano Aldo Guazzetti, allora presidente della Regione Lombardia, per illustrare il piano di aiuti messi in campo dalla Giunta regionale; ciò che più fa parlare di sé è però la gara di solidarietà lanciata dall’emittente che, come ricorda Renzo Villa, “nasce come nascono le cose da noi, con l’entusiasmo e il calore che accompagna le nostre iniziative, in mezzo alla gente, in un clima di partecipazione popolare”. Si avvia una vasta campagna di donazioni economiche, che raggiunge la cifra monstre di due miliardi di lire anche grazie alla vendita di oggetti e preziosi messi all’asta direttamente dal canale, che assegna ai battitori diversi moduli giornalieri di palinsesto. Subito si evidenzia la trasparenza dell’operazione, offrendo garanzie a telespettatrici e telespettatori riguardo la destinazione delle somme raccolte e le relative modalità d’incasso: Villa e Tortora ribadiscono in più occasioni che “le donazioni sono al sicuro, e non finiranno nel solito calderone oscuro”, richiamo esplicito all’ondata di corruzione che sarebbe venuta a galla nel decennio successivo. “Il Paese voleva vederci chiaro”, ricorda la vedova di Villa, Wally Giambelli, che fornisce anche alcuni dettagli sull’”adozione” del comune di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) da parte di Antenna 3.
INSERIRE DI SEGUITO
Inserire video Intervista a Wally Giambelli, La raccolta fondi per il terremoto in Irpinia (1980)
https://historica.unibo.it/bitstreams/db181815-7bfc-48e9-b1c8-273ee3ed06b9/download
L’emittente emiliana TeleSanterno riesce invece nell’intento di “fare rumore” e costruire un dialogo con le audience di riferimento attraverso un episodio accuratamente pianificato di falsificazione della realtà. È il febbraio 1979, ed Eugenio Marchi conduce una puntata de L’ora del topo, programma incentrato sulle nuove uscite letterarie e cinematografiche. In medias res, mentre si presenta un saggio sul paranormale, arriva la telefonata di un telespettatore che riporta la notizia di un non meglio specificato “atterraggio alieno” avvenuto nell’imolese, presso la località La Rocchetta. La trasmissione, che va in onda in differita, simulando la diretta, si protrae oltre il termine programmato: tutta l’attenzione si riversa su questa (presunta) invasione extra-terrestre, e il canale si mette immediatamente in contatto con inviati ed esperti che in studio commentano le immagini in arrivo dal luogo dell’accaduto, mentre in sovrimpressione e sui monitor di servizio scorrono mappe e dati esplicativi a supporto del racconto.
INSERIRE DI SEGUITO
video “L’ora del topo”, La notizia del presunto atterraggio alieno irrompe durante la trasmissione
https://historica.unibo.it/bitstreams/d1b1956c-517d-45a4-8fe4-07734ee46702/download
La telecronaca dello sbarco alieno è un’enorme messinscena ordita al cospetto del pubblico, ignaro che quanto (non) sta accadendo è in realtà un espediente per catalizzare l’interesse attorno all’emittente, agli esordi nel panorama televisivo italiano. L’espediente è efficace: la stampa locale dedica intere pagine all’accaduto, gli sponsor intuiscono le potenzialità pubblicitarie della rete, e il pubblico ne discute per giorni, in un’epoca in cui i misteri del cosmo, gli avvistamenti spaziali e l’idea di civiltà non terrestri catturano l’immaginario. La verità è svelata solo in un secondo momento, dopo sedicenti collegamenti satellitari con Ispra, Teleuropa Spazio e persino la base NASA di Pasadena in California, ricavati da filmati d’archivio dell’esercito italiano. Sguardo in camera e tono concitato, il conduttore disquisisce di “mezzi militari già schierati nell’Oceano Atlantico a difesa della popolazione, […] con missili a testata robotica pronti a entrare in azione”: nella provincia di Imola si scatena l’allarme, alcune auto si dirigono verso il fantomatico luogo dell’accaduto per verificarne l’autenticità e – capito il raggiro – la folla si rivolta contro i cronisti coinvolti nella rappresentazione, costringendo i carabinieri all’intervento.
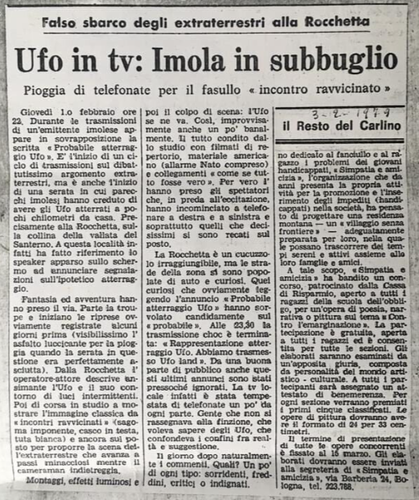
L’atterraggio alieno simulato da TeleSanterno sulla stampa nazionale
Nel caso delle breaking news, la tv locale è chiamata a un’opera di sintesi e semplificazione, codificando gradualmente l’evento al centro finestre straordinarie di programmazione. La narrazione del reale (o della sua simulazione) è modellata dal medium con un marcato valore memoriale e testimoniale che assume spesso sfumature patemiche. In un processo di ricucitura sociale, l’emittenza locale agisce da bussola e da calendario per il pubblico, sfruttando uno o più fatti di attualità per riunire comunità altrimenti frammentate. In questi casi, il broadcasting si fa valore condiviso: un’esperienza da vivere in sincronia, anche di fronte a emergenze, notizie dolorose o episodi destabilizzanti.
Percorso a cura di Emiliano Rossi (Università di Bologna)