Lo scrittore: il privilegio e il gusto di imbrattare pagine
Leonardo Vitali
Leonardo Vitali, attraverso un'analisi di scrittori statunitensi e canadesi, si domanda se le qualità letterarie di un autore o un'autrice siano innate oppure sviluppate attraverso la vita di società.
1. La nascita di uno scrittore
2. L'Innocenza per Mark Twain
3. Emily Carr e il paesaggio canadese
4. Henry James, l'americano inglese
5. I misteri di Edgar Allan Poe
6. Margaret Atwood racconta Susanna Moodie
7. Conclusioni
8. Bibliografia
1. La nascita di uno scrittore
Lasciarsi trasportare lontano, l’illusorio abbandono della percezione del “già visto”, vivere emozioni di seconda mano. Così potremmo sommariamente riassumere l’esperienza del lettore. Decisamente più complesso è immedesimarsi per cogliere lo stato d’ animo di colui che produce il testo, che estrapola dalla propria esperienza personale per poi riproporre, in chiave più o meno universale ma certamente irreale. Alla base dei due processi ritroviamo in entrambi i casi l’umana pulsione all’allontanarsi dall’io. Nel tempo gli uomini hanno sempre trovato poco appagante la loro condizione: chi sceglie la via dell’ebbrezza dionisiaca, chi si rifugia nei castelli di carte dell’apollineo. Ciò che comunemente chiamiamo "arte" la dobbiamo a coloro che possiedono, oltre che una sensibilità indubbiamente necessaria, le abilità tecniche e pratiche per costruire, almeno in parte, una finzione in cui rifugiarsi, in cui essere giudice, boia e imputato al tempo stesso, per riacquisire il controllo sul mondo che per sua natura sovrasta l’individuo.
Ma quando nasce un autore? Il segreto della grandezza è racchiuso nel DNA? Nature or nurture? Per cercare di fare luce su questo quesito, nel seguente saggio verranno prese ad esempio alcune delle penne più illustri del continente nord americano quali Poe, Twain e Iriving per quanto concerne gli Stati Uniti; Emily Carr e Susanna Moodie invece andranno a prestare voce al Canada. Senza dubbio sono voci molto differenti per stile e contenuti, quindi per tracciare un filo conduttore in questo coro eterogeneo, dobbiamo tornare a quell’ età in cui lasciarsi illudere è ancora lecito senza vergogna: l’ infanzia. Quanto potere abbia l’immaginazione sugli uomini è evidente sin da bambini. Questo elemento invisibile ci accompagna sin dalla tenera età all’interno dei rami che, imbracciati da piccoli guerrieri, prendono l’aspetto di minacciose durlindane; attraverso i colori a tempera muta il nostro DNA, tramutandoci in fiere feroci o leggere farfalle, che la notte rapprende il buio in artigli pronti a ghermirci da sotto il letto.

La fantasia riempie i vuoti come un fluido che si adatta al contenitore, ma quando quest’ultimo comincia ad essere riempito di verità, attraverso il naturale processo di acquisizione di esperienze verso l’età adulta, lo spazio disponibile diminuisce. Quello che a molti sfugge è il fatto che ciò che riempiva il contenitore prima non viene perso, bensì si compatta e, a differenza di un liquido, si raffredda. L’immaginazione di un adulto non è minore di quella di un ragazzino, come ci ricorda Irving nel suo racconto breve, Il Mistero di Sleepy Hollow (Il mistero di sleepy Hollow e altri racconti, W.Irving). Il protagonista, nonostante ricopra la posizione del maestro, ci viene descritto come un uomo un poco immaturo, privo di pulsioni erotiche o di arrogante arrivismo, ma carico di paure fondate su sciocche superstizioni e con un insaziabile appetito per tutto ciò di gustoso gli venga offerto.
Caratteristiche che si aspetterebbe più dal giovane Huck di Twain (Le avventure di Huckleberry Finn, M. Twain), anch’egli molto superstizioso, piuttosto che da un uomo adulto. Ma nonostante l’età della ragione, il protagonista arriverà a farsi suggestionare tanto da lasciarsi ridicolizzare dal suo rivale in amore, a tal punto da preferire la fuga piuttosto che affrontare le conseguenze del suo essersi lasciato ingannare. Da ciò che in apice del racconto ci vien fatto sapere, Ichabod Crane, dopo gli avvenimenti descritti riuscirà ad ottenere una carica prestigiosa, che probabilmente male si adattava all’immaturo professore di provincia di un tempo. Il potere della fantasia si può ritorcere contro nel lampante esempio qui sopra descritto, ma che dire della convinzione di superiorità di una razza rispetto ad un'altra senza alcuna prova scientifica? Questa è ciò che si può definire fantasia fredda, statica a differenza di quella della fanciullezza. Gli adulti scambiano per dati acquisiti quel briciolo di irrealtà che si insinua tra le intercapedini del nozionismo. Ma il bambino, salvo casi eccezionali, non è ancora in grado di espandere quel suo regno di finzioni oltre i confini dell’Io per raggiungere un pubblico. Il passaggio dall’infanzia all’età adulta è inframmezzato da una sfumata adolescenza, durante la quale attraverso un costante scontro tra reale e personale si va formando la personalità dell’individuo. Grazie alla peculiarità propria della razza umana di racchiudere l’infinito sotto un guscio di noce e di far esplodere il micro nel macro, possiamo riconoscere nell’800 quell’età di transizione tanto cara ai nostalgici.
2. L'Innocenza per Mark Twain
Erano gli anni della grande rivoluzione industriale, il mondo si rimpiccioliva sotto i piedi, le industrie sorgevano come cattedrali a monumento della nuova ideologia dominante: il denaro. Mentre l’Europa si godeva la propria opulenza, ignara di cosa sarebbe accaduto proprio al massimo picco del benessere, nel nuovo mondo nazioni giovani, ma non meno lanciate nella corsa all’accumulo, partorivano una generazione di malinconici.
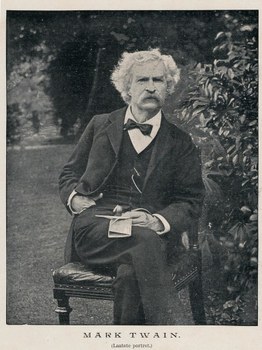
Più avvilito di Bentivoglio in Tournée (Tournée, G. Salvatores), Mark Twain è il signore incontrastato dei nostalgici. Figlio del mito della frontiera e cresciuto sui battelli a vapore che solcavano il Mississippi, attraverso la guerra di secessione e i frequenti viaggi all’estero (Innocents Abroad or The New Pilgrim Progress, M. Twain, 1869), maturò in lui la consapevolezza che la corrente che stava trascinando il mondo, questa volta era troppo forte per riuscire a evitare lo schianto contro il secolo decimo nono. Nella sua opera di maggior successo, Le Avventure di Huckleberry Finn, il protagonista non è il già popolare ed eterno fanciullo Tom Sawyer, bensì il controverso outsider sociale Huck. Archetipo dell’adolescente, il protagonista fin dalle prime battute si scontra con la vita borghese, timorata di dio, la “civiltà”(?) che lo circonda. Si ha una rottura con tutte le istituzioni, dalla famiglia alla scuola. Esse vanno strette al giovane che incarna il turbamento di una nazione che si sovrappone ad una realtà tanto reale quanto immaginata come la frontiera. L’idea di una nazione, di confini politici, tagliati su una terra tumultuosa, viva, lontana dallo sguardo severo dei sovrani europei. Il sogno che si assoggetta alle regole di mercato, la libertà che passa attraverso un valore quantificabile in numeri.
Mentre in Europa, autori del calibro di Balzac, ritenevano il denaro forza motrice della storia, Twain pare non credere all’innocenza della ricchezza (Perché leggere i classici, I. Calvino; cap. Mark Twain, L’uomo che corruppe Hadleyburg). Essa fa leva sugli istinti più bassi e in quanto tali, comuni ad ogni uomo; dal rispettabile cittadino della provincia al più ingenuo degli schiavi. Jim, fuggiasco compagno di viaggio del giovane Huck, nella sua semplicità d’animo e pensiero (dialogo sui re nel capitolo XXIII) comprende, inconsciamente come ogni creatura di Twain, che il linguaggio universale compreso sia dai bianchi che dai neri è la moneta. Egli quando parla del proprio valore, anziché concentrarsi sugli aspetti imprescindibili della propria persona, si quantifica/identifica nel valore di mercato affibbiatogli dalla società schiavista del sud. Questa idea di essere quanto si è valutati , purtroppo non è una mistificazione letteraria bensì un’idea comune tra gli schiavi che cercano riscatto.
Come nel caso di Equiano che nella sua epopea tra Africa, Europa e Americhe ci mostra come la realtà dei valori sia in effetti effimera e soggetta a interpretazione. Nella terra della corporeità nera, paradossalmente, il denaro non ha valore se non in rapporto al colonizzatore. Quest’ ultimo, superbamente, è convinto che grazie alla propria opera possa “insegnare” ai popoli inferiori quelle virtù tanto care ai pensatori occidentali (lista di Franklin). Un maturo Equiano racconta invece di come quelle leggi umane, ritrovabili nei sacri libri parlanti, fossero già intrinsecamente presenti nella cultura africana, declinati negli usi e costumi della propria terra. Vivendo a stretto contatto con la cultura dominante, lo schiavo tenuto in condizione di inferiorità intellettuale, è convinto di essere “lavato” da una non meglio definita colpa, così per riscattarsi agli occhi del -ma anche rivalersi sul- padrone si adatta alla cultura utilitaristica del mercato (Canoni americani, A. Portelli; cap. Olaudah Equiano e Chi è che non è schiavo? Sull’ universalità di Frederick Douglas).
Nuovamente Twain, agnostico pensatore, mente eclettica che spazia dalla scienza (Amicizia con Tesla, testi a sfondo scientifico come Un americano alla corte di re Artù) all’impegno sociale (posizioni anti-schiaviste, sostenitore dei diritti delle donne (The votes for women) e contro la pena di morte (Cronaca di un'impiccagione), si dimostra uno degli intellettuali più controversi della sua epoca quando afferma:
Io non ho pregiudizi di razza, di casta o di religione. Tutto quel che m'importa sapere di un uomo è che sia un essere umano: questo mi basta...non potrebbe essere niente di peggio (lettera non pubblicata al redattore de The American Hebrew, 1890).
Twain non impone con rabbia questa sua delusione al prossimo, piuttosto crea un mondo in cui, seppur vigono le leggi umane che regolano la realtà, in esso si può tentare di fuggire da esse. Così senza che Huck se ne accorga, l’autore gli mette in testa il germe dell’indipendenza intellettuale, nonostante sia zotico, poco istruito, il giovane supera la barriera della razza, con un accenno di toni fin troppo sentimentali (non al punto di intravedere un'ambiguità sessuale, come teorizza Leslie Fiedler in Come Back to the Raft Ag'in, Huck Honey!, 1948) o assimilando la gentilezza di Jim allo Zio Tom, richiamando più caratteristiche materne che virili (A. Portelli, Canoni americani, "Un eroe della resistenza, Uncle Tom’s cabin") ma che ben si adattano all’età delle passioni del giovane protagonista e del suo conflittuale rapporto con il padre.
Ciò che distingue Twain da molti è la sua capacità di astrazione dalla propria creatura. Riesce a dare al personaggio una linfa vitale propria, che pare quasi sfuggirgli di penna e, mentre l’incessante scorrere del fiume si intreccia con quello dell’inchiostro sulla carta, perdiamo sempre più di vista il mondo in cui si muoveva lo scrittore: una realtà positivista, che si rassicurava contando i profitti, ma che non finiva di convincere quel ragazzino latente a cui era permesso di valutare il valore delle azioni dall’alto della propria ingenua, fallace ma concessa prospettiva.
Le Avventure di Huckleberry Finn non è un libro per ragazzi, bensì un libro per uomini che furono ragazzi e che non hanno dimenticato mai la sana irrequietudine che proviene dal voler filtrare il mondo attraverso i propri occhi, e non il contrario.
3. Emily Carr e il paesaggio canadese
La stessa irrequietudine adolescenziale la possiamo trovare nel perpetuo pellegrinare di Emily Carr. Anche lei, vissuta a cavallo tra i secoli della maturità, figlia della massima espressione della macchina umana che era all’epoca l'impero coloniale britannico, errò in cerca di sé per tutta la vita attraverso the stunning landscape offerto dalla wilderness canadese.

Anello di congiunzione tra arte e letteratura, Emily spese la sua giovinezza errando tra i nativi in cerca dell’ispirazione e dei soggetti per la sua pittura. Dalla scelta di ritrarre quelle realtà lontane dalla concezione occidentale del mondo, filtrandole attraverso i propri occhi, fortemente influenzati dalla corrente post-impressionista, possiamo già notare due livelli di rottura con la realtà comunemente percepita.
Quando costretta a letto dalle condizioni di salute e non le sarà più possibile muoversi materialmente, attraverso la stesura delle sue memorie si avventura nel mondo doppiamente irreale del ricordo. Ne scaturisce una serie di racconti chiusi (Klee Wick, 1871) che coralmente vanno a comporre la melodia di una storia che vive delle distorsioni imprescindibili dell’esperienza umana rievocata dal ricordo (La passione e la ragione, G. de Luna cap. Le fonti). È grazie a questo espediente che si riescono a metabolizzare istanti di una vita spettatrice di grandi sofferenze, dalla mortalità infantile tra le tribù indiane alla consapevolezza che attraverso l’opera di civilizzazione dell’europeo, si va perdendo un modo di rapportarsi al tutto senza nemmeno averlo osservato con la giusta curiosità. Passando attraverso gli occhi dell’anziana Emily ci troviamo in compagnia della giovane durante il suo errare sensibile a ogni percezione.
Ecco allora che in momenti duri del suo viaggio, anche provata fisicamente, non perde l’occasione di raccontarci il mondo attraverso diversi sensi, rendendo più coinvolgente e realistica la finzione in atto, smarrendo anche i più testosteronici dei lettori nella prospettiva frustrata di un animale in gabbia. Così pare che alla fine dell’800 si avvii una progressiva perdita della libertà intellettuale umana che porterà all’attuale stato delle cose in cui l’idea perde di valore se non applicabile all’immanenza del mercato. È forse dunque finita l’epoca degli eroi che galoppano tra il mito e il reale, tra la “prateria lampante prova di dio” (Bufalo Bill, F. De Gregori) e quella frontiera irreale infinita possibilità costante, orizzonte inarrivabile, skyline metafisico al di là della staccionata? No. Era solo un nuovo inizio.
4. Henry James, l'americano inglese
Contemporaneo sia della mai quieta Emily che del “sovversivo” Twain, Henry James fu la prova di come sia necessario adattarsi all’epoca in cui volenti o nolenti ci si trova a vivere. Per James la libertà dell’immaginazione è in stretta relazione con la fortune, intesa non come talento innato, bensì come la più pragmatica disponibilità di mezzi (Canoni americani, A. Portelli; cap. Henry james e la frontiera). In The portrait of a Lady la protagonista Isabel, giovane di buona famiglia, sembra trascorrere il tempo guardando al di là della siepe, “che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude” (L’infinito, G. Leopardi), fantasticando su quale frutto quest’oggi gli gustasse staccare dal ramo.

James concepisce le ristrettezze economiche come vincolo all’immaginazione, donandoci una protagonista che seppur potenzialmente illimitata, di fronte alla vastità di scelta che le è concessa dal fato, si paralizza a discapito della propria libertà. Quando, dunque, questo ideale così squisitamente americano finisce dove comincia quella del vicino? Quando invece è l’individuo stesso a tarparsi le ali? Presupposti sbagliati portano immancabilmente a conclusioni fuorvianti. James stesso, concentrandosi su come senza attrito il potere dell’ immaginazione possa espandersi ipoteticamente all’infinito, perde l’occasione di riflettere invece su quanto il non voler accettare un’imposizione possa essere spunto per la creazione di un mondo alternativo in cui rifugiarsi.
Nonostante questa grossolana omissione, grazie a una forma impeccabile e ai temi così cari all’elite intellettuale contemporanea, all’autore, già in vita, venne riconosciuto dalla critica e dal pubblico un talento indubbio, che lo portò a raggiungere una fama mondiale, riconosciuta anche nello scettico Regno Unito dell’epoca.
Certo, per dimostrare come il Novecento sia stato un secolo che ha dato paternità a una gran quantità di capolavori, sarebbe bastato portare ad esempio qualcuno tra i grandi illusionisti creatori di mondi che, anche grazie a nuove forme artistiche (diffusione del cinema e della radio), hanno saputo far sognare un pubblico sempre più vasto. Ma osservare un fenomeno senza cercare una causa che lo giustifichi sarebbe erroneo quanto accontentarsi di formulare teorie senza applicare mai il metodo empirico.
5. I misteri di Edgar Allan Poe
La fama di James impallidisce al cospetto di una figura che calcò il suolo americano già 50 anni prima: Edgar Allan Poe. Spesso Henry viene messo in antitesi con il suo più contemporaneo Mark, due delle massime figure di spicco all’origine della letterature americana, ma non bisogna dimenticare che a volte fortune and nurture si combinano, incuranti se il mondo è pronto o meno, dando origine a ciò che comunemente viene chiamato genio. Una vita costellata di lutti e la perpetua ed inspiegabile, agli occhi dello stesso, indifferenza degli altri intellettuali, hanno fatto di Poe uno dei più grandi escapologi della realtà di sempre.
La sua capacità di costruire castelli di carta così solidi anche a distanza di anni la possiamo ricondurre alla concezione stessa di reale che traspare dalle sue pagine. Tra i generi letterari che dobbiamo al maledetto di Boston, troviamo il giallo e il noir. Nel primo, il mondo è presupposto come ordine turbato da un omicidio ma grazie alle doti dell’ investigatore (Dupin), tutti i frammenti del puzzle ritrovano il loro giusto incastro, smascherando il colpevole.
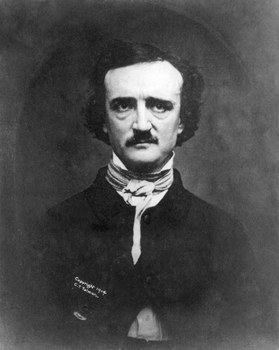
Questa sua virtuale possibilità di mezzi senza limiti paradossalmente provoca un’immobilità dell’inchiostro sulla pagina. Nel noir invece avviene il processo inverso: narrato dal punto di vista del criminale la realtà circostante è presentata come un guazzabuglio da far rientrare all’interno della logica di un piano malvagio.
Ora, non importa quale prospettiva il lettore prediliga, ciò che è interessante osservare è come l’autore abbia saputo lavorare su binari apparentemente in antitesi. La risposta è fornita dall’autore stesso nel saggio la filosofia della composizione in merito alla sua poesia più celebre, il corvo.
Nonostante i critici (Introduzione di Raul Montanari a Il corvo e altre poesie, 2009 Feltrinelli editore Milano) siano scettici nell’accettare le parole di Poe, che sembra limitare l’orogenesi poetica a una summa di accorgimenti tecnici, non va dimenticato come l’autore parta dall’idea di trasmettere una sensazione e, in seguito, mettendo mano al proprio bagaglio di conoscenze, trova la soluzione che meglio riesce nel suo intento.
Il giallo e il noir non sono quindi che l’esempio più pratico di scomposizione della realtà al fine di acquisire quei mattoni necessari per ricostruire a proprio piacimento quei processi atti a stimolare una specifica reazione, esattamente come Hitchcock che mettendo in secondo piano la realisticità del narrato, predilige l’uso della macchina per raggiungere lo scopo. Percepire la realtà non come un’entità unitaria ma come insieme di fotogrammi incisi dietro gli occhi:
O la storia offre una tesi; o ce n’è una suggerita da un fatto del giorno; oppure tutt’al più, l’autore si ingegna a mettere insieme avvenimenti interessanti (La filosofia della composizione, E. A. Poe).
6. Margaret Atwood racconta Susanna Moodie
Esattamente ciò che fa Margaret Atwood nei The journals of Susanna Moodie. L’autrice contemporanea si lascia ispirare dalla lettura delle memorie di una donna di duecento anni fa per la composizione di una forma artistica così personale come la poesia.

Si immedesima negli eventi reali narrati per poi rielaborarli attraverso la propria sensibilità, al fine di analizzare quella schizofrenia latente che la Atwood (The journals of Susanna Moodie, Margaret Atwood, Afterwords), riconosce nell’esperienza letteraria canadese.
Per fare ciò costruisce una fantasia, che potremmo definire realtà alternativa in quanto, non si limita a ricreare gli avvenimenti, ma anche i mutamenti che essi provocano nell’animo di una protagonista che comunque aveva già espresso il proprio punto di vista a differenza del viaggiatore nel tempo inventato ad hoc che Irving ci propone in Rip van Winkle (Il mistero di sleepy Hollow e altri racconti, W. Irving).
Ciò però non è applicabile all’ultima parte della raccolta in cui, immaginandosi uno spettro che infesta le strade di Montreal, come un moderno Tiresia (The wasteland, T.S. Elliot), non si riconosce nel paesaggio offerto dalle città del ventunesimo secolo.
7. Conclusioni
Eccoci dunque all’orizzonte, sottile linea di confine tra realtà e sogno. Due parti dello stesso intero, in continuo scambio: ciò che non è, può essere, ciò che è potrebbe essere differente. Lo scrittore è colui che riesce a fondere la sensibilità del fanciullino (Il Fanciullino, G.Pascoli), gli slanci di petto dell’adolescente nella concezione del reale di un adulto. Solo chi capisce profondamente ciò che non funziona comprende che “l’essenziale è invisibile agli occhi" (Il piccolo principe, A. Saint-Exupéry), è necessario essere consci che esista qualcosa al di là della mera luce.
Questo forse è il problema dell’epoca che stiamo attraversando, siamo talmente pervasi di luce che non è più possibile riconoscere le forme, distinguere ciò che è reale dall’indottrinamento. Se si è disposti a fare del materialismo un’ideologia, la speranza è che si possa, tramite processo contrario, fondere l’irreale nel mondo, sintonizzando pubblico e autori in un processo biunivoco. Letteratura non come fuga bensì come alternativa, per ricordarci che un’altra strada è possibile. “Ora, più che mai, dobbiamo essere tutto quello che possiamo essere” (L’ uomo che fissava le capre, Grant Heslov) perché sono “gli occhi a creare la luce” (The journals of Susanna Moodie, Margaret Atwood, solipsism while dyng).
8. Bibliografia
Atwood M., The journals of Susanna Moodie, 1970
Calvino I., Perché leggere i classici, 1991
Elliot T.S., The wasteland, 1922
Fiedler L., Come Back to the Raft Ag'in, Huck Honey!, 1948
Heslov G., L’ uomo che fissava le capre, 2009
Irving W., Il mistero di sleepy Hollow e altri racconti, 1819
Pascoli G., Il Fanciullino, 1897
Poe E. A., Il corvo e altre poesie, 2009
Portelli A., Canoni americani, 2004
Saint-Exupéry A., Il piccolo principe, 1943
Salvatores G., Tournée, 1990
Twain M., Innocents Abroad or The New Pilgrim Progress, 1869
Twain M., Le avventure di Huckleberry Finn, 1884
Foto 4 da ipsalegit.blogspot.com (data di ultima consultazione: 30/08/2021)