
Scavo della necropoli meridionale di Phoinike
Storia degli scavi e riflessioni archeologiche
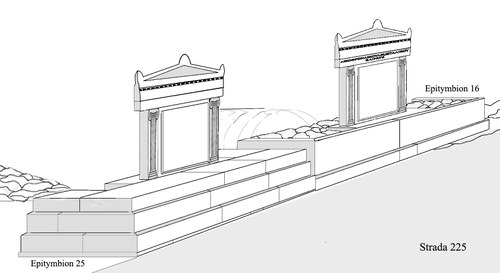
La necropoli meridionale di Phoinike, situata nel cuore della Caonia, si pone come uno dei contesti funerari più significativi dell’Epiro antico per l’ampio arco cronologico attestato – dal IV sec. a.C. al III sec. d.C. – e in virtù della ricchezza dei dati restituiti, che riflettono fedelmente le trasformazioni politiche, culturali e urbane dell'intera regione.
Il sito è descritto in condizioni di abbandono e in alcuni casi compromesso già da Luigi Maria Ugolini nel 1927 ed ha conosciuto una nuova e sistematica stagione di indagini ad opera del progetto Archeologia della morte in Illiria ed Epiro a partire dal 2001. Le ricerche, condotte con metodo stratigrafico hanno privilegiato un approccio conservativo, documentando per mezzo del disegno manuale coadiuvato dalle nuove tecnologie per la ricostruzione dei piani d’uso e delle fasi di vita del sito.
A partire dal 2001, un’équipe congiunta italo-albanese guidata da Giuseppe Lepore e Belisa Muka si è dedicata allo scavo della necropoli, individuando un totale di 85 sepolture, tra inumazioni e incinerazioni, articolate lungo assi viari che confluivano verso la collina dell’antica Phoinike. Da queste sepolture sono state ricavate 151 deposizioni, corrispondenti a 114 individui ben conservati. I dati bioantropologici hanno restituito un profilo demografico ampio, comprendente adulti, subadulti e infanti, con una leggera prevalenza maschile e una distribuzione rituale diversificata nel tempo.
La necropoli costituisce un autentico palinsesto delle pratiche funerarie e devozionali che riflette le vicende storiche della città: dal sorgere del centro urbano nel contesto della symmachia epirota e del koinon federale, fino alla piena integrazione nell'orbita di Roma. I corredi tombali, talora ricchi e raffinati, evidenziano una commistione di influssi greci, illirici, italici e macedoni, a testimonianza del ruolo di Phoinike quale nodo di scambio tra Oriente e Occidente.
Il lavoro svolto in oltre un decennio di campagne ha permesso di tracciare con chiarezza l’evoluzione storica dell’area funeraria e di formare un’intera generazione di giovani archeologi albanesi e italiani, molti dei quali hanno dedicato le loro tesi ai materiali rinvenuti. Le operazioni di restauro, condotte tra il 2008 e il 2009 grazie al CRA (Centro per il Restauro Archeologico) e a finanziamenti privati, hanno reso possibile la conservazione e l’esposizione museale di alcuni dei corredi più significativi.
I risultati dello scavo, confluiti in un volume pubblicato nel 2018, restituiscono un quadro coerente e organico delle dinamiche funerarie, urbane e culturali dell’Epiro settentrionale tra ellenismo e romanizzazione, evidenziando al contempo il valore di Phoinike come testimone privilegiato dei processi di trasformazione del mondo balcanico.