Un taylorisme augmenté, Critique de l’intelligence artificielle
Juan Sebastian Carbonell, Editions Amsterdam 2025
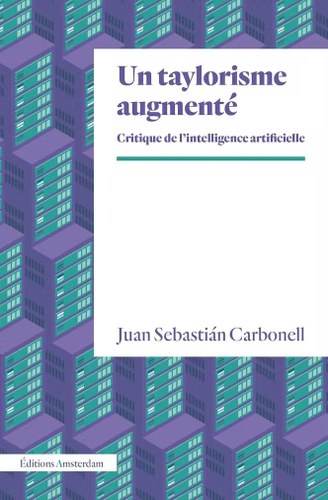
Nel suo nuovo saggio, Un taylorisme augmenté (ed. Amsterdam, 192 pagine), il sociologo del lavoro Juan Sebastian Carbonell ha deciso di intraprendere un altro percorso di studio, concentrandosi sull'impatto dell'IA sulla vita quotidiana dei lavoratori. Come stanno evolvendo l'organizzazione del lavoro, le condizioni di esercizio, ma anche l'autonomia nella realizzazione dei compiti? Che dire dei compiti svolti e delle conoscenze mobilitate?
Per l'autore, il quadro è cupo. Nel corso di questo libro critico, spiega perché l'IA è «uno strumento di degrado del lavoro nelle mani delle aziende», simile a un «taylorismo aumentato». A suo avviso, l'intelligenza artificiale tende a «semplificare, standardizzare o frammentare» le professioni, indipendentemente dal livello di qualifica richiesto per esercitarle. Gli addetti alla preparazione degli ordini possono subirne le conseguenze, così come gli oncologi. Allo stesso tempo, altri principi fondamentali del taylorismo, come "lo studio del tempo impiegato per ogni operazione o il cronometraggio", possono essere applicati, in particolare per i lavoratori delle piattaforme digitali, così come vari processi di sorveglianza. Soprattutto, il cuore del lavoro può essere profondamente sconvolto da ciò che Carbonell definisce una "spoliazione meccanica". Interessandosi all'impatto dell'IA generativa sulle professioni qualificate, egli dimostra che essa priva i lavoratori «dei gesti creativi del loro mestiere e li riduce al ruolo di "appendici". In altre parole, non è al loro servizio (...) e non li libera da compiti monotoni e poco interessanti; sono i lavoratori che sono messi al suo servizio ». I giornalisti possono così essere «espropriati della redazione degli articoli», un gesto che fino ad allora conservava «una dimensione semi-artigianale». L'avvento dell'IA li costringerebbe a esaminare i testi prodotti dalla macchina per individuare le imperfezioni di fondo e di forma. Un lavoro di "post-produzione" che può interessare anche i traduttori colpiti dall'arrivo di soluzioni automatizzate e che a volte aumenta il carico di lavoro. "Spesso è più difficile e richiede più tempo riformulare una frase errata che tradurre direttamente una frase difficile. » L'IA provoca una «dequalificazione» della professione, secondo l'autore. Il che si accompagna a una «precarizzazione». Uno studio condotto tra i traduttori nel 2022 ha infatti dimostrato che «la retribuzione del lavoro di post-editing è sistematicamente inferiore alle tariffe medie di traduzione». Cosa fare di fronte a questo deterioramento delle condizioni di lavoro, che si accompagna, osserva Carbonell, a un maggiore controllo sui lavoratori? Il libro invita alla «resistenza», attraverso una «rinascita luddista», in riferimento agli operai tessili inglesi che distruggevano le macchine all'inizio del XIX secolo. «Una tecnologia si impone soprattutto grazie alla superiorità degli attori che la promuovono», afferma. È quindi necessario avviare un rapporto di forza, con l'obiettivo di ottenere "il controllo sulla produzione, ma anche un controllo democratico sull'innovazione". Una "lotta" che potrebbe "aprire la strada, spera l'autore, a una riflessione su un'"altra IA"". Tenendo presente che ciò che è "tecnologicamente possibile" non è necessariamente "socialmente auspicabile".