Messbarger, La signora anatomista: vita e opere di Anna Morandi Manzolini,
Recensione a cura di Domenica Verducci
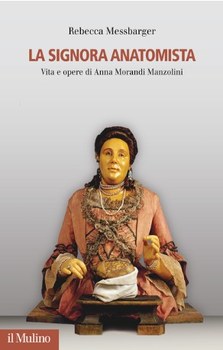
Il volume monografico “La signora anatomista” presenta la vita ed illustra le opere di Anna Morandi Manzolini, figura femminile nata e vissuta a Bologna tra il 1714 ed il 1769. Tra gli obiettivi di questo libro vi è indubbiamente quello di ridare spazio e dignità ad un personaggio della storia dell’arte e della medicina del XVIII secolo a lungo screditato e/o dimenticato. Proprio in questo senso, risultano particolarmente significative e d’impatto alcune parole con cui si apre il secondo paragrafo dell’Introduzione: “Anna Morandi fu in grado di superare le sue umili origini, un limitato percorso di formazione e diverse costrizioni, di carattere culturale e sociale, imposte alle donne e a persone provenienti dalle classi sociali meno abbienti, fino a diventare la più acclamata modellatrice di cere anatomiche dell’intera Bologna, città che nel XVIII secolo era celebre in tutta Europa quale centro di eccellenza sia negli studi di anatomia sia nella realizzazione di cere anatomiche. Tra i suoi patroni ed estimatori Morandi potè vantare papa Benedetto XIV, l’imperatore Giuseppe II d’Austria e Caterina la Grande. Eppure, nonostante il sostegno di personaggi illustri come questi, dal momento della sua morte e per oltre due secoli, fino al restauro realizzato nel 2000 dei suoi manufatti in cera, solo pochi articoli biografici le avevano tributato un ruolo nella storia dell’arte, così come in quella della medicina” (La signora anatomista: vita e opere di Anna Morandi Manzolini, R. M. Messbarger, Bologna, Il mulino, 2020, p. 13). Queste poche righe sono sufficienti per riassumere brachilogicamente e densamente la vicenda di Anna Morandi, in quanto vanno a segno nel nocciolo della questione e presentano alcuni tra i principali temi che verranno ampiamente sviscerati nel corso dei capitoli successivi del volume.
Punto di partenza per la ricostruzione di un ritratto della signora anatomista - che operò in pieno Illuminismo nella seconda città più grande dello Stato Pontificio - è un enorme lavoro svolto dall’autrice, Rebecca Messbarger, docente di lingua e cultura italiana presso il Department of Romance Languages della Washington University. Come ella stessa ha generosamente rivelato durante un suo intervento in occasione della tavola rotonda “La giornata di Anna Morandi. Il ritratto di una pioniera dell’anatomia”, durante otto lunghi anni di fase investigativa ha avuto la preziosa occasione di visitare archivi principali e minori, vecchie soffitte e cripte di chiese, magazzini di musei, monasteri, cimiteri, istituzioni governative e case private. Tale immensa ricerca delle fonti documentarie legate alla storia di Anna Morandi emerge chiaramente nel corso del volume, che risulta costellato di continui riferimenti bibliografici, perfettamente contestualizzati e che concorrono ad arricchire il testo e a spezzare il racconto delle dinamiche. Da tali fonti bibliografiche emergono innumerevoli dettagli e particolari che contribuiscono a raccontare, da un lato, in che modo venne percepita e giudicata la figura di Anna Morandi e, dall’altro, la sua fervida ambizione ed il suo desiderio di ottenere risultati di rilievo.
La ricostruzione operata dalla scrittrice è egregiamente inserita in una accurata e particolareggiata analisi storiografica, che considera il contesto culturale, storico, socio-politico e religioso in cui le competenze di ceroplasta e anatomista della Morandi poterono svilupparsi nella Bologna del XVIII secolo. Del resto, come sostiene la stessa autrice, la storia di Anna Morandi non avrebbe potuto svilupparsi in nessun’altra città, tant’è vero che Anna non si trasferirà mai all’estero, nonostante le svariate proposte ricevute.
Entrando nel vivo delle tematiche trattate, il capitolo introduttivo descrive in breve i primi anni di vita di Anna Morandi, mettendo in evidenza che non si sappia quasi nulla fino al suo ventiseiesimo anno di età, ossia a partire dall’evento destinato a cambiare il corso della sua vita: il matrimonio con Giovanni Manzolini (Bologna, 1700-1755), suo sposo e compagno di vita. È come se improvvisamente i riflettori si accendessero sulla figura di quella povera donna, fino ad allora invisibile agli occhi dei suoi contemporanei.
Prima di affrontare questo argomento, viene messo in evidenza il fatto che Anna Morandi e l’Istituto delle Scienze di Bologna siano nati a distanza di poco meno di due mesi: “Queste due date di nascita diedero il via a due diverse storie che, per breve tempo, si sarebbero incrociate. Ognuna, in un certo senso, contestualizzò ed ebbe ripercussioni sull’altra, determinando un momento di trasformazione nella storia culturale della città di Bologna” (Ivi, p. 18).
Nelle pagine successive si passano rapidamente in rassegna le principali tappe della vita della ceroplasta e si introduce un tema, che diventerà poi ricorrente nel corso dell’intero volume: la questione delle tematiche di genere. Per qualcuno una donna che fa scienza, “così determinata, rappresentava una minaccia, un’intromissione. Essendo peraltro dotata di un corpo inferiore, in quanto femminile, e dunque di uno sguardo impudente, diminuiva l’autorevolezza delle scienze anatomiche e dei suoi maestri che avrebbero dovuto essere tutti, per definizione, uomini” (Ivi, p. 41). Il suo avversario più convinto fu il professore bolognese di anatomia umana Petronio Zecchini (1739-1793), il quale teorizzava come la causa dell’inferiorità intellettuale delle donne fosse da ricercare nel sistema riproduttivo femminile, da lui definito “utero pensatore” (Dì genitali. Della dialettica delle donne ridotta al suo vero principio, P. I. Zecchini, Bologna, A. S. Tommaso d’Aquino, 1771). Zecchini culminò nell’affermazione che le donne e i loro intelletti sono soggetti al “furore uterino”. Per altri, fu invece la Madre dell’anatomia. Per esempio, il noto fisico e botanico Giovanni Bianchi (1693-1775) di Rimini sottolineava come la potenza della maternità vissuta ponesse la studiosa su un piano a sé stante e superiore, rispetto alla società degli anatomisti uomini: “Questo è come un prodigio in una donna, che non abbia a schifo d’essere Anatomica pratica […]. [Era] la prima Donna, che abbia atteso così di proposito alla Notomia pratica, e che partorendo figliuoli, e notomizzando cadaveri venga per certo ad essere nel metodo sintetico, e nell’analitico” (Lettera del Signor Dottor Giovanni Bianchi di Rimino scritta da Bologna ad un suo amico di Firenze, G. Bianchi, 21 settembre 1754, in Novelle letterarie pubblicate in Firenze, vol. XV, Firenze, Stamperia della SS. Annunziata, 1754, p. 711). Malgrado queste due posizioni estreme, espresse da Zecchini e Bianchi e molto discusse, è indubbio quanto la Signora Anatomista, una volta divenuta celebre, fosse in grado di catturare l’attenzione dei suoi contemporanei.
Nel primo capitolo, “Il museo del Papa”, proseguendo il discorso già intrapreso, si sottolinea come Anna Morandi sia stata in grado di opporsi alle tendenze culturali della sua epoca e di sfidare i “ruoli convenzionali di genere che, durante la Pubblica Anatomia tenuta una volta l’anno, vedevano un corpo femminile, in forma di cadavere disteso inerme sul tavolo di marmo, aperto ed esplorato in ogni sua parte dal professore anatomista. […] Sovvertì tali ruoli tradizionali, diventando lei stessa una docente di anatomia nella sua scuola-laboratorio” (La signora anatomista: vita e opere di Anna Morandi Manzolini, R. M. Messbarger, Bologna, Il mulino, 2020, p. 48).
A questo punto, si propone un focus specifico sulle figure di Laura Bassi (Bologna, 1711-1778) e Anna Manzolini, tracciandone analogie e differenze. Il tutto risulta ancora più interessante perché inserito in un contesto più ampio che è quello della prospettiva liberale di Papa Benedetto XIV: egli fu, infatti, un abile coordinatore della presenza femminile all’interno delle istituzioni accademiche, dal momento che incoraggiò le carriere accademiche di entrambe le donne entro un generale progetto di rinnovamento culturale dell’Università e, dunque, di riflesso, della città di Bologna.
Il capitolo successivo, “Professare l’anatomia”, si apre con una curiosa parentesi sulla scuola-laboratorio a casa dei coniugi Morandi-Manzolini: nello specifico, si descrivono accuratamente le varie fasi del loro lavoro quotidiano di dissezione dei cadaveri e ricostruzione dei vari organi, arti, muscoli, vene, e arterie stratum super stratum. L’autrice prosegue elencando i vantaggi di frequentare la scuola della coppia e le principali categorie di studenti e visitatori più assidui.
Il terzo capitolo, “Ricreare”, mette in campo diverse tematiche, alcune delle quali già presentate brevemente nell’introduzione del volume. Anzitutto, è illustrato il topos dell’improvvisatrice non istruita, di solito di umili origini, che all’occorrenza e dietro sollecito rivela la sua brillante capacità nelle arti e nelle scienze. Neanche Anna Morandi si sottrasse a questa tendenza e fu spesso giudicata, dai suoi contemporanei e per oltre due secoli, come una “dotata dilettante, una improvvisatrice in campo anatomico, reputando la fama da lei acquisita come un caso dovuto alla carriera del marito nell’arte della ceroplastica. Venne ritratta come una virtuosa priva di istruzione, il cui talento spontaneo emergeva semplicemente dietro comando” (Ivi, p. 14).
A proposito di questo argomento, la scrittrice apre una dettagliata parentesi sulla maniera in cui venne percepito il sodalizio tra Anna Morandi e Giovanni Manzolini dai suoi contemporanei: l’ingresso di Anna nel campo dell’anatomia fu visto come una conseguenza fortuita della sua devozione al focolare domestico, a Dio e al marito. In poche parole, Anna era la semplice aiutante di Manzolini, il marito che lei serviva, non solo nel mero ruolo di moglie, ma anche come disciplinata assistente nel laboratorio anatomico.
Il terzo ed ultimo argomento trattato in questo capitolo verte sulla prima commissione che i coniugi ricevettero da parte di Giovanni Antonio Galli (1708-1782), docente di Chirurgia presso l’Università di Bologna. Entrando nei dettagli, la coppia fu chiamata a realizzare venti modelli di uteri, placente e parti del sistema riproduttivo femminile affinché il professore li potesse utilizzare per le sue lezioni, tanto a casa, quanto presso l’Istituto delle Scienze. Finalmente nel 1757 il papa Benedetto XVI acquistò la collezione di strumenti ostetrici del Professore Galli e in questo modo i capolavori di Anna e Giovanni ebbero modo di varcare per la prima volta la soglia dell’Istituto delle Scienze. A tale riguardo, la Professoressa Messberger evidenzia come tali opere “rimasero sostanzialmente invisibili agli occhi di intellettuali e governatori di Bologna contemporanei, che si accorsero di lei solo quando cominciarono a giungerle tributi e segnali di fervida approvazione dall’estero, da accademici e dignitari europei, nonché da viaggiatori impegnati nel Grand Tour, che pian piano portarono finalmente il suo lavoro alla luce. Le cere anatomiche divennero, difatti, una delle numerose attrazioni cittadine” (Ivi, p. 14).
Il capitolo “La signora anatomista” si apre con un approfondimento dedicato all’autoritratto in cera realizzato da Anna Morandi e descritto dall’autrice come una vera e propria autobiografia. Esso rivela in tutta la sua potenza il modo in cui la donna percepiva se stessa e comunica svariati messaggi che vanno aldilà della mera opera e che sono difficili da cogliere per un occhio poco esperto che non conosce a fondo la sua storia.
A seguire, si racconta cosa accadde dopo la morte del marito: l’anatomista raggiunse la sua massima fama, in quanto donna che da sola aveva il coraggio e la forza di continuare ad insegnare in casa propria, ma soprattutto a dissezionare cadaveri. È in questo periodo che ricevette i massimi tributi e riconoscimenti, come la nomina a membro onorario dell’Accademia Clementina di belle arti di Bologna (1755) e la nomina di “Modellatrice e Dimostratrice Pubblica di Anatomia” dell’Università (1756). Come conseguenza di ciò, le venne concesso uno stipendio di 300 lire bolognesi. Sembrerebbe, dunque, che la donna fosse felice e navigasse nell’oro, ma in realtà il sussidio ricevuto era appena sufficiente per garantire la sopravvivenza sua e di uno dei suoi figli.
Prima di affrontare il racconto degli ultimissimi anni di vita, la scrittrice dedica un breve capitolo (“Esse est percipi. Mani e occhi”) alla serie degli organi di senso di Anna Morandi, divenuta la più famosa e celebrata dai numerosi viaggiatori del Grand Tour. Tale serie è chiaramente legata all’esperienza del corpo nell’ambiente circostante e proprio in virtù di ciò permette ad Anna Morandi di proporsi come contro-argomentazione alle teorie contemporanee sulla Scienze delle donne: attraverso sculture, dissezioni e scritti, ella dimostra di avere pieno controllo dei suoi sensi, “ai quali avrebbe dovuto essere assoggettata secondo le credenze diffuse all’epoca” (Ivi, p. 204).
Nel penultimo capitolo, intitolato “Sotto la foglia di fico”, viene ripreso il tema della polemica, alimentata da parte di Zecchini, sulla presunta inferiorità intellettuale delle donne la quale, secondo il suo punto di vista, sarebbe una conseguenza diretta delle loro funzioni riproduttive. Risulta evidente come nelle sue parole è insito un celato attacco nei confronti di diverse figure a lui contemporanee: la fisica Laura Bassi, la matematica Maria Gaetana Agnesi (Milano, 1718-1799) e, in particolare, Anna Morandi. Proprio quest’ultima si contrappone alla misoginia e rappresenta un fatto eccezionale: osa condurre uno studio teorico del sistema riproduttivo e degli organi genitali maschili.
Infine, il settimo ed ultimo capitolo “Cessio ac venditio”, come perfettamente riassunto dal titolo, racconta l’atto finale della vita di Anna Morandi la quale, alla luce delle gravi difficoltà fisiche ed economiche, si mostrò incline ad accettare un’offerta ricevuta dal conte Girolamo Ranuzzi (Bologna, 1724-1784): il nobile bolognese esperto in affari, approfittò della situazione della ceroplasta per proporle di acquistare la sua intera collezione. In questo modo, egli ambiva a trarne profitto, accrescendo il suo status e prestigio personale. L’anatomista divenne così una delle principali attrazioni del palazzo e potè finalmente vivere una vita agiata e confortevole grazie alla fama raggiunta. Durante gli anni a palazzo, Anna si dedicò soprattutto alla produzione di copie degli stampi in gesso di opere già realizzate precedentemente. Infatti, è da considerarsi altamente improbabile che abbia continuato a dissezionare cadaveri e a insegnare anatomia a studenti di medicina: verosimilmente Ranuzzi aborriva l’idea di un flusso costante di porzioni di cadaveri provenienti dall’obitorio cittadino.
La storia di Anna Morandi ha un epilogo glorioso: difatti, appena otto mesi dopo la sua morte, avvenuta nel 1784, il conte Ranuzzi scrisse al Senato di Bologna per vendere l’intera suppellettile manzoliniana. In questo modo, si venne a realizzare il più grande sogno che la donna nutriva, come racconta l’amico Luigi Galvani (Bologna, 1737-1798) con il quale si era confidata: “Ciò che questa nostra Accademia ed i Dotti tutti quanti e la Cittadinanza intera e noi pure massimamente desiderammo e cioè che venissero finalmente collocate in questa sede delle Arti e delle Scienze le parti del corpo umano plasmate in cera da quell’Anna Manzolini che di gran lunga superò quanti Artisti la precedettero, […] noi moltissimo ce ne rallegriamo. […] Mi diceva che, morendo, solo di questo molto si sarebbe rattristita, di non aver ancora certa e bastante conoscenza sulla possibilità che i suoi cittadini potessero usufruire in perpetuo della sua attività e delle sue fatiche, scopo a cui soprattutto aveva mirato” (De Manzoliniana suppellectili, G. Galvani, Bologna, 1777, in Opere edite ed inedite di Luigi Galvani, S. Gherardi, Bologna, Tipografia di Emidio dall’Olmo, 1841, p. 109).
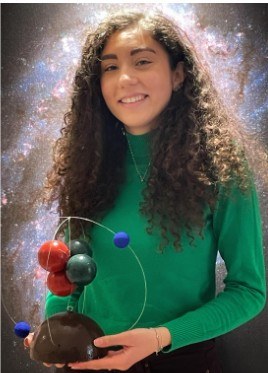
Domenica Verduci ha conseguito una Laurea Magistrale in "Didattica e Comunicazione delle Scienze Naturali", all'interno della quale ha selezionato il curriculum in Comunicazione delle Scienze nei Musei. Ha frequentato anche un Master di primo livello in Comunicazione scientifica presso l'università di Parma.
A seguire, è diventata una borsista di tipo junior presso il "Museo Storico della Fisica Enrico Fermi" ospitato nella celebre palazzina di via Panisperna: si è occupata dell'ideazione e implementazione di attività all'interno della linea di ricerca "Portare la Scienza nelle scuole e nella Società".
Infine, è risultata vincitrice di una borsa di dottorato in Storia della Scienza presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università di Bologna. Supervisionata dai docenti Marco Beretta e Sandra Linguerri, porta avanti un progetto intitolato "Cronache museali: la storia della fisica del Novecento a Roma attraverso le collezioni scientifiche, i luoghi, le istituzioni, i protagonisti. Un ponte tra passato e futuro per la conservazione, la divulgazione, il dialogo e l’orientamento delle nuove generazioni".