Lobaccaro, "Ai confini del senso. La schizofrenia tra semiotica, psicopatologia e scienze cognitive"
Recensione a cura di Tommaso Bigatti
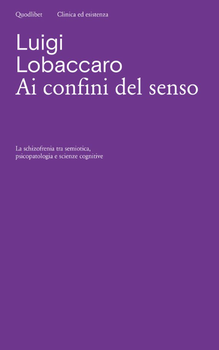
Fra i diversi sconvolgimenti che possono stravolgere l’animo umano, pochi sono quelli che si configurano con una tale radicalità ed estraneità quanto la schizofrenia, assurta col tempo a divenire emblema e sinonimo della follia stessa: di essa si ignorano le cause e, per molti versi le dinamiche, per questo c’è chi ne ha parlato come della “sfinge della psichiatria” (Borgna 2019) – essa è, per riprendere una celebre formula di Rudolf Otto, un mysterium tremendum et fascinans (Otto 2018). A renderla tale è il fatto che essa sia una forma di disturbo onnicomprensivo, che stravolge la produzione e la ricezione di senso da parte del soggetto e che “colpisce tutti quegli elementi che la cultura occidentale utilizza per descrivere la soggettività umana: la razionalità, la capacità di oggettivare il mondo e la capacità di riconoscere e dominare i propri stati emotivi” (Lobaccaro 2024: 31). Una tale perdita dei caratteri considerati essenziali per determinare l’umano – che appunto, da Aristotele in avanti, è concepito dalla tradizione metafisica come l’animal rationale –, ha fatto sì che la storia del pensiero Occidentale abbia connotato lo schizofrenico – il “folle” – accostandolo così all’animale o al bambino, in quanto a-logos, “a) privo di ragione, b) privo di parola, c) incomprensibile o assurdo” (Lobaccaro 2024: 69), ovvero un meno-che-uomo, e concepito la schizofrenia come il “regno dell’insensato” (Lobaccaro 2024: 16).
È questo spaesante maremagnum che cerca di cartografare Luigi Lobaccaro con il suo testo, edito da Quodlibet, Ai confini del senso. La schizofrenia tra semiotica, psicopatologia e scienze cognitive, il cui obiettivo è di mostrare “che la schizofrenia non sia il dominio del non-senso, ma un paesaggio diverso illuminato da una luce crepuscolare e ancora inesplorato, dove è possibile muoversi a tentoni e comunicare con gli abitanti del luogo” (Lobaccaro 2024: 17). Ciò che di questo libro è particolarmente rilevante è il tentativo di tenere insieme, in un’ottica interdisciplinare, appunto tre branche del sapere come la psicopatologia fenomenologica, le scienze cognitive – segnatamente quelle delle cosiddette 4E cognitions – e, su tutte, la semiotica. La preminenza di quest’ultima disciplina nell’approccio di Lobaccaro è giustificato da una delle poche certezza che abbiamo sulla schizofrenia, cioè che essa si costituisca come una pressoché totale “metamorfosi delle modalità di produrre, interpretare, trasformare e processare il senso” (Lobaccaro 2024: 15) e la semiotica è, fra le altre cose, quella disciplina che si occupa di indagare l’ambito del sensato e della significazione. Quindi, emerge qui uno degli aspetti significativi del volume di Lobaccaro, ossia che il disturbo schizofrenico non viene concepito ex negativo a partire da un concetto deficitario della malattia come privazione, quanto piuttosto letto semioticamente – e dunque positivamente – come una differente modalità in cui il paziente opera nell’orizzonte simbolico in cui è immerso.
Il volume è suddiviso in sei capitoli, che conducono passo passo il lettore a gettare sempre maggior luce su quell’oscuro dominio che è quello della schizofrenia. Il primo capitolo si occupa di illustrare una classificazione dei tradizionali sistemi nosografici e diagnostici della schizofrenia, nonché una breve rassegna dei principali modelli (e stereotipi) che, dalla letteratura al cinema, passando per la dimensione del mass-media e della politica, hanno contribuito a plasmare l’immaginario culturale comune che si ha della schizofrenia, al fine di sottolineare come sia necessaria una “battaglia semiologica in cui è necessario intervenire sulle rappresentazioni culturali stesse e sulla loro ricezione” (Lobaccaro 2024: 57). Uno dei bersagli principali di tale disamina è proprio il modello diagnostico proposto dal DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5th ed.), che pur promettendo neutralità teorica, ha in realtà “come sfondo epistemologico un razionalismo medico che produce una concezione della malattia mentale come malattia del corpo il cui indicatore fondamentale […] è il sintomo” (Lobaccaro 2024: 33). Infatti, uno dei problemi principali è proprio l’utilizzo del criterio sintomatologico, ché se la schizofrenia è concepita come una somma di sintomi, ma il sintomo, in quanto sintomo-di qualcosa d’altro, è sintomo solo a partire dal sistema utilizzato per valutarlo come tale, così che ne risulta che siano “gli stessi discorsi e le pratiche sulla schizofrenia che producono una diagnosi di schizofrenia” (Lobaccaro 2024: 42). Questo non significa che Lobaccaro intenda disfarsi della categoria, quanto piuttosto porre l’accento sul fatto che “è nel dominio del semiotico e non dell’ontologico che va inserito il problema” (Lobaccaro 2024: 46): si potrebbe azzardare a dire che lo spostamento dell’interrogazione che qui viene compiuto possa considerarsi, sebbene sui generis, una sorta di epoché che non tenti in prima battuta di determinare ciò che la schizofrenia è, ovvero è supposta essere, (che equivarrebbe ad una domanda ontologica), quanto piuttosto come essa ci si dia e cosa chiamiamo con quel nome. Perciò, l’Autore considera la parola ‘schizofrenia’ come un “artefatto semiotico, un fatticcio della psichiatria [… e dunque essa] allora non è una malattia, né un disturbo; è un’ipotesi di malattia” (Lobaccaro 2024: 46-47).
Nel secondo capitolo è presentato un excursus storico su psichiatria e psicopatologia, mostrando i principali paradigmi che hanno concettualizzato la schizofrenia – e che, conseguentemente, ne hanno messo in opera il trattamento terapeutico: la psichiatria ‘classica’ a partire da Kraepelin, la psicanalisi freudiana e la psicopatologia fenomenologica jaspersiana. Ciò che accomuna questi tre differenti paradigmi teorici è la comune concezione della schizofrenia come regione oscura e come a-loghia, così che essa si configura rispettivamente come “deficit organico della corteccia cerebrale che rispecchia un deficit cognitivo irrimediabile” (Lobaccaro 2024: 72) (Kraepelin), come regresso a uno stato arcaico e pre-culturale o infantile (Freud), o infine come abisso di incomprensibilità rispetto al quale è, per lo psicopatologo, impossibile ogni comprensione (Jaspers). Il seguito del capitolo mostra poi come, in opposizione ai modelli teorici appena menzionati, sorga fra gli anni 60’ e 70’ del Novecento, la corrente dell’antipsichiatria, che, forte di un orizzonte filosofico di stampo marxista, “combatte contro il concetto di malattia mentale, l’ospedalizzazione forzata, la forma e l’organizzazione manicomiale” (Lobaccaro 2024: 100) nella convinzione di un legame causale fra moderne società tecno-capitalistiche e schizofrenia, la quale sarebbe una ‘patologia sociale’ resa possibile dall’organizzazione socio-economica.
Il terzo capitolo è quello che prepara il passaggio dalla psicopatologia alla semiotica, cercando di superare definitivamente il pregiudizio per la quale la follia sarebbe una mera zona di oscurità del senso affatto irrazionale. Un primo passo per ridare dignità e autonomia al concetto di schizofrenia è quella di considerare il paziente nella sua totalità, ossia in quanto essere umano, facendo della malattia una forma dell’esistenza, i cui ‘sintomi’ sono le sue modalità espressive: dunque, il “carattere sintomatico di una manifestazione patologica […] diventa una forma attraverso cui si organizza il senso dell’esperienza di un determinato soggetto” (Lobaccaro 2024: 116) e il compito dello psicopatologo diviene allora comprendere il mondo del paziente – che è sì un mondo dotato di una sua dignità significante, ma altra rispetto al mondo non-patologico. Questo è un primo passo in direzione di una piena determinazione della ‘follia’, ma per muovere ulteriormente verso la comprensibilità è necessario, secondo Lobaccaro, operare uno spostamento disciplinare in direzione della semiotica. Quest’ultima, infatti, permette di affermare non solo che la schizofrenia sia una una modalità di esistenza, ma anche che “l’esperienza schizofrenica è indagabile perché essa è significativa e commisurabile a quelle altrui” (Lobaccaro 2024: 142), per cui in essa ne va non già di un non-senso, quanto piuttosto di una diversa manipolazione della significatività possibile – e tuttavia a partire appunto da un piano di significatività comune a tutti, tale per cui lo schizofrenico è come se costruisse (con una certa invarianza strutturale) giochi linguistici privati.
Proprio in quest’ultimo aspetto risiede la “tesi fondamentale” espressa nella seconda parte del libro, dedicata ad un’esplorazione delle modalità di significazione schizofreniche a partire dalla schizofasia, secondo cui “ogni manifestazione schizofasica si poggia sulle (e sfrutta le) possibilità offerte dalle strutture del linguaggio [… e costituisce] una diversa modalità di abitare la dimensione del significato” (Lobaccaro 2024: 148). Il concetto fondamentale che Lobaccaro mobilità per esplorare la dimensione semiotica schizofrenica è quello echiano di enciclopedia, che indica l’insieme dello “spazio entro cui si svolge ogni lavoro di interpretazione e di produzione del senso […] e contiene in sé tutte le informazioni di cui disponiamo” (Lobaccaro 2024: 167), nonché tutte le condizioni di dicibilità del senso: l’enciclopedia consiste nell’orizzonte del senso – ossia, letteralmente, del pensabile e del dicibile – e nelle pratiche per il suo (corretto) utilizzo. Va da sé che un tale regime non è descrivibile dal suo interno in quanto totalità ed è costitutivamente una totalità aperta, che contiene ogni possibile tautologia e contraddizione, passibile di nuove interpretazioni che ne fanno vibrare le struttura stessa e modificantesi al modificarsi delle conoscenze e interpretazioni degli individui situati in essa. La tesi che portano avanti i capitoli 4, 5 e 6 – i più complessi e teoreticamente densi del volume – è che la schizofrenia sia dovuta ad una difficoltà nella gestione del senso, ovvero nella gestione dei tagli, delle cesure da operare all’interno del piano enciclopedico, così da portare ad una situazione in cui il soggetto finisce per striare infinitamente spazi lisci e, per converso, lisciare – ovvero restituire ad una continua rinegoziazione dei significati – spazi striati. Questi capitoli vanno ad articolare e illustrare l’esperienza del senso dello schizofrenico a partire da tre differenti ambiti, cioè il linguaggio schizofrenico, l’esperienza del disorientamento rispetto al senso comune e alla difficoltà di dire ‘io’ da parte del soggetto patologico. L’idea di fondo secondo la quale gli schizofrenici avrebbero una più o meno marcata difficoltà nella gestione delle competenze enciclopediche, ovvero difficoltà ad economizzare il sensato, ribalta la concezione standard della schizofrenia come deficit: quello che caratterizzerebbe tale disturbo sarebbe dunque non una mancanza, bensì un eccesso, una “incapacità di tagliare, di rimuovere i significati in eccesso e istanziarsi su un singolo piano enciclopedico di riferimento” (Lobaccaro 2024: 174), giungendo così ad una rottura idiosincratica, piuttosto che ad una mera perdita dell’evidenza naturale.
In conclusione, il contributo di Lobaccaro mette bene in luce come il disturbo schizofrenico, letto in ottica semiotica, sia nella sua dimensione di disturbo esperienziale e di problema linguistico, debba “essere inquadrato alla luce della crisi del senso comune nella sua doppia accezione corporea ed enciclopedica” (Lobaccaro 2024: 256). Questa lettura opera un’ulteriore ribaltamento della concezione classica della schizofrenia, mostrando come lo stravolgimento semiotico – linguistico, esperienziale, e del pensiero – che caratterizza lo schizofrenico non è conseguenza del disturbo, quanto piuttosto suo fattore scatenante. Tale lettura permette di sottrarre una volta per tutte la ‘follia’ al paradigma dell’incomprensibilità, facendo così del ‘folle’ non è più un alogos, ma, al contrario, un soggetto che vive un eccesso di logia, un prigioniero del possibile.
Bibliografia:
Borgna, E., 2019, La follia che è anche in noi, Torino: Einaudi.
Lobaccaro, L., 2024, Ai confini del senso. La schizofrenia tra semiotica, psicopatologia e scienze cognitive, Macerata: Quodlibet.
Otto, Rudolf, 2018, Il sacro, Milano: SE.

Tommaso Bigatti dopo aver conseguito la laurea magistrale in Scienze Filosofiche presso l’Università degli Studi di Milano con una tesi dedicata al Derrida lettore di Heidegger, ha successivamente conseguito un Research Master in Phenomenology alla KU Leuven con una tesi dedicata al problema del flusso assoluto della temporalità nella filosofia di Husserl. Si è occupato principalmente di fenomenologia nelle sue varie declinazioni e attualmente è dottorando in Philosophy, Science, Cognition, and Semiotics presso l’Università di Bologna, dove lavora sotto la supervisione del professor S. Galanti Grollo a un progetto dedicato al tema “Il Leib trascendentale e le sue anomalie: la ‘follia’ come problema-limite della fenomenologia”.