Karnes, "Medieval Marvels and Fictions in the Latin West and Islamic World"
Recensione a cura di Amine Xhakoni
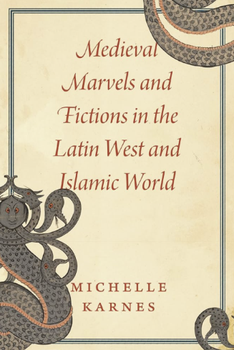
Granchi pietrificati con virtù curative, salamandre che resistono alle fiamme, specchi che predicono tradimenti –che siano ‘minor quirks’ della natura o ‘monstrous aberrations’ (p. 11)– questi fenomeni sfuggono a una classificazione banale e superficiale, rivelando invece una complessità concettuale che attraversa discipline, generi e contesti culturali. ‘Meraviglie’ che suscitano stupore poiché sfidano, in apparenza, le leggi della natura o sono il prodotto di relazioni causali ignote: una categoria sfuggente e multiforme a cui Michelle Karnes dedica il suo studio Medieval Marvels and Fictions in the Latin West and Islamic World. Proprio in virtù della natura del tema affrontato, l’opera di Karnes si presta a essere letta in diretto dialogo con contributi fondamentali quali A History of Magic and Experimental Science di Lynn Thorndike e Wonders and the Order of Nature, 1150–1750 di Lorraine Daston e Katharine Park, che offrono un articolato orizzonte teorico di riferimento, rielaborato dall’autrice in una trama concettuale originale e autonoma. L’approccio è insieme interdisciplinare e interculturale: l’autrice intreccia trattati filosofici a resoconti di viaggio e testi letterari, tutti animati dalla presenza di mirabilia, proponendo un inedito confronto tra le tradizioni latina e arabo-islamica medievale, esplorate secondo nuclei tematici e angolazioni differenti. Rifiutando esplicitamente l’associazione tra meraviglia e nozioni come arretratezza, estraneità, credulità e semplicità intellettuale (p. 203), Karnes rivendica la ricchezza semantica e la forza creativa di questa categoria. Le ‘meraviglie’ diventano così uno spazio privilegiato d’intersezione tra filosofia, scienza e letteratura.
Nell’introduzione, l’autrice definisce con chiarezza i confini e la metodologia della propria indagine, soffermandosi sul significato del termine ‘marvel’ e sottolineandone l’intrinseca interdisciplinarità, giustificando così l’ampiezza delle fonti utilizzate e l’approccio comparativo adottato. In questo orizzonte, Karnes delimita consapevolmente il campo della sua ricerca: esclude gli automi, in quanto frutto dell’ingegno umano e non espressioni dirette della natura; allo stesso modo, sceglie di non prendere in considerazione l’alchimia e la cosmologia, il cui respiro teorico risulterebbe troppo ampio rispetto agli obiettivi e all’estensione del volume; inoltre, la trattazione delle fonti ebraiche è limitata a brevi riferimenti nelle note. Il contributo rimane, nondimeno, ricco e stratificato, articolandosi in due parti distinte: la prima, che comprende due capitoli, si fonda sul dibattito filosofico riguardo alla facoltà immaginativa; la seconda, che ne comprende altrettanti, esplora il potenziale creativo delle ‘meraviglie’ all’interno di diversi generi letterari. Il terzo capitolo assume una natura ibrida, facendo da ponte tra le due sezioni principali.
Nei capitoli iniziali, l’attenzione si concentra sul ruolo della facoltà immaginativa nella produzione delle ‘meraviglie’, e sulla nozione, quindi, di ‘marvel-performing imagination’ (p. 28) –particolarmente esplicativo è il concetto di taḫyīl (figurazione), come formulato da al-Ǧurǧānī (XI sec.). L’autrice attinge tanto alle riflessioni di al-Kindī, Avicenna e al-Ġazālī quanto a quelle di Tommaso d’Aquino, Thomas Bradwardine, Nicola d'Oresme e Alberto Magno. L’immaginazione, secondo questa prospettiva, è una facoltà in grado di generare immagini che confondono interiorità ed esteriorità, apparenza e realtà, e che può persino agire direttamente sul mondo materiale. Sogni premonitori, rivelazioni profetiche e possessioni demoniache costituiscono, nel primo capitolo, esempi di fenomeni che, pur radicandosi nell’interiorità, mettono in crisi i confini tra realtà interna ed esterna poiché la forza di tali esperienze non risiede tanto nella sostituzione della percezione, quanto nella loro capacità di imitarla con precisione (p. 31).
Quel confine fra percezione sensoriale e immaginazione viene attraversato nel secondo capitolo, in cui fenomeni come il malocchio o la telecinesi vengono interpretati come manifestazioni di un'immaginazione con un potenziale agente capace di modificare direttamente la realtà e alterare i corpi e gli oggetti nel mondo esterno. È il potere di pensare a un cammello che cade e vederlo davvero cadere. In questa prima sezione, argomenta Karnes, la facoltà immaginativa non si limita a rendere le ‘meraviglie’ più complesse e significative, ma è ciò che le genera e le definisce. Con questa intuizione, l’autrice sfida l’idea comune secondo cui la meraviglia si origina dall’ignoranza e svanisce quando la causa nascosta viene svelata. Karnes, al contrario, propone un modello rovesciato, in cui l’indagine razionale e la ‘meraviglia’ non sono inversamente proporzionali (p. 81), ma in cui la prima è motore della seconda.
Il terzo capitolo, che si avvale in maggior modo di fonti primarie, sposta il focus sulle ‘meraviglie’ che animano sia le produzioni filosofiche sia quelle letterarie, come pietre, erbe e animali straordinari, approfondendo come queste non siano necessariamente espressioni della natura che necessitano di dimostrazione, ma possibilità creative della stessa. Queste non sono impossibili, ma ipotesi legittime e si collocano nella predisposizione di pensiero che si domanda: “if such marvels are real, how would they work?” (p. 108). Così, l’esempio dell’ʿanqāʾ muġrib, una creatura inesistente simile alla fenice, viene utilizzato da Avicenna per riflettere sulla possibilità di immaginare, dopo la morte, qualcosa che non sia frutto di percezione sensibile. Alberto Magno nel De Mineralibus discute, invece, della proprietà dello zaffiro di curare gli ascessi –una credenza comune, aggiunge. L’effetto curativo della pietra è riconosciuto e, pertanto, non rifiutabile come falso, ma questo, sostiene Karnes, è proprio ciò che conferisce alle meraviglie la loro natura distintiva: “at minimum, marvels are non impossibilities” (p. 89). Infine, l’autrice mostra come le ‘meraviglie’ condividano le stesse caratteristiche anche in generi letterari diversi, e come i filosofi attingano da questa varietà di fonti per discuterne. A questo proposito, l’esempio di Nicola d’Oresme è emblematico: per spiegare come i vapori della terra causino allucinazioni, egli utilizza fonti che spaziano dalla poesia alla letteratura medica, dalle cronache fino alle Sacre Scritture. Così, la Sibilla diceva la verità, ma perché alterata dai vapori sotterranei, non perché avesse doni profetici. Le ‘meraviglie’ letterarie vengono quindi accostate a quelle del mondo naturale non per confusione categoriale, ma perché entrambe riflettono la stessa curiosità speculativa e il medesimo desiderio di comprendere la creatività della natura (p. 111).
Il quarto capitolo attinge da un tipo diverso di fonti, ovvero le narrative di viaggio, dove luoghi reali si alternano a geografie immaginarie, ritraenti luoghi fantastici e lontani, che ospitano pesci tatuati con la šahāda, draghi o abili illusionisti. Attraverso l’analisi di un numero consistente di esempi tratti da I viaggi di Mandeville, Sir Orfeo o il Kitāb Murūǧ al-ḏahab di al-Masʿūdī, l’autrice mostra il ruolo dell’immaginazione e della creatività in questa tipologia di letteratura, evidenziando come essa interpreti la potenzialità della natura stessa, rielaborandola, “allowing its most spectacular features to resonate in its most mundane one” (p. 25).
Nel quinto e nel sesto capitolo si discute dell’adattamento delle ‘meraviglie’ a contesti letterari specifici. Karnes analizza testi che includono tecniche divinatorie –come la geomanzia– mostrando come queste pratiche non offrano certezze, ma generino spazi di ambiguità interpretativa. In Vita Merlini, per esempio, i prodigi profetici di Merlino suscitano meraviglia proprio per la loro inverosimiglianza: egli predice per tre volte la morte dello stesso uomo, presentato ogni volta sotto sembianze diverse e formulando un verdetto diverso per ciascuna. Il discredito del mago sembra inevitabile, ma l’uomo finisce per morire davvero in tutte e tre le modalità profetizzate: si rompe il collo, rimane appeso a un albero e annega in un fiume. Nella letteratura fantastica le ‘meraviglie’ fungono da strumento per affinare lo sguardo del lettore, che deve imparare a riconoscere le strategie autoriali messe in campo. In questo senso, le ‘meraviglie’ diventano simboli di trasformazione e mutabilità: gli autori le utilizzano in modo consapevole, modificandole, omettendo quelle attese e introducendone di inaspettate. Questo gioco di presenze e assenze serve a sorprendere e disorientare lettori considerati fruitori informati e familiari con tale tradizione. Spesso le ‘meraviglie’ non appaiono quindi direttamente o si manifestano in forme mutate, evidenziando così la loro fluidità. Opere come Flores y Blancaflor evocano la presenza delle ‘meraviglie’ proprio nella loro assenza, enfatizzandone il valore simbolico più che la concretezza. L’autrice insiste nel rompere l’associazione tradizionale tra meraviglie, ingenuità e credulità, mostrando come nei contesti letterari esse costituiscano piuttosto una sfida intellettuale e un elemento di sofisticata creatività. Non è quindi solo la natura ad essere creativa nella produzione di ‘meraviglie’, ma lo sono anche autori, che, attraverso forme testuali diverse e in continua evoluzione, stimolano l’immaginazione e sfidano le aspettative del pubblico.
Medieval Marvels and Fictions in the Latin West and Islamic World si distingue per l’ingegno con cui Michelle Karnes intreccia fonti di epoche, lingue e culture diverse, abbracciando generi testuali molteplici, dove le ‘meraviglie’ emergono come espressioni fluide e plastiche. Al centro del suo studio vi è il ruolo fondamentale dell’immaginazione e della creatività: le ‘meraviglie’ sono così interpretate non solo come manifestazioni della natura, ma anche come prodotti della creatività umana, frutto dell’intervento immaginativo e letterario degli autori. Il contributo si configura, dunque, come un viaggio intellettuale che oltrepassa i confini disciplinari, restituendo alle ‘meraviglie’ una dimensione viva e complessa. Non si tratta semplicemente di un libro sulle ‘meraviglie’, ma di un’autentica collezione di mirabilia, ricca di strumenti metodologici, e contenutistici che parlano anche ad un pubblico non specialista. Pur muovendosi con particolare sicurezza nel campo della letteratura, Karnes realizza un esperimento complessivamente riuscito, che costituisce una solida base per future ricerche comparate e interdisciplinari, che scrivano di storia intellettuale e culturale, di filosofia e di letteratura.

Amine Xhakoni è dottoranda in Philosophy, Science, Cognition, and Semiotics (XL ciclo) presso l’Università di Bologna, dove svolge le sue ricerche nell’ambito della storia della scienza arabo-islamica medievale. Il suo percorso dottorale è inquadrato all’interno del progetto ERC UseFool - Knowledge and manipulation of nature between usefulness and deception in the Arabo-Islamic tradition (9th–15th century) (consolidator grant agreement n. 101043939). I suoi interessi di ricerca riguardano la trasmissione, circolazione e ricezione della cultura e dei saperi filosofici e scientifici tra la tarda antichità e l'epoca premoderna. Si dedica, in particolare, allo studio della tradizione manoscritta e della letteratura tecnica relativa alla conoscenza delle proprietà naturali nel contesto arabo-islamico medievale.