Benoist, "Sans Anesthésie. La réalité des apparences"
Recensione di Edoardo Parasporo
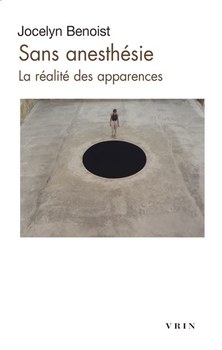
Tre movimenti animano il dibattito nella filosofia teoretica francese dei nostri giorni: il pensiero post-fenomenologico, il realismo speculativo e il realismo contestuale di stampo analitico. Il primo, preso tra gli eccessi della micro e della macro fenomenologia (si pensi alle microanalisi di Dépraz, e alle cosmologie di Barbaras e Romano), il secondo, inaugurato da Quentin Meillassoux e proseguito dal suo allievo Tristan Gracia (che si situa, volente o nolente, nel contesto della Object-Oriented Ontology), ed il terzo, rappresentato da Sandra Laugier e Jocelyn Benoist, di cui si parlerà in questo breve articolo. Una differenza fondamentale tra i tre movimenti risiede nella maniera di pensare il mondo esterno. Partendo dalla prima, la fenomenologia ha subito talmente tante variazioni, e interpretazioni, da quando è nata, che è certo ben difficile definire in poche battute la sua differenza specifica. Eppure, su due punti si può avanzare senza indugi: essa è sempre stata pensiero del sensibile; non è mai stata pensiero del reale. Questo è almeno quanto ci dice Jocelyn Benoist nell’avant-propos del suo recentissimo libro Sans Anesthésie. La réalité des apparences (2024), in cui l’autore offre una sorta di summa del suo pensiero realista, sintetizzando in otto capitoli il lavoro la gran parte dei temi affrontati negli ultimi dieci anni.
Il filosofo parigino, di formazione fenomenologica, definisce la sua posizione negativamente In due passi: prima contro la fenomenologia (cap.1, cap.8), poi contro il realismo speculativo (p.63, pp.231-231, passim). Infatti, la sua posizione è quella di un realismo contestuale d’ispirazione wittgensteiniana, che pretende dar voce al reale intero, al di là della rappresentazione, e al di là dunque della distinzione kantiana tra fenomeno e cosa in sé. In questa prospettiva, è ben chiaro il motivo per cui Benoist voglia allontanarsi dalla fenomenomenologia: essa è pensiero dell’apparenza, certo, ma dell’apparenza del soggetto, colta da un lato preciso- che il soggetto stesso descrive in quanto tale, perché si manifesta a lui attraverso una donazione. Questo significa mettere in secondo piano la realtà delle cose, che il pensiero deve saper cogliere al di là della rappresentazione, dunque al di là dell’apparenza.
Ora, il motivo per cui il filosofo parigino vuole allontanarsi dall’altro movimento nominato, il realismo speculativo, è concatenato al primo: nella sua lettura, il realismo speculativo fa esattamente il contrario della fenomenologia: pensa il reale senza il sensibile. In effetti, nel suo libro fondamentale, Quentin Meillassoux cerca una maniera di trovare un cammino che dall’interiorità del soggetto porti al di fuori, verso l’assoluto. I suoi argomenti- la cui forza è eguagliata soltanto dalla loro assurdità- consistono proprio nel trovare una via d’uscita a partire dal più radicale correlazionismo- il nemico giurato del suo realismo. ll correlazionismo, dunque, consiste nella tendenza fondamentale della filosofia moderna: quella di pensare sempre l’uomo e il mondo come indissociabili; sempre, e già da sempre, presi in un rapporto di correlazione. Che sia la correlazione uomo-mondo, pensiero-essere, linguaggio-referente, la filosofia post-kantiana non riesce a pensare al di fuori di tale schema. E questo, soprattutto perché l’argomento avanzato dal correlazionismo è fortissimo: in fondo, come potrebbe il soggetto uscire da sé stesso per verificare la realtà di un oggetto che lui stesso ha pensato? Cadrebbe in una contraddizione pragmatica, o performativa, ed è per questo che bisogna pensare all’interno della correlazione, fino a farla collassare. A questo punto, si potrà tornare a parlare di qualità primarie- ovvero, di qualità reali, e non sensibili.
Quindi, da una parte il realismo di Meillassoux è troppo poco realista (proprio perché nel voler uscire dalla correlazione, considera solo la cosa in sé, come l’uomo che di fronte ad una mosca in una bottiglia, rompe la bottiglia pur di arrivare alla mosca, cfr. p.64), e dall’altra è ancora troppo legato al paradigma rappresentazionale. Infatti, secondo Benoist, con l’etichetta di correlazionismo Meillassoux sta cercando essenzialmente di combatter la rappresentazione, il paradigma epistemologico secondo il quale l’unico accesso alle cose che l’uomo possa avere, deve passare attraverso delle rappresentazioni- che porta al paradosso di un’interiorità sempre proiettata verso l’esterno, e di un’esteriorità claustrale. Proprio come Marx che, mettendo Hegel con i piedi per terra, condivideva con lui lo stesso terreno- Meillassoux nel cercare di sconfiggere Kant dall’interno rimane complice del kantismo.
È invece della tirannia della rappresentazione che bisogna disfarsi se si vogliono gettare le basi di un nuovo realismo, contro il realismo speculativo e contro la fenomenologia: «se, al di là degli slogan, possiamo trovare un nucleo filosofico sostanziale dietro questa nozione di realismo, ebbene esso risiede, mi sembra, nell’idea della fine dell’era della rappresentazione» (p.226, trad. mia). Benoist propone una forma di realismo contestuale, il cui obiettivo è quello di pensare il reale non senza la rappresentazione, ma al di là del paradigma che il pensiero rappresentazionale ha istituito. Quest’ultimo, secondo il francese, consiste nel considerare il reale nei termini di un oggetto di conoscenza, e le proprietà di ciò che lo abita come esser-conosciuto. Su questo punto, gran parte del realismo attuale non si distacca dal paradigma moderno, e dunque dal realismo classico, configurandosi come un realismo epistemico (pp. 236-238), ovvero come un realismo che intende difendere la nozione di verità contro la messa in discussione che ha subito nella febbre postmoderna della seconda metà del novecento, ma che appiattisce la nozione di realtà su quella di verità. Invece, il “vero realismo” dovrebbe indagare in primis sulla distinzione tra verità e realtà, e capire in che modo si possa render conto del reale, al di là del suo esser-conosciuto. È anche il motivo per il quale il realismo non dev’essere identificato, o ridotto, ad una difesa dell’oggettività (cfr. Cap. V)- perché anche questo modo di pensare tradisce un epistemologizzazione del reale. Il realismo di Benoist è contestuale perché parte dal fatto che ogni rapporto al mondo esterno, ogni esperienza, si dia in un contesto preciso, e che essa assuma un senso a partire dal proprio contesto, eppure, questo non significa che il reale si risolva nella prospettiva che ne abbiamo, tutt’altro. Uscire dal paradigma della rappresentazione significa pensare la rappresentazione come parte di un contesto, quello umano, all’interno di un dominio più ampio. Significa al tempo stesso cercare di dar voce alle cose al di là della loro conoscibilità.
È evidente che su questo punto Jocelyn Benoist stia seguendo, più o meno obliquamente, la via tracciata da Heidegger, per lo meno in due punti: prima con la sua distruzione della metafisica degli oggetti, e poi con l’importanza assegnata alla poetica. I due punti vanno insieme, sono concatenati, perché se da una parte l’essere non è un oggetto da contemplare, ma un insieme di strumenti per l’uomo che vi si trova già da sempre in commercio, allora non sarà il discorso scientifico, o epistemico, quello da prediligere per dirlo. Ma quale discorso, dunque, si nasconde dietro l’idea di poetica? Utilizzando questo termine, Benoist intende smarcarsi da un’altra nozione: quella di estetica. In effetti, il filosofo francese rivendica l’importanza primaria delle arti per il suo progetto filosofico, ma vuole allontanarsi dalla matrice soggettivista e rappresentazionale che implica l’etimologia e la tradizione del concetto di estetica (quella dell’aisthesis, della sensazione del soggetto e del gioco delle sue facoltà). L’estetica rinvia a quel movimento di neutralizzazione della realtà del sensibile che Benoist vuole contrastare, quella di un soggetto puramente recettivo, che riceve il sensibile e ci gioca al suo interno: è in fondo la stessa matrice contemplativa contro la quale lottava Heidegger. La poetica, al contrario, si presenta come una “tecnologia del sensibile”, una produzione di ombre, un’interazione diretta e impegnativa col sensibile (p.58, p.239)
Eppure, per disambiguare, poetica non vuol dire poesia. Infatti, l’arte che secondo Benoist convoca in maniera più chiara il reale è la musica, ed in particolare la musica concreta, quella del suono più che della nota- quella che lascia suonare la rudezza dei rumori, più che l’idealità delle note (pp.95 et sgg.). Ebbene non solo la musica, per il carattere non-rappresentativo che tanto la fece amare a Schopenhauer, si presenta come un’alleata del “vero realismo”, ma anche l’arte contemporanea, o sperimentale, di cui Benoist offre una definizione tanto sbrigativa quanto contestabile: l’arte contemporanea si definirebbe per il suo carattere non-referenziale (p.87). All’interno di una tale definizione, non sarà difficile includere le performance che popolano i musei d’arte contemporanea: le performance di fatto sono non-referenziali. È più difficile stabilire invece se alcune opere fondatrici dell’arte contemporanea, come ad esempio la Fontana di Duchamp, siano sussumibili o meno sotto questa definizione. Ad ogni modo, Benoist sottolinea che non si tratta, in questo caso, di applicare dall’alto gli schemi di una filosofia, la sua, a delle discipline- atteggiamento che il francese rigetta, in quanto idealista. Si tratta invece di render conto della maniera in cui tali arti possano stimolare il pensiero a pensare in un’altra maniera il sensibile, e dunque il reale.
Per concludere, l’ultima pubblicazione di Jocelyn Benoist si presenta come un’opera densa, sintetica, in cui il filosofo francese riprende e integra gran parte delle intuizioni che hanno segnato il suo cammino a partire dal 2011, anno in cui pubblicava il primo testo di stampo propriamente realista (Élements de philosophie réaliste). Nel rivendicare l’importanza di un rapporto diretto, senza filtri, senza anestesia con il sensibile, Benoist prosegue il percorso teoretico iniziato con Le bruit du Sensible (2013) e Logique du Phénomène (2016), testi nei quali veniva sviluppata una critica realista del contratto fenomenologico. Al tempo stesso, Sans Anésthesie è un libro profondamente radicato nell’attualità, per i riferimenti, i dialoghi, le tensioni polemiche, gli elogi, il libro si è un’ottima introduzione non solo al pensiero di un autore originale, ma anche della scena culturale e artistica all’interno della quale si situa.
Bibliografia:
Barbaras, Renaud, Phénoménologie et Cosmologie, Paris: Vrin, 2024
Benoist, Jocelyn, Éléments de philosophie réaliste. Paris: Vrin, 2011
Benoist, Jocelyn, Logique du Phénomène, Paris: Vrin, 2016
Benoist, Jocelyn, Le bruit du sensible, Paris: Cerf, 2013
Benoist, Jocelyn, Sans Anesthésie. La réalité des apparences, Paris: Vrin, 2024.
Dépraz, Nathalie La surprise, Paris: Seuil, 2024
Garcia, Tristan, Forme et Objet, Paris: PUF, 2014
Romano, Claude, L’événement et le monde, Paris: PUF, 2021

Edoardo Parasporo si è laureato in filosofia nel 2024, con una tesi in storia della filosofia moderna sull'influenza della filosofia di Hume nell'opera di Quentin Meillassoux. Ha passato il suo terzo anno di laurea all'estero, in erasmus alla Sorbonne Université, dove si è interessato ai rapporti tra filosofia francese e letteratura. Attualmente è iscritto in un corso di laurea magistrale all'università Pantheon-Sorbonne, dove svilupperà una tesi intorno alla questione della soggettività e la questione del fondamento in Gilles Deleuze, sotto la direzione di Quentin Meillassoux.