Intervista a Antonino Pennisi
a cura di Elia Pupil e Eduardo Serna

Antonino Pennisi è un filosofo e linguista italiano. Dal 2012 al 2018 ha diretto il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e degli Studi Culturali dell'Università di Messina, presso cui è titolare della cattedra di filosofia del linguaggio. I suoi interessi riguardano prevalentemente la psicopatologia del linguaggio e, più in generale, la relazione tra linguaggio, evoluzione e cognizione umana. Tra le sue ultime pubblicazioni consigliamo L’ottava solitudine. Il cervello ed il lato oscuro del linguaggio (2024), Che ne sarà dei corpi? Spinoza ed i misteri della cognizione incarnata (2021), assieme ad Alessandra Falzone The Extended Theory of Cognitive Creativity. Interdisciplinary Approaches to Performativity (2020).
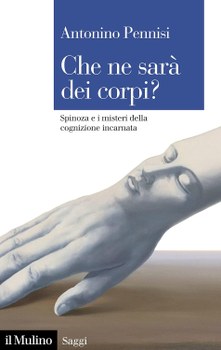
Segnalibri Filosofici – Da dove è nata questa esigenza di usare Spinoza all’interno delle scienze cognitive?
Antonino Pennisi – L’occasione è stata la lettura del libro di Damasio – Looking for Spinoza: Joy, Sorrow, and the Feeling Brain – perché Spinoza l’avevo prima studiato come filosofo, ma non l’avevo mai pensato come un possibile neuroscienziato. Dopo quella lettura, come capita sempre quando leggi un bel libro, mi sono incuriosito e ho divorato tutto Spinoza. È diventata una mia passione e l’ho sottoposto ad una lettura intensiva, perché quando un filosofo mi interessa mi procuro tutte le sue opere, e mi costruisco le concordanze lessicali in modo che modellizzo ogni ambito semantico. Infine lo rileggo con calma. Spinoza, per me, è un’icona etica, perché incarna il mio ideale di razionalismo e naturalismo assoluti.
SF – Lei parlava della sua volontà di ricercare Spinoza anche nell’ambito del politico…
AP – Sì, dopo che ho scritto il libro ho continuato a rileggere le sue idee e la sua influenza politica, e non escludo che in uno dei prossimi libri ne parlerò, ma devo capire come riportarlo all’attualità. Per esempio, Spinoza si presta a una discussione sulla biopolitica e sulla felicità sociale. Mi piace leggere i classici, ma per risolvere dei problemi attuali.
SF – Questo si connette molto con la sua tematica della solitudine?
AP – Lui è un'icona etica anche per questo, perché ha saputo condurre tutta la sua vita in solitudine. Chi aveva amore per la ragione e solo per la ragione era completamente solo. Anche quei pochi amici che lo aiutarono sono finiti male dato che erano perseguitati essendo suoi seguaci, Un altro aspetto etico molto importante è il valore dell’argomentazione, cioè la capacità di riuscire a ragionare e spiegare sino alla chiarezza ultima, “geometrica”. Per far questo la compagnia della solitudine è essenziale.
SF – Andando subito nel core della situazione, percepiamo una continua tensione nel suo libro tra una formazione neuroscientifica e psicolinguistica, che vuol fare da asse mediano alla sua trattazione di Spinoza, e quel particolare invito di Deleuze a considerare un corpo non per quello che è, ma per quello che può. Tant’è che il titolo Che ne sarà dei corpi cavalca questa medietà, e la triadicità che lei presenta per spiegare il corpo – Korper-Leib-Umwelt – sembra molto calzante. Questo perché distanzia tanto il fisicalismo semplicistico quanto un certo tipo di “fenomenologia”, rilegato nell’impossibilità di tematizzare le prospettive di prima persona. È stato un po’ arrischiato aver infilato questo concetto di Umwelt nel libro su Spinoza?
AP – Può darsi. Ma gli autori li dobbiamo capire e interpretare a partire da ciò che noi vogliamo capire e interpretare del mondo ed appoggiarci su di essi. Lo aveva capito Chomsky tanti anni fa con Cartesian Linguistics. Il punto principale è che Spinoza ha fatto saltare tutta la filosofia della mente contemporanea, perché ci ha fatto capire quanto sia antropocentrica e quanto sia irragionevole l’opposizione ad un certo riduzionismo non volgare, come se il riduzionismo non potesse avere al suo interno un fortissimo elemento di complessità. Cosa distanza un riduzionismo sempre più complesso da una teoria non riduzionista sempre più semplicistica?
SF – Ad esempio un dualismo à là Searle?
AP – Esattamente! Se la potenza esplicativa e la qualità con cui si ricostruiscono le dinamiche che vanno a studiare è esattamente identica, la prima [il riduzionismo con il suo forte elemento di complessità] mira a capire i rapporti di correlazione delle occorrenze e della loro genesi, l’altro [il non riduzionismo semplicistico] mira a narrare l’esperienza dei fenomeni. In particolare l’esperienza dell’insondabilità della differenza tra mente e corpo, così come tra brain-body e non-brain-body (come dicono David Hutto e Alva Nöe), rischiando di dare un vero e proprio valore ontologico a questa differenza, prospettandoci una divisione su – almeno – due piani: quello ontologico e quello metodologico.
Per quanto riguarda la comprensione delle patologie contemporanee, ho scavato attorno a questa idea e sono certo che se Spinoza potesse esprimersi oggi le sue posizioni potrebbero essere applicate con successo ad alcuni tipi di patologie (come l’anoressia, la xenomelia o la vigoressia, che ho cercato di trattare nella prima parte del libro). Noi non possiamo dire che Spinoza era uno psicologo clinico ante litteram, ma possiamo dire che le sue idee servono a capire perfettamente cosa sia una psicopatologia corporea. Dobbiamo partire dal principio che il soggetto anoressico – ad esempio – si guarda allo specchio e vede sé stesso come un obeso, ma pesa 30 chili e continua a dimagrire. Come fare a spiegare una condizione del genere? Per noi filosofi del linguaggio non è difficile darne conto: sono “narrazioni”. Lui si narra il corpo, non dice com’è il corpo, ma si costruisce una rappresentazione, un'immagine mentale del sé corporeo. Tutto questo è la condizione normale della natura umana, noi ci narriamo di tutto e sviluppiamo diagrammi significativi che rendono sensata questa narrazione. Ciò può spingersi sino ai casi estremi della patologia, in cui creiamo delle narrazioni neganti. Una cosa è l’immagine corporea, un’altra è lo schema corporeo. Lo schema corporeo è un dato comune a tutte le specie: è la reazione automatica dei corpi ad adeguarsi all’ambiente. Uno schema stimolo-risposta che precede qualsiasi coscienza e qualsiasi cognizione animale. L’immagine mentale è invece uma rappresentazione solo umana perchè costruita grazie al linguaggio.
SF – Riprendendo la questione circa la complessità e il riduzionismo “sempre più complesso”. Nel momento in cui Spinoza va a sviluppare una definizione di corpo come realtà composta da moltissimi corpi che lo quasi-riproducono, la dimensione intensiva sussume in essa infinite modalità estensive; anche un autore come Sangiacomo va ad analizzare la complessità del corpo e vede come sia difficile concepirlo adeguatamente, in quanto questo pone la sua dipendenza dalla rete di relazioni molecolari con gli altri corpi. Allo stesso tempo, proprio in virtù della sua composizione, il corpo diventa un operatore epistemico attraverso cui la mente può sviluppare nozioni comuni che consentano di concepire in modo adeguato i nuovi rapporti. Da questo punto di vista è interessante vedere come nel suo libro si vada a ricondurre una fitta speculazione attorno a due termini molto problematici nella filosofia spinoziana, mens e conscientia. Come li tratta all’interno dello spettro della complessità appena citata? Anzi, come li interpreta funzionalmente al suo pensiero?
AP – La formula filosofica più attuale di Spinoza è proprio la “mente come idea del corpo”. Penso che l’idea che noi ci siamo fatti (con una specie di materialismo scadente contrapposto ad un altrettanto scadente cerebrocentrismo) è che il cervello è un operatore escluso dal corpo; per come parla la neuroscienza contemporanea, vi è la centralità del cervello come implementatore fisico e poi c’è il corpo come semplice modulatore accessorio degli input o come semplice strumento d’esecuzione. Spinoza dimostra che, al contrario, senza corpo non c’è neanche cervello e che il cervello stesso è corpo. Si tratta di un’acquisizione esplosiva che adesso, nell’embodied cognition (ed oltre), viene finalmente riconosciuta. La distinzione che fanno sia Noe che Hutto tra neural-body e non-neural-body fa comprendere che tutto è un unico corpo con strutture biologiche specifiche e compiti funzionali diversi. Il cervello è una parte del corpo che ha compiti specifici, i quali non possono essere svolti in nessun’altra parte del corpo. Spinoza, queste cose le elabora in forma etologica e pure in forma proto-evoluzionistica. Naturalmente non dico che automaticamente questo possa giustificare un pre-darwinismo, ma di fatto nelle cose lo è. Spinoza comprende bene cosa voglia dire ridurre due istanze problematiche ad un unico problema, memore della dottrina degli attributi, e la stessa cosa sembra farla con il neural-body e il non-neural-body, definendoli come un’unica sostanza come modi e attributi diversi. Ed è solo comprendendo questo che noi possiamo uscire da molti empasse. Devo dire che mi è molto servita la lettura che ne ha fatto Gilles Deleuze nelle sue lezioni su Spinoza (Cosa può un corpo?), che è molto diversa da quella lettura che ha fatto Damasio. Solo capendo che cosa può un corpo noi possiamo rispondere che cos’è una mente e quali sono le sue potenzialità, quindi cosa può fare una mente. Se questo fosse il programma standard della scienza cognitiva contemporanea, allora sarebbe straordinario; Spinoza non era abituato ad una letteratura biologica, la sua formazione era prevalentemente fisica. Ma che lui arrivi dalla biologia o dalla fisica del tempo, arriva da paradigmi comunque certamente superati. Eppure Spinoza si mostra attualissimo, perché riduce la questione al principio filosofico di cos’è un corpo, inteso a definire cosa può fare, in relazione alla conoscenza specifica (scientificamente variabile nel tempo) che abbiamo della sua composizione. L’embodied cognition in questo non lo ha seguito a causa del suo rifiuto preconcetto della nozione di rappresentazione.
SF – In che senso “rappresentazione”? O meglio come, salvando capre e cavoli, nel momento in cui si parla di mens come idea corporis o nel momento in cui si parla di coscienza come “proprietà fisica dell’idea che è idea dell’idea”, si può anche parlare di immagine del sé e di schema corporeo?
AP – Lo schema mentale cablato nel sistema nervoso è la funzione di monitoraggio automatico sia del corpo biologico (Korper) che di quello esperito (Leib). Viceversa, quando abbiamo a che fare non con lo schema corporeo, ma con l’immagine corporea, siamo in un altro mondo che è quello tipicamente umano e non più animale, il mondo di chi costruisce un’immagine del sé. Solo così noi possiamo spiegare l’anoressia oppure qualunque altra patologia che racconto nella prima parte del libro (“Corpi che si odiano e corpi che si amano”). Quei corpi si vedono in quel modo, perché costruiscono un’immagine linguistica e rappresentazionale del proprio corpo. Solo così si spiega la convinzione dell’anoressica di credersi obesa, nonostante la sua morfologia ed i suoi parametri fisici. Queste che sembrano contraddizioni palesi affondano tutto nella facoltà umana di farsi un’immagine delle cose, di non vivere direttamente le cose, ma sondarle in un campo di mediatezza. Questa è una scoperta che l’embodied cognition non recepisce, appunto perché rifiuta l’idea della rappresentazione. La valutazione cognitiva dei soggetti è condizionata dall’immagine del corpo – che il corpo stesso invia al cervello quale implementatore fisico – la quale è a sua volta modulata dalla rete di affezioni che il corpo esperisce, delimitando l’ambiente cognitivo in cui esso è immerso. Questo ambiente, noto come Umwelt, è la somma delle cecità cognitive vincolate neurobiologicamente dal corpo come Korper (il corpo com’è biologicamente, lo schema corporeo come struttura biologica) e dalla trama socio-biologica e socio-linguistica in cui questo si individua. In questo senso, riprendendo dall’inizio, la mente è sempre l’idea del corpo in quanto immagine del corpo. Nel momento in cui parliamo di patological core parliamo della crisi nel rapporto tra non-neural-body e neural-body. Allo stesso tempo, mente e corpo sono fatti della stessa sostanza, ma hanno ruoli differenti: la prima elabora attraverso la propria idea di corpo, mentre il corpo produce percezioni vincolate alla cognizione etologica della specie e alla specie-specificità dei suoi qualia.
SF – Lei da questo punto di vista analizza il patological core sotto il profilo della dissonanza e della consonanza tra neural body e non-neural-body, ed ancora di più tra mente e corpo, la prima intesa come immagine del corpo, il secondo inteso come schema corporeo specializzato nel condizionare le sensazioni percettive coi suoi diversi sistemi sensoriali etologicamente specifici. Saltando dalle neuroscienze a Spinoza e viceversa, come affronta l’identità di ordo et connexio tra gli attributi in Spinoza? Al di là delle facili interpretazioni su un presupposto parallelismo, come riprende, se la riprende, la distinzione reale tra attributi? Finora sembrano due modi per esprimere la stessa cosa, la sostanza, ma come quindi valutare le possibili dissonanze alla base del patological core? Sono condizioni relative ai piani di esperienza di mente e corpo ed a come l’intelletto li esperisce oppure si danno nell’articolarsi dei modi di conoscenza?
AP – Premetto che si tratta di una questione ancora da esaurire completamente: una lettura di Spinoza senza una propria ipotesi del mondo è molto difficile. Anche chi fa filologia pura lo sa: non esiste neutralità nella lettura. A me non interessa un rispetto paranoico del testo. Il testo l’ho voluto sottoporre prima ad un processo di analisi semantica informatizzata proprio per leggerlo quanto più compiutamente possibile e non ricorrere alla singola citazione per elaborare fantasie interpretative, che è il difetto opposto del filologo puro, quello di chi il testo proprio lo ignora. Da tempo ho lavorato sempre con le concordanze e con le tassonomie, costruendomi i programmi. Quindi, disponendo delle opere di Spinoza in versione integrale e facili da mettere in input, si può avere un modello lessicale completo di quello che ci dice Spinoza. Tutte le accezioni di corpo, tutte le accezioni di anima vengono sviluppate nei loro aspetti semantici; per me la lettura di un testo è una lettura legata ad uno smontaggio, per poi rimontarlo. In questo lavoro di montaggio e smontaggio meccanico, nel senso che lo deve fare un computer, vi è anche la ricostruzione di questi smontaggi, e questa ricostruzione si fa con le ipotesi poste a moventi della propria ricerca. Io non ho mai sostenuto che Spinoza potesse essere uno scienziato o un neuroscienziato, perché queste cose non sono vere e neanche mi interessano, ma le idee spinoziane senza dubbio sono rivoluzionarie rispetto al suo tempo. Andando al fulcro della domanda, quando Spinoza riprende nel Breve Trattato il fatto che bisogna distinguere la percezione mentale dell’oggetto corporeo ed il giudizio che la mente forma su questo oggetto sembra che voglia indicare che le possibili dissonanze dipendano dalla relazione tra le immagini del corpo e le immagini della mente, o meglio, dipendano dalla mancata coincidenza tra corpo come schema corporeo e corpo come immagine del corpo. Quindi, sembra sottintendere che la mancata convergenza tra questi rimanda la questione non tanto alla dimensione della distinzione tra gli attributi, quanto a una filosofia basata sul corpo stesso come operatore di conoscenza.
SF – Quindi lei tenta di approcciare la questione mente-corpo in Spinoza funzionalmente alla sua interpretazione, analizzando le mancate collimazioni tra immagine del corpo e corpo stesso alla stregua di disallineamenti tra percezione e giudizio, tra l’elaborazione del non-neural-body e la produzione rappresentazionale che viene implementata – volendo utilizzare un termine neutro – dal neural body, senza essenzialmente dover dare conto della questione degli attributi se non col fine di sottolineare l’importanza del monismo in Spinoza.
AP – Sì. Quando parlo della centralità del monismo, parlo della storia dell’isolamento filosofico di Spinoza per secoli. Ci sono volute molte scoperte scientifiche per capire che Spinoza aveva ragione e quando Damasio scrive L’Errore di Cartesio questo riconoscimento della scienza moderna era già avvenuto. È diventato centrale perché oggi pratichiamo i principi della sua scienza: della scienza monistica di Spinoza. Oggi il monismo lo accetti già nel momento in cui decidi di fare scienza. Non puoi dare una spiegazione dualistica dei fenomeni, altrimenti che tipo di ricerca stai facendo? Tu puoi dire che ci sono fenomeni che sono fuori dalla possibilità di comprensione, perché il corpo non ha ancora rivelato tutte le sue possibilità. Quello che conta è il metodo. Se dovessimo vedere le cose come duecento anni fa tutto il mondo ci sembrerebbe magico, mentre oggi lo diamo per scontato. Oggi qualunque scienza è scienza nella misura in cui cerca le sue spiegazioni in un’unica sostanza. Tutto questo che oggi è scontato in qualunque tipo di scienza era un’eresia al tempo di Spinoza. Era stato perseguitato, morì giovanissimo, ma ha lasciato al mondo questo capolavoro filosofico che ha insegnato agli scienziati che cosa significa il metodo monistico.
SF – All’inizio del capitolo sesto lei dice che Spinoza servirebbe per fondare una nuova semiotica, oltre che per rifondare delle nuove scienze cognitive…
AP – Io sono ormai vecchio, era un po' più vecchio di me Umberto Eco ed ancor più Tullio De Mauro. Bologna è una città che ho amato ed in cui ho avuto tanti interlocutori. Ho potuto vivere tutta la stagione della semiotica che si è svolta a Bologna in tutte le sue varie declinazioni. La semiotica era per me inavvicinabile. Ma Eco era una persona straordinaria: non proprio uno scienziato della semiotica, ma un genio artistico-creativo, nel tentativo di confrontarsi spesso polemicamente con la semiotica greimasiana. Quando mi sono incontrato con lui e tutta la sua scuola mi ricordo che non fu facile intendersi: parlavamo linguaggi completamente diversi. D’altro canto parlavamo in modo diverso anche da tutta la filosofia del linguaggio: ho avuto un percorso conflittuale in filosofia del linguaggio, sebbene oggi le scienze cognitive siano ben accette nei suoi percorsi. La filosofia del linguaggio italiana è molto cambiata, ad esempio non ha gli stessi rapporti con la filosofia analitica che aveva dieci anni fa, e proprio nel corso di questa trasformazione ha cambiato i linguaggi. Tutti hanno cambiato linguaggio; un semiologo o uno scienziato cognitivo di oggi finalmente hanno un terreno comune molto esteso, quello che ancora è da realizzare è una completa concretizzazione della comunanza nei metodi di indagini. Prima dell’arrivo dell’ultima generazione di semiologi – ben rappresentata da Claudio Paolucci a Bologna e da Massimo Leone a Torino – costituire questo piano di dialogo era molto più ostico, anche perché l’idea di semiotica di allora era ormai finita come era finita l’idea della filosofia analitica, come era finita l’idea a cui io appartengo filologicamente parlando (la cosiddetta filosofia “sintetica”). Sono molto soddisfatto, quindi, di quest’ultima generazione di filosofi del linguaggio: ed è grazie alle Scienze cognitive che sta cambiando tutta la Semiotica che oggi è al centro, è in palla col mondo.
E questo mi dà molta soddisfazione. In tutta umiltà ed onestà, aver creato negli anni Novanta la prima Laurea magistrale e il primo Dottorato di Scienze cognitive a Messina, e – a Bologna – la prima rivista italiana di Scienze Cognitive (“Reti, saperi, linguaggi. Italian Journal of Cognitive Sciences”, il Mulino) sono state scelte molto difficili ma lungimiranti, vedendo le conseguenze scientifiche che ha prodotto, non solo sulla Semiotica ma su tutte le scienze del linguaggio. Bisogna capire le cose prima che avvengano, un po’ come quello che accadde con il superamento dello strutturalismo. Io sono cresciuto in un ambiente che era in pieno fervore strutturalista. Negli anni sessanta-settanta non si parlava d’altro. Lo strutturalismo era un paradigma avvolgente, aveva un fascino straordinario. Ma dopo un po’ di tempo mi sono accorto subito che saremmo finiti in un vicolo cieco teorico se non fosse intervenuta un’attualizzazione nel nostro modo di intendere i problemi (e grandi maestri come Tullio De Mauro o Franco Lo Piparo lo intuirono in tempo). Per me fu decisivo l’approccio al naturalismo e alle scienze cognitive per uccidere lo strutturalismo con cui ero accademicamente nato e cresciuto.
Spinoza non si occupa di semiotica ovviamente, ma la provocazione è profonda: alla base di tutto, anche di questa “rifondazione”, è quel contenuto rivoluzionario del monismo ad oltranza. Più di Vico, più di Aristotele. Era un monista convinto ed assoluto, anticipando oggi il fondamento vero o presunto di ogni scienza. Vi è la necessità circa il fatto che non ci possa essere una scienza dualistica. La filosofia della mente che ancora insegue il dualismo io la trovo patetica: l’idea che non ci sia niente che possa essere spiegato in termini specificamente razionali, quindi smontandoli analiticamente, è per me la cosa più eccitante.
SF – Si vede come Spinoza, nonostante (o proprio a causa) del suo monismo, riesca elegantemente a giocare molto sui punti di vista circa l’esperienza, dalla prima alla terza persona e viceversa, come ha fatto anche lei nella tripartizione Korper-Leib-Umwelt, in cui cerca di ordinare il tutto in una trama unitaria basata sul profilo esperienziale di un modo immerso in un tessuto relazionale.
AP – Esatto. Io non attribuisco a Spinoza queste idee, ma le traggo da altre letture e altre formazioni. Però, se non avessi letto Konrad Lorenz, Von Uexküll e l’etologia moderna, il concetto di Umwelt non sarebbe mai entrato nel mio lavoro, ed in particolare nella definizione delle cecità cognitive. Spinoza lo anticipa proprio perché lui era veramente un etologo ante litteram, compreso il suo ironico rapportarsi con la boria dell’antropocentrismo. La sua stessa idea di cognizione e di conoscenza dipende esclusivamente da questo principio centrale che sta alla base del triangolo Leib-Korper-Umwelt e all’unità della natura umana che ho sussunto come pietra angolare della mia ricerca. Questo, in un certo senso, era ciò che la mia lettura mi portava a fare leggendo Spinoza. Ci sono altre cose invece che ho imparato da zero. La più toccante, e che, credo, ci tocca tutti è quella secondo cui: “la felicità o l’infelicità dipendano solo dalla qualità dell’amore”. Cosa significa la “qualità dell’amore”? La qualità dell’amore la stabiliamo noi e non pertiene all’oggetto dell’amore (che sia bello, intelligente, ecc.): non è un portato dell’oggetto dell’amore, ma è un portato del nostro desiderio – che lo si legga come una particolare orexis aristotelica o il nostro conatus di spinoziana memoria. La qualità dell’amore come portato del nostro desiderio ci porta a vederci negli oggetti e nella narrazione che noi ci costruiamo. Questa spiegazione razionalistica – che magari tanti deluderà – non ci dà una ricetta che ci spiega la qualità dell’amore, ma dice che la qualità dell’amore la moduliamo noi nei nostri processi di significazione (come diceva Platone: noi siamo il simbolo di noi stessi in qualunque cosa noi cerchiamo, e cerchiamo il simbolo di noi stessi in qualunque cosa cerchiamo). Noi, nella nostra mente, nei nostri desideri, ci proiettiamo sulla figurazione o sulla narrazione che facciamo dell’oggetto di amore. E proprio a questo che penso di dedicare il mio prossimo libro.
SF – Infatti, lei ribadisce molto idea della qualità dell’amore che trae dal Breve Trattato che cita spesso. Cosa ritiene di aver visto lì che non si trova nell’Etica?
AP – La lettura più immersiva di Spinoza che ho fatto è l’Etica, a cui mi riferisco di continuo in tutto il libro. Tuttavia i suoi prodromi e anche certe parti inesplorate stanno anche nel Breve Trattato ed in altri scritti minori. Il suo capolavoro indiscusso resta ovviamente l’Etica, e tutta la sua ricostruzione della mente come idea del corpo è lì contenuta in maniera sistematica. Ma soprattutto la psicologia dei sentimenti, che mi ha sorpreso e appassionato, nasce nel Breve Trattato, e non è poco. Anche perché si tratta di un'opera molto poco conosciuta.
SF – Data la prospettiva dello scienziato cognitivo, tale qualità dell’amore delinea una facoltà etologica che gode di una sua specie-specificità particolare?
AP – Sì, non sarebbe ripetibile negli animali. L’affermazione spinoziana secondo cui la qualità dell’amore la decidiamo noi con la costruzione dell’immagine dell’oggetto d’amore ha una dimensione puramente umana, dipendente dalla sua specie-specificità. Questo sarebbe impossibile per gli animali, essi infatti non hanno la mediazione del linguaggio articolato, quindi non hanno la possibilità di costruirsi un'immagine mentale o una narrazione dell’altro. In sostanza, questo spiega anche perché l’anoressia è una grande patologia dell’amore. Tutte queste patologie, che tratto nella prima parte del libro, sono il frutto di un principio fortemente spinoziano, il “perseverare in existentia”, che Darwin chiamerà “selezione sessuale”. Anche se “giusitificati” in mille diversi modi, tutti i comportamenti patologici che analizzo sono ispirati dalla selezione sessuale: la ricerca dell’attrattività che determina l’anoressica a dimagrire, il vigoressico ad ingrossare a dismisura i muscoli, lo scempio corporeo sistematico del body hacking, etc. Tutti questi soggetti vogliono in realtà essere più attrattivi: questo è un principio semplicissimo che diventa architettura del meccanismo selettivo. Naturalmente c’è di mezzo la trasformazione dell’immagine mentale: io sento che devo essere attrattivo, perché mi vedo attrattivo solo se scompaio, se divento un palestrato o se mi tatuo. Tutto questo si media attraverso una molteplicità di agency e contesti naturali e culturali, e tutto questo fa parte dello stesso principio naturale che è il principio della conservazione della specie, che in Spinoza si può facilmente derivare dall’idea di conatus; tant’è che l’idea di perpetuazione è molto darwiniana. Se metti assieme i principi naturalistici specifici come quello della selezione sessuale, i principi semiotici dell’immaginazione e quindi della capacità di crearci narrazioni, quello che si struttura d’innanzi a noi risulta un modello molto forte, ad alto valore euristico.
SF – La biosemiotica ovviamente poco può fare per togliere l’empasse o il pericolo che si cada nell’antropocentrismo con queste affermazioni. Questo proprio a causa del vincolo della narrazione, nonostante alcuni studi sull’interpretazione negli organismi biologici, ad esempio lo studio del fenomeno di scaffolding e della scala di grandezza su cui un organismo si può costruire un Umwelt proprio. Abbiamo in mente, ad esempio, gli studi di Kalevi Kull sui meccanismi di sintesi proteica, i quali possono aprire alla considerazione che vi sai, se non una vera e propria narrazione, almeno una certa scala di libertà – o di “creatività” – nel definire i codici di associazione tra i codoni del mRNA letti dal ribosoma e gli anticodoni del tRNA.
AP – Senza volermi addentrare in spiegazioni troppo tecniche (che nel libro sono intenzionalmente “recluse” nel cap. VIII), mi pare giusto precisare che non dovremmo confondere gli adattamenti evolutivi biochimici con processi volontari, espliciti, come la creazione linguistica di immagini mentali. Il desiderio animale, infatti, non passa mai per la narrazione, anche se metaforicamente si possono scorgere forti similitudini tra il desiderio animale e quello umano. Il pavone lo puoi mettere a paragone con l’anoressica, perché il pavone, con la storia che il suo ventaglio dev’essere sempre più grande, è diventato incapace di volare e ha acquisito una serie di caratteristiche che lo hanno danneggiato molto. Sono quelle che individuo nel libro come effetti di mostruosità presenti sia nel mondo animale che in quello umano. Tuttavia è questa la differenza: l’animale e l’umano sono tutti e due basati sul principio della selezione sessuale, ma la selezione sessuale del pavone è completamente indipendente, è genetica. Il pavone non ha nessuna coscienza delle sue trasformazioni corporee, sono codici iscritti a livello filogenetico. Invece, le trasformazioni del corpo che si hanno con qualunque dei fenomeni che indico nella prima parte del libro (anoressia, vigoressia, body-hacking, ecc.) sono estremamente volute, perché prodotte dal ricercare la corrispondenza con l'immagine dell’attrattività che abbiamo codificato nelle aspettative individuali e/o collettive. È questa la differenza invalicabile tra l’animale umano e gli altri animali. Gli altri animali, non avendo il linguaggio, non sono capaci di costruire una rappresentazione o un'immagine di se stessi: questo non significa che il linguaggio è un vantaggio, può anche essere uno svantaggio per l’evoluzione.
SF – Quanto il paradosso nurture vs nature colpisce questa argomentazione? Si può parlare di mediatezza nell’individuazione della qualità, oppure la cosa è differente? Ad esempio, ci viene in mente quanto anche nella stessa semiotica vi sono grandezze che dipendono in gran lunga dal grado di convenzionalità di un rapporto, e di come, ad esempio, gli schemi culturali subentrino assieme agli schemi di stimolazione percettiva nel riconoscimento di un segno iconico (esempio ad Eco molto caro, quello del cavallo per gli Aztechi).
AP – Certamente. I fatti culturali (sub-speciae Umwelt, però) incidono molto. Appunto perché frutto di “rappresentazioni”. La qualità dell’amore è già un concetto mediato dalla rappresentazione, perché io, a seconda dell’immagine che mi costruisco, a seconda del mio desiderio, costruisco anche il referente della stessa. Quindi il modello di amore cambia quando mi convinco che l’immagine è un’altra. Barthes ha rintracciato in Goethe l’esempio di questa costruzione del modello, quando spunta un neo sulla faccia della donna e il narratore da quel piccolo punto ha capito che l’immagine si è rovinata ed è finito l’amore. Questo spiega perché le caratteristiche che ricerchiamo non sono poi così “reali”, ma sempre mediate da quello che noi desideriamo. Se si capisse questo si comprenderebbe moltissimo anche della psicologia dell’amore. Sarebbe rivoluzionario. Con i miei studenti ho approfondito questo punto, perché ho posto loro davanti gli studi moderni della psicologia evoluzionistica che spiegano molto bene come il principio della selezione naturale trasformi in profondità l’uomo “culturale”. Per esempio, quanto il potere o il denaro incidono oggi nella selezione sessuale femminile? Ovviamente tantissimo (come dimostra David Buss in Evolutionary Psychology). E ciò non è una cosa che contraddice il principio naturalistico perché quest’ultimo viene sempre mediato dal linguaggio e dai valori che quel linguaggio porta con sé.
SF – Per finire, possiamo dire di aver fatto un discorso strutturato su uno scambio simmetrico e biunivoco, che vede la filosofia e le scienze cognitive quali suoi termini. Prendendo un esempio vicino a noi, ovvero l’esempio di uno studente che dalla filosofia si avvicina alle scienze cognitive, con quale chiave costui riesce ad esperire la pacificazione di queste due voci disciplinari, in particolare in un dominio così complesso da trattare come Spinoza e la sua eredità? Come uno studente di storia della filosofia può leggere il suo libro senza riscontrare difficoltà nella sua lettura funzionale (ho in mente la questione degli attributi o la differenza tra idea corporis e idea ideae); oppure come uno studente di scienze cognitive può approcciare Spinoza senza andare a riscontrare problematiche per le medesime questioni?
AP – Penso che il segreto consista nell’adattabilità del piano di studio a questi nuovi e continui stimoli. Nessuno si deve attaccare a determinate idee o impostazioni, e neppure a quelle delle scienze cognitive. Le scienze cognitive vanno continuamente elaborate finché non si cambia il paradigma. Se si vuole fare il ricercatore si deve capire come risolvere i problemi, e nient’altro. Non si deve appartenere a una squadra o a un'altra: gli elementi di parte, di scuola, vanno usati, ma se vi è qualcosa che non quadra va affrontata senza fondarsi sul valore dogmatico dell’auctoritas. È d’altrocanto l’eredità più importante dell’Illuminismo. Ciò vale ancor più se il nostro campo di ricerca è la filosofia.

Elia Pupil (Udine, 1999): Studente del corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche all’Università di Bologna; i suoi interessi vertono sui campi della filosofia della scienza e della tecnica, specificatamente sul rapporto tra semiotica, IA e scienze cognitive. Tra i vari progetti a cui ha partecipato, segnala la stesura di un’intervista-dialogo a sei mani “Con Toni Negri” insieme al pensatore italiano (Con Toni Negri. Intervista di Francesco Barbetta ed Elia Pupil – GramsciOnline).

Eduardo Serna (São Paulo, 2000): Studente del corso di laurea magistrale in Scienze Filosofiche presso l’Università di Bologna. I suoi interessi si focalizzano sulla teoria dell’immaginazione nella filosofia di Spinoza. In particolare, mi interessano i problemi che riguardano la costituzione della soggettività e dell’identità, oltre che le connessioni con le sue molteplici sfaccettature semiologiche, neuroscientifiche e psicologiche.