Uhlmann, J. M. Coetzee: Truth, Meaning, Fiction
Recensione di Alessia Veca
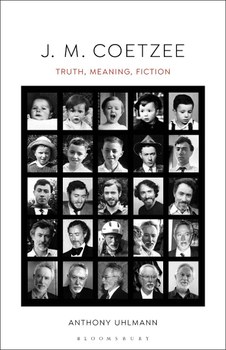
J. M. Coetzee: Truth, Meaning, Fiction indaga l’attitudine filosofica di J. M. Coetzee, importante scrittore contemporaneo, in riferimento ai contenuti dei suoi romanzi, e, soprattutto, alla forma di essi. Anthony Uhlmann, autore del volume, sostiene che il contributo filosofico di Coetzee non si limiti al confronto con temi etici, politici ed epistemologici tramite la rappresentazione di immagini o situazioni, ma sia composto anche dalle scelte stilistiche del romanziere australiano.
In particolare lo stile viene definito “provocatorio”, tende, infatti, a presentare delle questioni, spesso molto profonde, senza risolverle, né proporre un punto di vista preciso. Uhlmann individua tre tipi di “provocazione”. In primo luogo, pare che Coetzee suggerisca la possibilità di trovare la verità attraverso la finzione, sottintendendo che le storie possano realmente guidarci verso delle verità. La seconda provocazione, invece, si configura nella parodia e nelle modifiche della fattualità che sono proposte nei vari romanzi, le quali aprono discussioni sulla veridicità delle fonti e delle nostre conoscenze. Infine, una provocazione di genere più “epistemologico” è individuata nel metodo che Coetzee sembra proporre per la ricerca della verità: al posto del classico ragionamento logico-argomentativo viene designata l’intuizione.
Il volume presenta Coetzee come uno dei personaggi più importanti della scena letteraria contemporanea, sottolineandone le peculiarità e le innovazioni, e mettendole, al tempo stesso, in confronto con le influenze dell’autore. Egli si è dimostrato, infatti, sin dai suoi primi lavori un grande conoscitore e studioso della letteratura e della filosofia, le sue opere vantano influenze di profondo spessore, da Platone a Nabokov, da Aristotele a Damasio, da Bergson a Deleuze. Al tempo stesso, combinando teorie anche molto diverse tra loro e proponendo una scrittura nuova, Coetzee si impone come artista e filosofo insieme. Anthony Uhlmann, tramite un’analisi precisa e puntigliosa, lo rappresenta in maniera dettagliata e ne sottolinea il valore letterario, meritatamente attestato dal Premio Nobel per la Letteratura del 2003.
Il testo, inizialmente, si confronta con le più importanti voci della storia della filosofia che hanno lavorato con il concetto di intuizione, concetto essenziale per l’intero volume. Vengono menzionati e brevemente esplicati i pensieri di Platone, di Aristotele, di Descartes, di Spinoza, di Kant e di Bergson, e vengono sottolineate le influenze che questi autori hanno esercitato su J.M. Coetzee. Uhlmann evidenzia quanto questo concetto, fondamentale nella “filosofia” coetziana, sia stato presente nella storia culturale dell’occidente fin dall’Antica Grecia e si sia evoluto nel corso dei secoli, modificandosi a seconda del contesto: dall’essere definito “inspirazione”, in un’accezione più spirituale, all’essere assimilato al concetto di “preconscio” in Damasio, neuroscienziato contemporaneo.
Sono, in secondo luogo, analizzate le influenze letterarie di Coetzee, in particolare, Beckett e Nabokov. La prima è facilmente osservabile nella Dissertazione su Beckett scritta nel 1969, e permane nell’intero corpus. Si esprime nell’”importanza del ritmo”: Uhlmann nota come Beckett, e, in seguito, Coetzee, siano soliti strutturare i loro testi per opposizioni. Di frequente strutturano le frasi affiancando una negazione ad una affermazione, suddividono un testo ponendo sezioni contrapposte in continuità tra loro e così via. L’importanza del ritmo, dell’armonia data dall’alternanza, è, così, essenziale nei lavori di entrambi. É, inoltre, identificata come di ascendenza beckettiana la corrispondenza tra forma e contenuto degli scritti coetziani.
Già entro le prime quaranta pagine del volume, quindi, il professore della Western Sydney University mostra come lo stile sia portatore di significato. Questo tema viene rafforzato nel confronto con Nabokov. In particolare, l’influenza del geniale autore del 1900 è evidenziata tramite l’analisi del romanzo giovanile Dusklands (1974), tradotto in Terre al crepuscolo. In esso, sono ripresi i metodi parodici di Nabokov: in particolare, nella seconda parte dell’opera The narrative of Jacobus Coetzee, l’apparente ripresa di un resoconto storico è disseminata di modifiche ed omissioni. La fattualità è discussa, gli errori di aderenza al testo originale non sono casuali, ma vengono utilizzati come metodologie vere e proprie, le quali spingono a riflettere sul carattere dell’autorialità e della veridicità. Uhlmann mostra come le scelte stilistiche e di composizione di un testo portino a riflessioni filosofiche e stimolino il pensiero nel lettore.
Nel quarto capitolo l’analisi si sposta su Waiting for the Barbarians, in italiano Aspettando i Barbari. Questo testo è stato di frequente studiato come critica alla società sudafricana degli anni quaranta e cinquanta e, in particolare, all’apartheid, temi che dagli anni ottanta in poi hanno occupato largamente i lavori di Coetzee. Uhlmann, però, senza negare l’evidente impegno politico ed etico di questo testo, ne sottolinea la prospettiva formale ed epistemologica: questa novella, infatti, suggerisce l’accesso alla verità tramite due percorsi. Il primo è quello dell’intuizione, che presenta sempre il rischio di essere una falsa intuizione quando non affiancata dallo sforzo della comprensione, il secondo consiste nell’interpretazione, che il romanzo spesso ci spinge a svolgere. L’arte viene, quindi, presentata come metodo per raggiungere la verità, e viene al contempo descritta come punto di incontro tra etica ed etologia. Uhlmann relaziona il corpus coetziano a pensieri quali quello di Deleuze e di Spinoza. Osserva che in ognuno di loro si trova un’intersezione tra i tre ambiti citati: l’arte, l’etica e l’etologia. Essi si occupano, infatti, di una sola materia, del vivere, ed è per questo motivo che sono strettamente dipendenti l’uno dall’altro. Durante la riflessione è evidenziata da Uhlmann una caratteristica dell’uomo che permette di entrare il contatto con il mondo della vita (perciò con l’etica, l’etologia e l’arte): la simpatia, concetto chiave in moltissime opere di Coetzee, a partire da Elisabeth Costello. La tesi di Uhlmann, che coincide con quella di Elisabeth Costello stessa, sostiene che la simpatia umana, ovvero la capacità del singolo di immedesimarsi con altri esseri, sia di per sé illimitata, e che il suo unico confine sia definito dai limiti dell’immaginazione. La simpatia, nota l’autore, è molto vicina ad un certo tipo di conoscenza teorizzato da Bergson. Quest’ultimo, altra grande influenza di Coetzee, distingue infatti tra intelletto e istinti. Gli istinti, similmente alla simpatia, sono forme di conoscenza immediate e proattive, permettono al singolo di comprendere in maniera diretta l’ambiente circostante e di reagire ad esso. L’intelletto, diversamente, è una conoscenza di forme, che, per quanto offra una visione più concettuale e complessificata, non è in grado di vedere il mondo per quello che è, poiché lo interpreta come statico. Uhlmann studia come questa distinzione, oltre ad essere in linea con le nuove scoperte neuro-scientifiche, le quali stanno sempre più investigando il mondo della conoscenza tramite il corpo, sia presente nelle opere di Coetzee. Non solo nel concetto di simpatia di Elisabeth Costello, infatti, si configura un nuovo percorso per il pensiero umano, che può superare i preconcetti della logica e i confini del linguaggio, per avvalersi di altri strumenti, quali i sentimenti, ma anche nel romanzo Life & Times of Michael K. viene perfettamente ripresa la teoria bergsoniana. Nel titolo stesso, infatti, nota argutamente l’autore, il termine Life si riferisce agli istinti mentre Times all’intelletto: Michael K. si presenta, così, come la sintesi perfetta tra queste due tendenze ed esplica ampiamente il concetto di coestensività tra etica ed etologia. Lui è, infatti, un uomo di azione, che entra in relazione e cerca di comprendere il suo intorno tramite il corpo, in particolare, tramite il giardinaggio.
Rispetto alla comprensione che supera il linguaggio e gli strumenti più “tradizionali”, Uhlmann cita Age of Iron, Età del Ferro, romanzo del 1990, nel quale lo sviluppo della conoscenza al di fuori delle strade comuni è velatamente espressa. È espressa tramite figure extra-terrene che possono superare gli schemi umani, per esempio gli angeli, allusioni poetiche o bibliche e forme di comunicazione non convenzionali, come lo sguardo o i movimenti della bocca. In questo volume la conoscenza non è argomentata ma “sentita”, esattamente come suggerisce la stessa Elisabeth Costello nell’omonimo romanzo, il suo scopo è far “sentire i pensieri”. In quest’ultimo testo l’attitudine provocatoria, utilizzata come metodo di scrittura, viene accentuata, così come in The master of Petersburg, opera che si presenta senza dubbio come la più provocatoria dell’intero corpus coetziano.
Il volume conclude gli ultimi capitoli proponendo una visuale sulle cosiddette “autobiografie finzionali” e su The childhood of Jesus, L’infanzia di Gesù, mostrando che anche essi indagano il rapporto tra ragione e intuizione, tra conoscenza logica e conoscenza emotiva, tra finzione e verità. Si deduce, nel corso dell’argomentazione di Uhlmann, che la verità ha un legame particolare con la finzione, e, soprattutto, con le storie. Tramite le storie, infatti, è possibile creare delle verità, costruire dei pensieri che potenzialmente possono divenire delle convinzioni, o, addirittura, delle certezze. Al contempo, l’arte e le storie sembrano aprire ad un senso nuovo, ad una verità che, senza esse, ci sarebbe preclusa.
La conclusione mostra come la conoscenza sia strettamente legata alla verità ed alla finzione, all’arte e alla realtà, e come sia necessario intenderla come un processo piuttosto che una meta.
J.M.Coetzee: Truth, Meaning, Fiction permette di immergersi nella “filosofia” di Coetzee, osservandone la profondità e l’innovazione. L’indagine di A. Uhlmann è molto sottile ed attenta, riesce a cogliere gli intenti dell’autore e a riconoscerne le influenze filosofiche. I punti di contatto tra la storia della filosofia ed i capolavori dello scrittore australiano sono osservati con puntualità e descritti con ampiezza, i legami che vengono mostrati tra Bergson e Michael K., tra Platone e The childhood of Jesus, tra Spinoza ed Elisabeth Costello non solo sottolineano l’erudizione e l’acutezza di Coetzee, ma vivificano al tempo stesso i pensieri dei grandi filosofi del passato. Grazie a questi paragoni è possibile osservare come le “intuizioni” della storia della filosofia siano vive e presenti tutt’oggi, non solo nel mondo reale ma anche nel mondo dell’Arte e della Letteratura. Grazie all’analisi di Anthony Uhlmann, infatti, è possibile notare come la filosofia e la letteratura dialogano e si intersecano, offrendo nuove prospettive e nuovi percorsi di pensiero. Questo tema è evidente nei romanzi di Coetzee, ma l’acutezza di Uhlmann si sviluppa nell’intercettare i metodi e gli strumenti più particolari che lo scrittore australiano utilizza per stimolare il pensiero. Il tema principale del libro è, infatti, quello di investigare lo stile e le metodologie coetziane, spaziando oltre la semplice contenutistica e presentando un artista che non solamente è in grado di affrontare tematiche etiche e politiche, stimolando riflessioni tramite racconti avvincenti, ma è così sopraffino da poter offrire un contributo filosofico attraverso la forma dei suoi testi.
Grazie all’analisi di Uhlmann, è possibile conoscere l’innovazione e l’acutezza di Coetzee, il quale, oltre a riprendere grandi voci della filosofia, si avvicina particolarmente al mondo delle nuove scoperte neuroscientifiche. Il legame che Uhlmann sottolinea tra etologia ed etica, tra la conoscenza delle forme e la comprensione “diretta” offerta dagli istinti o dalla simpatia, è, infatti, perfettamente in linea con le scienze cognitive di seconda generazione. Uhlmann offre, così, una prospettiva che permette di notare la combinazione in Coetzee di passato e presente, di idee secolari, quali l’intuizione, ed idee rivoluzionarie, quali la potenzialità della simpatia.
In aggiunta, Uhlmann è uno scrittore particolarmente chiaro nell’espressione di concetti filosofici, che vengono presentati senza eccessivi fronzoli e con la giusta profondità. Spesso l’autore, legando teorie filosofiche e romanzi coetziani, riesce a spiegare ambedue e fornirne un’interpretazione particolare ed interessante. Differente è l’introduzione del concetto di intuizione, che riporta pensieri di grandi filosofi, senza relazionarli ad un argomento tangibile, ma limitandosi a una descrizione puramente astratta. Più avvincente è, nel corso del volume, la presentazione dei temi in relazione ai singoli romanzi: ad ogni teoria filosofica o caratteristica coetziana viene abbinato un testo paradigmatico. Così, l’analisi panoramica di Coetzee, che il volume riesce egregiamente a proporre, viene articolata con riferimenti tangibili ai singoli romanzi.
Il volume è di sicuro interesse per i conoscitori di Coetzee; un buon livello di familiarità con l’autore è consigliabile, affinché la lettura possa risultare chiara e scorrevole, mentre una conoscenza della storia della filosofia non è assolutamente necessaria, essendo le spiegazioni di Uhlmann complete e limpide. J.M.Coetzee: Truth, Meaning, Fiction non è stato tradotto in italiano. L’inglese di Uhlmann è un inglese accademico di alto livello: nonostante la coerenza e la logicità che lo rendono particolarmente accessibile, va dunque prevista una buona conoscenza linguistica.
Riferimenti bibliografici
Uhlmann, Anthony. 2020. J.M.Coetzee: Truth, Meaning, Fiction. New York: Bloomsbury Academy.

Alessia Veca, laureata in Filosofia all’Università degli Studi di Milano, è attualmente studentessa di Scienze Filosofiche presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. I suoi interessi investono diversi ambiti, dall’antropologia alla filosofia morale, dalla pop-filosofia alla poetica. Durante il suo percorso di studi, ha vissuto per due periodi all’estero, a Oviedo (Spagna) e a Hobart (Australia).