Taddio, "Maurice Merleau-Ponty. L’apparire del senso"
Recensione di Alex Turra
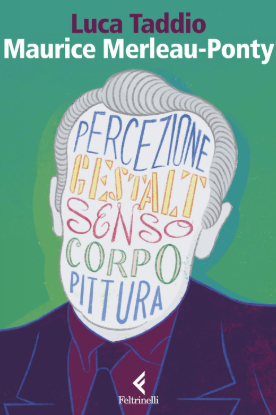
Quali sono gli snodi concettuali di base del prolifico pensiero di Maurice Merleau-Ponty? E in che modo i contributi del filosofo francese, morto prematuramente nel 1961, possono essere ancora oggi riutilizzati, aprendo a nuove disamine filosofiche sugli sviluppi del nostro futuro prossimo? Sono queste le principali sfide a cui Luca Taddio, docente di Estetica presso l’Università di Udine e autore di diversi saggi dedicati all’intersezione tra fenomenologia della percezione ed esperienza estetica (tra questi Fenomenologia eretica. Saggio sull’esperienza immediata della cosa, Milano-Udine, Mimesis, 2004), va incontro con quest’ultimo volume. Pubblicato nel 2024 da Feltrinelli, nella collana “Eredi” diretta da Massimo Recalcati, il testo si propone di ripercorrere un autore che, benché possa dirsi già frequentatissimo nei lavori di bibliografia secondaria, gode di molteplici possibilità interpretative, tali da aprirne il pensiero non solo a contributi di settore, inerenti la storia della filosofia francese del secondo dopoguerra, ma anche alle ultime evoluzioni del XXI secolo, come dimostrano ulteriormente le preziose pubblicazioni sui temi dell’ecologia e del gioco di Prisca Amoroso e Gianluca De Fazio.
Senza considerare «le pieghe della sua esistenza» (p. 17), evitando quindi di scadere in un approccio di tipo biografico-storicistico, Taddio riesce perfettamente a tenere insieme quel doppio movimento di lavoro tra introduzione e innovazione di un pensiero, restituendo un Merleau-Ponty sia in termini classici (da manuale) che proiettato verso nuove possibili applicazioni delle sue riflessioni. Se da un lato si ritrovano tutti i punti di introduzione al complesso lavoro filosofico di questo maestro del Novecento, capaci di evidenziarne tanto l’intreccio con le variabili fenomenologiche ereditate da Husserl quanto gli studi di psicologia (con particolare riferimento alla Gestalt), sino all’interesse per l’arte di Cézanne e la letteratura di Proust, dall’altro lato questa fenomenologia delle relazioni tra “mondo” e “Leib”, in Taddio, non può che cercare una messa in pratica in quei nuovi processi di trasformazione digitale di cui Merleau-Ponty non poteva esperire, ma a cui il nostro presente va incontro, proiettandosi in questo modo sulle questioni scoperchiate dalla possibile ibridazione tra il corpo e gli ultimi sviluppi tecnico-scientifici.
Ed è focalizzandosi sui nuclei teorici tanto della fase precedente quanto di quella posteriore alla pubblicazione della Fenomenologia della percezione del 1945 che la citazione di Nietzsche, tratta dalla Nascita della tragedia e posta come epigrafe al testo, diventa emblematica di quella doppia valenza, di introduzione e di progressione, sopracitata. Con le parole del filosofo che apre al XX secolo – “Solo come fenomeno estetico l’esistenza e il mondo sono eternamente giustificati” – Taddio riassume preliminarmente tutta la pregnanza filosofica di Merleau-Ponty, richiamandosi così ai punti focali del suo pensiero, come la centralità dell’arte e la rilevanza del campo filosofico che indaga il processo tramite cui le cose ci appaiono, ovvero la fenomenologia. Eppure quelle parole non possono che interpretare anche il rifiuto, che Merleau-Ponty condivide implicitamente con Nietzsche, di concepire la realtà come naturalmente scissa tra “illusione” e “verità”, offrendo un giudizio di presunta stabilità della realtà a partire da dogmi imprescindibili. Ecco che grazie a Nietzsche, Taddio recupera quell’elemento di introduzione a Merleau-Ponty – per cui tutto si staglia sul piano di quell’apparire fenomenico che ci colpisce e fa dell’esperienza immediata l’unico piano di azione possibile – sancendo inoltre la posizione nietzschiana di Merleau-Ponty (una reinterpretazione de “La morte di Dio”) – per cui è necessario rigettare i valori dualistici della tradizione metafisica occidentale, al fine di nobilitare nuovamente la relazione tra il “soggetto” e l’“oggetto”. Usando direttamente le parole dell’autore, nel volume si pone dunque «Merleau-Ponty a un crocevia in cui le strade divergono o si ricongiungono, a seconda del punto di vista assunto; […] da un lato da irraggiamenti verso nuovi percorsi e, dall’altro, da convergenze verso un nucleo teorico di base» (p. 13).
L’analisi della relazione tra “apparenza” e “realtà”, assieme al riconoscimento per cui tutto inizia a partire dall’esperienza diretta mediata dalle singole percezioni che abbiamo del mondo che ci circonda, si può considerare il fil rouge tra i vari capitoli e, non a caso, già dai primi cinque Taddio inizia a sondare il pensiero di Merleau-Ponty facendo del “problema dell’inizio” (della conoscenza) l’argomento con cui delineare il proprio nemico: la scienza moderna. Non si tratta di sconfessare in toto la Scienza, con cui tra l’altro Merleau-Ponty ha sempre lavorato a stretto contatto (e lo dimostrano anche i molteplici esempi ripresi dall’autore del testo), quanto più di riconoscere come quel momento di giudizio “assolutizzante” che essa pretende di apporre sia, in verità, anch’esso la restituzione di una determinata prospettiva, un punto di vista implicante determinate relazioni e per questo in grado di rappresentare solo parzialmente, e non oggettivamente, l’esperienza: come puntualizza Taddio, anche in laboratorio ci si affida a quei medesimi “sensi” che altrove sono detti fonte di inganno, ma se «sono gli stessi sensi a cui ci affidiamo per vedere il dato misurato, non ci potrebbero ingannare anche in questo senso?» (p. 114). Espressione filosofica di questo approccio razionalizzante, che piega la realtà a un mondo di fenomeni oggettivi da sottoporre alle esigenze di una prospettiva unidirezionale, è Descartes. A partire dalla mossa solipsistica del cogito, la modernità, tanto scientifica quanto filosofica, ha spezzato la relazione tra “realtà” e “mondo”, restituendo solamente «un mondo fatto di cose apparentemente stabili e autonome» (p. 21). In altre parole, la tradizione filosofica occidentale si basa su molteplici forme di dualismo (mente/corpo, fenomeno/noumeno, ecc.) che pretendono di scindere, come nel caso della fenomenologia, il “percepito” dal “percipiente”, istituendo un’impossibile riconciliazione tra ciò che ha la funzione di essere colto (elemento passivo) e ciò che ha il compito, quasi teleologico, di analizzare e definire (elemento attivo). Distinzione che tenta di captare cosa i sensi offrano (fenomeno) e quale realtà oggettiva si disveli oltre l’illusione delle sensazioni (noumeno). Se dunque il metodo cartesiano, agli occhi di Merleau-Ponty, si configura come il regno dogmatico del giudizio acritico e dell’astrazione assoluta sulle cose, per il metodo merleau-pontiano è necessario tornare ad accorgersi di «quel silenzioso manifestarsi del mondo e delle cose» (p. 34) secondo un movimento di retrocessione che riconosca il piano precategoriale in cui si instilla il ruolo e la relazione del nostro corpo (soggettività) rispetto alle cose.
Il movimento a cui Merleau-Ponty ci induce implica, al fine di cogliere le “cose stesse”, il passaggio dalla fede nel soggetto al riconoscimento valoriale dell’apparire del mondo (esperienza) come dimensione percettiva che precede ogni momento linguistico-concettuale. Si tratta di un’operazione che rifiuta di racchiudere la realtà in categorie irremovibili, accettandone, invece, l’intrinseca ambiguità e relazionalità di cui si compone. Un percorso di “apertura” in cui si inserisce il confronto con l’arte pittorica e la psicologia della Gestalt (successivamente criticata per via di posizioni ancora oggettivistiche, cap. VII), avendo essa «il merito di aver posto in primo piano l’idea di ‘struttura’ anziché quella di ‘significato’» (p. 32). Rispetto a un approccio geometricamente categorizzante, la silenziosa dimensione estetico-percettiva, in particolare l’arte di Cézanne, è colei che, sapendo far parlare le cose da sé, accoglie i fenomeni nella loro complessità, vale a dire nell’interazione dei vari elementi della materia. Come ne La montagna di Sainte-Victoire, Merleau-Ponty non vuole reintrodurre un’ipostatizzazione, ma cerca di rieducare lo sguardo a cogliere la processualità e la dinamicità «che si affermano nel divenire delle forme, richiamando e inscrivendo il mondo della vita e del corpo alla virtualità dell’Essere» (p. 19). Ciò che insegna l’arte e che ha in comune con la fenomenologia è dunque l’atto del “tornare alle cose stesse”: passando da Cézanne fino a Klee, Merleau-Ponty fa dell’arte il mezzo con cui ritrovare l’espressività relazionale che avvolge tanto la “cosa” quanto il “soggetto”, il quale dismette dall’esperienza la propria posizione di superiorità di giudizio, cogliendo nel suo posizionarsi l’immanente dinamica relazionale capace di definire, di volta in volta, forme di vita diverse.
Dopo aver brevemente introdotto gli estremi di una filosofia della relazione nella prima parte del testo, è possibile identificare la seconda parte del volume di Taddio nella totalità dei capitoli restanti, dal sesto al diciannovesimo, considerandoli un insieme unico in cui, a partire da molteplici esempi tratti da Merleau-Ponty stesso (illusione di Zӧllner, esperimento di Ternus, ecc.), Taddio tenta di ricostruire la terza via merleau-pontiana. Il problema di un approccio di tipo tecnico-scientifico è, come brevemente accennato nella prima parte, il “realismo ingenuo”: una visuale naturalmente prospettica che, nel tentativo di riconoscere l’oggettività e dunque la manipolabilità, genera dei dualismi per via della presunta autonomia dell’individualità (primo polo), rispetto il mondo-ambiente (secondo polo) che la circonda. Un confronto tra poli – “soggetto” e “oggetto” – che non ne costituisce l’effettiva chiarificazione di senso, ovvero una comprensione nei termini di una relazione circolare, ma una presa di posizione epistemologica che riconosce questi enti come intrinsecamente indipendenti rispetto l’esperienza che se ne fa. Taddio offre così un ulteriore volto al nemico merleau-pontiano, poiché le diramazioni che tale modernità ha prodotto, da Descartes a Kant, confluiscono nella produzione di “-ismi” che, dall’empirismo fino all’intellettualismo, cercano di rendere ragione dell’osservabile, concentrandosi su uno solo dei due poli e mancando per questo «di cogliere il manifestarsi del contenuto fenomenico delle relazioni in gioco nelle dinamiche di campo» (p. 94).
Rispetto alla percezione immediata, infatti, l’intellettualismo (dal razionalismo al criticismo) descrive l’apparire della cosa sulla base di dati a priori, vale a dire a partire dal ruolo di giudizio assegnato all’intelletto, mentre l’empirismo, cogliendo gli elementi di base dell’esperienza (le sensazioni manifeste), si occupa di ciò che si deve vedere sulla base dello stimolo distale; tuttavia in ambedue i casi, ove ci si limiti ad analizzare uno solo dei due poli della relazione, «l’ordine di senso dell’apparire fenomenico non esiste» (ibidem). Questo confronto serrato dell’autore con la tradizione filosofica occidentale rappresenta forse uno dei contributi principali del volume di Taddio, il quale sceglie di definire “contenuto” e “materia d’azione” della fenomenologia merleau-pontiana disvelando altresì l’incapacità degli “-ismi” di afferrare pienamente la grammatica propria dei fenomeni. Se quest’ultimi si danno solo in quella relazione costitutiva dell’apparire fenomenico, che tanto l’intellettualismo quanto l’empirismo rifiutano di accogliere, la “rivoluzione copernicana” di Merleau-Ponty, in cui Taddio ci conduce, si costituisce così dal rifiuto di «imprimere il sigillo del concetto sulla cosa» (p. 104), rendendo ragione del fenomeno nella sua unità-interezza. In altri termini, «Merleau-Ponty intende sciogliere la dicotomia tra res extensa e res cogitans introducendo il corpo proprio (Leib) come cerniera di raccordo tra il mondo e la coscienza nella relazione soggetto-oggetto» (p. 111).
Per rendere ancora più effettiva la non-riducibilità della “forma” alla sola coscienza o alla sintesi degli elementi che la compongono, Taddio riporta il caso dell’illusione di Müller-Lyer (cap. XV), come emblema del riduzionismo in cui cade il metodo scientifico. Al fine di misurare il fenomeno ritenuto illusorio, dimostrando l’uguale lunghezza dei due segmenti paralleli, l’illusione in quanto tale viene spogliata della sua ricchezza espressiva, per venire sottoposta a «un’azione di astrazione (estrapolazione) rispetto all’apparire della cosa» (p. 115). Un esempio dalla valenza universale, di cui Taddio si serve per ricordare che ciò che si misura in laboratorio non è il fenomeno considerato pienamente nelle sue condizioni di apparenza al soggetto, e dunque nel suo presente fenomenico, ma, in virtù di un certo fine (ottenere dei dati oggettivi), si misurano solamente dei dati (nell’esempio citato la sola lunghezza dei segmenti). Una misurazione che rende sì manifesta l’illusione rispetto alla presunta realtà (presa di posizione epistemologica), ma che tuttavia non si esaurisce in tale atto, poiché continuiamo a vedere quei segmenti come prima, cioè in modo “illusorio” rispetto il righello: ogni aspetto di immediatezza del vissuto, «se dissezionato all’interno di un determinato quadro di indagine scientifica (fisica, chimica, fisiologica), evapora irrimediabilmente» (p. 134). Pur sapendo quale “realtà” sottostà all’illusione, cioè assumendo come riferimento lo stimolo fisico, gli aspetti del mondo fenomenico – come la presenza del triangolo sui cerchi (Kanizsa) o la bivalenza prospettica del cubo (Necker) – perdurano, a dimostrazione del “piano di immanenza”, come direbbe Deleuze, in cui si inscrive l’esperienza.
Nonostante il declassamento del fenomeno a mera “rappresentazione” stabile (anche Galileo ne è complice) non sia restituito in modo lineare all’interno del volume, tale sistematica ricostruzione del nemico è qui funzionale per affrontare la pars costruens di delineazione della fenomenologia di Merleau-Ponty, a cui Taddio dedica, pur sempre in modo tortuoso, altrettante forze. La via con cui l’autore sceglie di penetrare le maglie del fenomeno percettivo si configura come l’espressione del bisogno (quasi fisiologico) di «tornare a quello stato primordiale della percezione antecedente ogni possibilità di comparazione» (p. 67). Ed è solo nel contatto originario (esperienza) che si verifica quel ritorno alle cose stesse (fenomeni), capaci di offrirsi «al nostro sguardo [e non “occhio”, pp. 85-6] prive di mediazione, se non attraverso quel medium stabilito dal loro stesso manifestarsi all’interno di un orizzonte di senso» (p.107) e di cui è un esempio La durée poignardée di Magritte considerata da Taddio. L’errore delle scienze è infatti quello di trattare il fenomeno e la percezione in termini di passività e di ricezione, senza riconoscerne le leggi di organizzazione interna e le capacità di elaborazione per cui le cose non emergono in termini unidirezionali, ma solamente da giochi di riflessi e intrecci (chiasma) tra noi, gli altri e il mondo. È con l’abile paragone al comportamento che Taddio rende il fenomeno una struttura inscindibilmente complessa e comprensibile solo nel particolare rapporto che, di volta in volta, intrattiene con il mondo-ambiente che lo circonda e non riducibile a uno stimolo (così come il movimento cinematografico non si riduce ai fotogrammi della pellicola): si tratta di «cogliere la percezione secondo l’unico senso che le è proprio, ossia l’esperienza diretta del mondo e delle cose» (p. 85) che non tematizza un singolo sistema di riferimento, ma l’intera processualità comprendente tanto il mondo quanto noi stessi.
Taddio non lo esplicita direttamente ma anche il lettore neofita comprende come il movimento fenomenologico possa dunque dirsi doppio: ricalibrazione del modo di osservare (e non vedere) i rapporti e riconoscimento valoriale del piano fenomenico. Da un lato si pone la necessità di tematizzare l’intreccio che ci condanna al senso, cioè a «quella nicchia della realtà che emerge dalla relazione tra il nostro corpo e l’ambiente fisico attorno a noi» (p. 89). Rispondere perciò all’esigenza di “tornare alle cose” significa, in questo primo momento, coglierle nel loro aspetto pre-giudiziale, all’interno di quelle dinamiche relazionali del campo percettivo in cui l’invisibile configura il visibile. Ancora una volta, non è l’analisi dello stimolo sulla retina a definire le caratteristiche della cosa, ma è il piano fenomenologico della processualità a rivelarne l’espressività: una relazione che non si dà tra due elementi preesistenti, ma che assume una determinata processualità dallo stato di uno specifico sistema, che è inoltre possibile condividere intersoggettivamente. Usando le parole più semplici che lo stesso Taddio ha forse trovato, «il fenomeno percettivo prende corpo dalla relazione in quanto tale ed è essa che va assunta come costitutiva dell’apparire fenomenico» (p. 95) e non l’ingenua arbitrarietà di un soggetto che si pensa protagonista (le relazioni costitutive di una soggettività sanciscono l’impossibilità della sua esistenza oltre quel determinato nucleo di relazioni, pena la trasformazione).
Tale fenomenologia della relazione, dall’altro lato, necessita poi di ammettere che «possiamo vedere le cose solo da una determinata prospettiva [che] ci introduce alla loro “realtà carnale”» (p. 107). Un secondo momento di definizione fenomenologica che esclude ogni categoria di “apparenza” e “realtà”, in nome dell’apertura alla «verità del logos» (p. 108), in cui l’apparire si dà come virtualità dell’Essere (e non fonte di inganno), ossia nella propria immediatezza fenomenologica. È solo da tale cambio di paradigma che si può ammettere l’ambiguità costitutiva del fenomeno senza doverla svalutare a “illusione”, ma permettendo anche a quest’ultima di godere di dignità ontologica, poiché parte della virtualità della realtà che noi definiamo “mondo”: «ogni apparire in quanto tale risponde sempre a una virtualizzazione del reale» (p. 171). In termini sia anti-intellettualistici che anti-empiristici, Taddio ricostruisce così un Merleau-Ponty anti-moderno, contrario ad alcuna presa di posizione epistemologica rispetto ciò che deve essere valutato come “reale” o “apparente/illusorio” e aperto alla virtualità del reale, cioè a quell’idea per cui il reale sia un costante divenire in grado di assumere, ogni volta, senza necessità di giudizi, forme di meta-stabilità in base alle indissolubili relazioni fenomeniche che l’esperienza immediata restituisce (ogni relazione mediata da determinati rapporti genera specifiche proprietà emergenti che si danno solo nell’immediatezza dell’esperienza). Ed ecco perché, quasi con un’eco hegeliano, «ogni virtualità del reale è reale» (p. 117), ovvero perché esistono molteplici modi in cui il piano epistemologico incrocia quello ontologico, tanti mondi intrecciati a una sola realtà.
Riprendendo dunque la domanda metodologica di Taddio, «qual è l’orizzonte di pensiero che possiamo ricavare da […] Merleau-Ponty?» (p. 174). Ciò che rispetto tale domanda rimane certo è la presentazione del filosofo francese attraverso un approccio che permette al lettore, dopo un percorso fatto di arte, scienza, realtà, percezione e illusione, di cogliere “essenza” e “compito” della sua nuova fenomenologia delle relazioni. Da un lato un metodo, se non un’intera filosofia, che riconosce i molteplici mondi in quanto tali, mantenendoli intrecciati al medesimo piano di realtà, ma che dall’altro lato re-insegna «a guardare il mondo a prescindere dall’uso e dalle valutazioni [scientifiche] operate sul mondo» (p. 123), chiarendo, di volta in volta, il livello di realtà che si vuole indagare.
Ed è quest’ultima la chiave d’accesso con cui Taddio risponde alla domanda posta all’inizio del paragrafo precedente, re-costituendo le stesse virtualità applicative di Merleau-Ponty. Dinnanzi alle nuove evoluzioni tecnologiche del digitale e alle prospettive di integrazione tecnica del corpo (ibridazione), il movimento a cui la fenomenologia ci induce, per Taddio, rimane invariato, costituendo ancora quel richiamo alla “processualità”. Solo se analizzate fuori da categorie apparentemente stabili, le rivoluzioni del digitale, a cui il XXI secolo va incontro, potranno essere analizzate compiutamente all’interno della relazionalità e della complessità che le definisce, permettendo alla fenomenologia di interrogarsi persino sulla nostra soggettività: se l’ibridazione di corpo e tecnologia implica una radicale trasformazione del nostro “abitare il mondo”, per come l’abbiamo conosciuto sinora (Homo sapiens), ciò che rimarrà sarà l’intrinseco paradigma per cui «ogni forma di vita configura un senso in relazione al proprio rapporto con l’ambiente» (p. 154) ed è a quel punto che, forse, saremo costretti a tornare a Merleau-Ponty e alla sua fenomenologia, proprio per ripensare le dinamiche di senso emergenti dalla nostra nuova soggettività e guardare così il mondo con altri occhi.
Bibliografia
L. Taddio, Maurice Merleau-Ponty. L’apparire del senso, Milano, Feltrinelli, 2024
L. Vanzago, Merleau-Ponty, Roma, Carocci, 2012
M. Merleau-Ponty, La prosa del mondo, trad. it. di P. Dalla Vigna, Milano-Udine, Mimesis, 2019
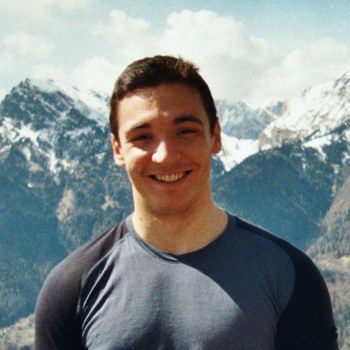
Alex Turra (2002) si è laureato nel 2024 in Storia delle Dottrine Politiche presso l’Università di Bologna, con una tesi sui processi di razionalizzazione nell’utopia di Gabriel de Foigny. Attualmente è tutor all'internazionalizzazione presso il Dip. di Filosofia e frequenta il I anno del CdS in Scienze Filosofiche all’Università di Bologna. Il suo ambito di interesse è la filosofia politica.