Mieli, "La gaia critica. Politica e liberazione sessuale negli anni settanta. Scritti (1972-1983)"
Recensione a cura di Francesco Pompili
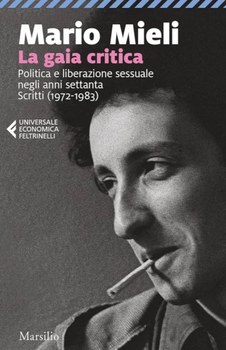
Frocix rivoluzionarix, intellettuale follemente lucidx e figura centrale della cultura italiana degli anni ‘70, Mario Mieli è statx ed è tutt’oggi una figura fondamentale per il movimento di liberazione sessuale e per lo sviluppo dei Gender Studies e della Queer Theory. Il suo pensiero, fortemente influenzato da una attenta e originale lettura del pensiero marxiano e della teoria freudiana, e al contempo in continuo dialogo con il pensiero femminista, analizza in maniera radicale e rivoluzionaria la repressione dell’Eros perpetuata dal Capitale e dal Patriarcato. Teoria e prassi sono inscindibilmente legate nella vita di Mieli, e la raccolta La gaia critica. Politica e liberazione sessuale negli anni settanta. Scritti (1972-1983), curata da sua sorella Paola e da Massimo Prearo, che ne raccoglie gli scritti più significativi, ritraccia il percorso compiuto da Mieli, arricchendolo attraverso la ricostruzione del contesto in cui questo si compie e la presenza di alcuni testi manoscritti, recuperati dal suo archivio personale. Il volume, accompagnato da un’introduzione e diviso in quattro sezioni (Articoli e interventi, Recensioni e critiche, Sulla stampa, Dialoghi e interviste), ciascuna delle quali ordinata cronologicamente, lascia emergere la poliedricità e l’ampiezza della riflessione che Mieli sviluppa durante la sua breve ma intensa vita; l’aggiunta di una biografia critica consente allx lettorx di ripercorrere la costellazione di eventi, esperienze e relazioni che più hanno inciso nella sua lotta per la realizzazione del “Regno della Libertà” (p. 217), mappando la sua traiettoria teorico-politica all’interno di una “geografia di esperienze” (p. 13). Ma cos’è la gaia critica? Quali sono gli spazi da cui nasce e in cui si muove? Chi sono i suoi nemici e quali i suoi obiettivi? Ma soprattutto, perché ad oggi ha senso per noi un recupero ed un confronto con il pensiero di Mieli?
La gaia critica nasce dalla critica omosessuale, ovvero dalla critica alla Norma eterosessuale quale “modo di produzione delle risorse umane e simboliche su cui poi si organizza la società e l’economia (Zappino 2019)” capitalista e patriarcale. Mieli, nella sua opera teorica fondamentale Elementi di critica omosessuale, edita per la prima volta nella collana ‘Saggi’ di Einaudi nel 1977 e tradotta in varie lingue, sistematizza tale critica che è al contempo “critica da un punto di vista omosessuale e critica del punto di vista omosessuale stesso” (p. 12); in Elementi concettualizza nozioni originali quali transessualità originaria, educastrazione, Norma eterosessuale, gaio comunismo, fondamentali per un’analisi innovativa e radicale delle modalità di dominio del capitale e per una loro sovversione, ed esplora tabù millenari (coprofagia, sadismo, masochismo, pederastia tra gli altri) che fino ad allora pochx avevano avuto il coraggio d’affrontare, ma che nessunx era statx in grado di porre all’interno di un percorso reale di liberazione. Costanti nella critica omosessuale sono il riferimento alla collettività, poiché, per Mieli, in tuttx vi è repressione sessuale e dunque potenzialità rivoluzionaria; alle proprie esperienze personali; alla teoria marxiana e a quella psicanalitica, che costituiscono i due pilastri teorici con cui si confronta, ma nella cui operazione di recupero esclude gli elementi ritenuti deboli e/o reazionari, come ad esempio il linguaggio fallocentrico di Marx.
La critica omosessuale è, dunque, teoria e pratica omosessuale rivoluzionaria. La gaia critica ne estende i confini, ne diversifica i registri linguistici, “ne manifesta e approfondisce i dettagli argomentativi, gli spunti esistenziali, le regioni teoriche e le implicazioni politiche” (p. 12): la precede, la attraversa, la oltrepassa. In questo suo nuovo aspetto polimorfo, la riflessione di Mieli si accresce, oltre che di prospettive antipsichiatriche, presenti anche in Elementi (Mieli 2017), di istanze antimilitariste ed ecologiste, soprattutto negli scritti risalenti agli ultimi anni della sua vita, come ad esempio “Appello per la pace” (p. 210). Ad accompagnare il suo cammino teorico vi è un metodo di ricerca fortemente legato alla prassi, che lx curatorx del volume definiscono “attivismo etnografico” (p. 14): questa scelta è estremamente efficace per mostrare allx lettorx quanto il lavoro critico che Mieli compie prenda le mosse direttamente dalle esperienze di repressione e violenza (maschile), fisica e psicologica, che quotidianamente subiva sul proprio corpo.
Immergendoci in questo “archivio esperienziale del presente” (p. 13), veniamo catapultatx per le strade torride della Marrakech degli anni ‘70 nei panni di unx travestitx che fa i conti con “il dramma di chi ha scoperto nell’oasi il vuoto angosciante della propria sofferenza e alienazione” (p. 49) e che affronta le prime forme di liberalizzazione e mercificazione della transessualità in quel “miraggio omosex” (p.47) che era Casablanca, per poi trovarci nella Berlino Ovest del primo raduno internazionale dei movimenti omosessuali rivoluzionari, dal cui reportage emergono, tra “corpi sudaticci, falli penzoloni e chiappe chiare” (p. 93), le pratiche di un internazionalismo dal basso, le difficoltà collaborative e le convergenze/divergenze, sia teoriche che pratiche, fra i vari gruppi. L’insistenza sul “processo mortifero della totalizzazione capitalistica” (p. 185), sull’alienazione violenta che lo sorregge e su una resistenza attiva e sovversiva contro tale processo, è il fil rouge che attraversa tutte queste esperienze: dalla pratica del travestitismo che “non risolve l’antitesi tra i sessi in una sintesi che è superamento dialettico”, bensì mette “in luce quest’antitesi, abbigliandosene” (p. 129), al fenomeno della prostituzione maschile che, visto da una prospettiva marxiana-metapsicologica, mostra come “la deviazione delle energie libidiche dalla meta sessuale rende possibile la loro sublimazione nella sfera produttiva” (p. 185) e come tale sublimazione alimenti e venga a sua volta alimentata da “gratificazioni palliative legate al privilegio fallico, gratificazioni che [inducono il sottoproletariato maschile] a considerarsi ‘qualcuno’ nell’ottica capitalistica della valorizzazione del sesso” (p. 187).
L’ideologia eterosessuale permea il quotidiano, le relazioni intrapersonali e il rapporto tra sé e sé, e il suo essere norma, anzitutto giuridica, le conferisce lo status di legge naturale alla quale l’umanità si conforma. Dallo spazio liminale che la Norma crea circoscrivendosi al centro dello spazio giuridico, è possibile vedere la contraddittorietà che si cela sotto la sua pretesa assolutizzazione: ed è proprio in tale spazio marginale che si trova la prospettiva omosessuale, insieme a quella femminista tra le altre, come Mieli ben rileva in “Dirompenza della questione politica omosessuale” (p. 98). La consapevolezza della condivisione di una dimensione comune, seppur differente, di oppressione e di lotta, è ciò che porta Mieli a confrontarsi in maniera diretta e critica con i movimenti rivoluzionari sorti negli anni ‘70 (femministi, omosessuali, autonomi) e alla cui nascita prende parte in maniera attiva, costituendo il F.U.O.R.I. (Fronte Unitario Omosessuale Rivoluzionario Italiano) e partecipando ai primi gruppi di presa di coscienza omosessuale e femminista. Il suo rapporto conflittuale con i movimenti militanti, causato da alcune dinamiche interne ad essi che Mieli denuncia come antirivoluzionarie e fortemente reazionarie, lx porta a rilevare gli snodi teorici e pratici in cui i movimenti dell’epoca s’affossano e a problematizzare tali snodi, in una prospettiva che permette a noi oggi di porre le basi per un’intersezionalità dal basso che riesca ad esprimere al massimo la sua dirompente potenzialità rivoluzionaria, per “combattere una lotta razionale, piacevole, aperta alla soprarazionalità” (p. 122).
È di questa lotta che oggi, io credo, avvertiamo la necessità. In questi “nuovi” anni Venti, in cui le fiamme del disastro climatico mischiandosi a quelle della guerra interimperialista mettono a rogo il pianeta e i nostri corpi, in cui la povertà dilaga e la salute mentale svanisce, evidenti e devastanti sono gli effetti che la dominazione capitalistica e la cultura patriarcale hanno portato, e continuano a portare, alle nostre vite: effetti che Mieli già prospettava e ipotizzava cinquanta anni fa (vedi Non c’è due senza tre, p. 208). Se le sfide di fronte a cui questo momento storico ci pone ci lasciano un senso di sopraffazione e di soffocamento, le riflessioni di Mieli, e La gaia critica in particolare, sono ciò che ci può ridare la forza per tornare a respirare ma soprattutto a lottare. Come scrivono lx curatorx nell’introduzione, “questa modalità gaia di attraversare il presente per farne teoria e pratica della liberazione sessuale, è metodo per pensare e praticare la liberazione individualmente e collettivamente dappertutto, sempre e comunque” (p. 16), dato che, come dice Mieli stessx, “la rivoluzione la si fa ovunque. A Macondo come in un tram, a Buckingham Palace come alla Breda, a pranzo dai genitori e a letto con l’amante. La parola d’ordine è AMARE: buttiamo A MARE la macchina capitalistica, e riprendiamoci il mondo. Quanti di voi sono in grado di sedurre un poliziotto?” (p. 230).
Bibliografia:
Mieli, Mario. 2017. Elementi di critica omosessuale. Milano: Feltrinelli.
Zappino, Federico. 2019. Comunismo queer: note per una sovversione dell’eterosessualità. Milano: Meltemi.
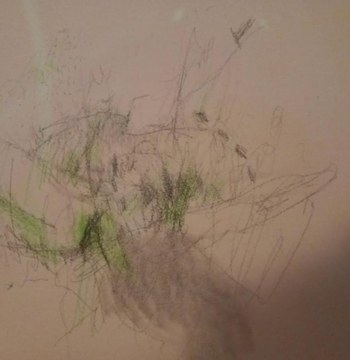
Nato a Fermo nel 2002, Francesco Pompili è uno studente di Filosofia dell'Università di Bologna e facchino sottopagato del mondo dello spettacolo. Tra i suoi vari interessi, quelli che più lo incuriosiscono ora sono la filosofia politica, la queer theory, l'antipsichiatria, le pratiche dell'autogestione e la Sound System culture.