Sette su dieci | Un’inchiesta sull’accesso all’aborto a Bologna
𝗦𝗲𝘁𝘁𝗲 𝘀𝘂 𝗱𝗶𝗲𝗰𝗶: un’inchiesta sull’accesso all’aborto a Bologna. Tra dati, storie e ostacoli, un racconto che illumina le difficoltà di un diritto spesso lontano dall’essere garantito.
Pubblicato il 07 marzo 2023 | Podcast
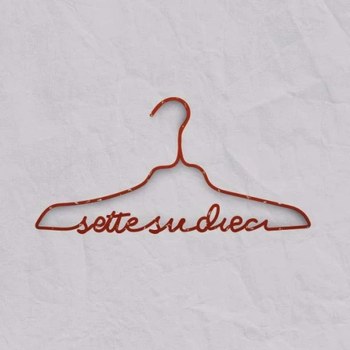
Immaginate di recarvi in un ospedale pubblico, quello della vostra zona. Avete un problema, qualcosa di risolvibile in day hospital, questione di poche ore. Il personale medico di turno, dopo avervi gettato uno sguardo sdegnato o magari mormorando qualche commento tagliente sottovoce, vi dice che gli dispiace, ma che lì non “fanno quelle cose”. Vi invita poi a provare da un’altra parte, non possono – o non vogliono – proprio aiutarvi. Assurdo, impensabile. Sareste indignati, magari confusi, e avreste ragione.
Questo è ciò che si sentono dire innumerevoli gestanti quando si rivolgono alla struttura sanitaria sbagliata, magari a una delle centinaia che hanno un tasso di obiezione di coscienza che oscilla fra l’80 e il 100%, oppure a una delle oltre duecento che, pur avendo un reparto di ginecologia e/o ostetricia, non effettuano il servizio di interruzione volontaria di gravidanza. E queste sono solo alcune delle barriere pratiche, sociali e morali innalzate dall’esercito di obiettori di coscienza, che a oggi nel Bel Paese sono quasi 7 ginecologi/he su 10, oltre 4 anestesisti/e su 10 e quasi altrettanti fra il personale non medico. Questi dati, già di per sé poco incoraggianti, nascondono criticità notevoli, poiché restituiscono un’immagine tardiva, parziale e sfocata dell’andamento e dell’efficacia della celebre legge 194/78. Eppure, sembrano essere sufficienti per il Ministero della Salute che, nell’ultima “Relazione sull’attuazione della legge contenente le norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza”, depositata in Parlamento l’otto giugno 2022, non ha indicato tali valori come problematici o sintomatici dell’inadeguata erogazione del servizio di IVG in territorio italiano.
Partendo da questi numeri significativi e a fronte del recente inasprimento del dibattito civile e politico sull’accesso all’aborto, il nostro lavoro d’inchiesta si pone l’obiettivo di stringere l’inquadratura e catturare una fotografia quanto più veritiera possibile dello “stato di salute” della l.194/78 a Bologna, città in cui viviamo e studiamo. Nata come progetto di natura conoscitiva, “Sette su dieci” è una serie podcast in quattro puntate che cerca di dare informazioni concrete, confrontando dati istituzionali e testimonianze dirette per rispondere a una domanda complessa: oggi quanto accessibile è, realmente, il diritto all’IVG a Bologna? All’interno di questo singolo quesito ne risiedono molti altri; del resto, il tema è molto ampio e svariate sono le chiavi di lettura per interpretarlo. In particolare, ci siamo chieste se la legge 194 venga applicata realmente e, se sì, cosa comporti; quanto ostacolanti siano, al di là della loro percentuale, gli obiettori di coscienza nella “Rossa”; e ancora, come l’IVG venga trattata all’interno del Dipartimento di Ginecologia dell’Alma Mater e come il tema “aborto” venga vissuto dalla società civile bolognese.
Ritorno al passato: il diritto di abortire nel 2023
Il 24 e il 25 giugno 2022, i media italiani riportano a caratteri cubitali una notizia appena giunta da oltreoceano: la Corte suprema americana ha ribaltato la storica sentenza Roe v. Wade, che dal 1973 aveva reso l’aborto legale negli Stati Uniti. Con questa decisione senza precedenti viene sancita la libertà per i singoli Stati di applicare le loro leggi in merito all’interruzione volontaria di gravidanza, con conseguenze gravissime per le soggettività residenti nei bacini più conservatori. A oggi, l’aborto è illegale in ben 11 Stati e milioni di persone hanno perso così una parte fondamentale del proprio diritto di autodeterminazione[1].
Questo fatto ha esacerbato un dibattito, quello sull’IVG, che nel nostro Paese non ha mai smesso di accendere gli animi, riportando il diritto all’aborto al centro della discussione pubblica e politica. La scelta americana ha ridisegnato con forza la linea fra i diversi schieramenti, provocando immediate reazioni di varia natura. Agli estremi, il filone oltraggiato che trova il proprio pensiero meglio formulato nelle parole dell’ex Ministra per le Pari opportunità, Elena Bonetti, che l’ha definita “una decisione che […] ferisce la dignità e i diritti delle donne”; e il gruppo apertamente favorevole capitanato dal senatore leghista Simone Pillon, che sul suo Facebook ha espresso il desiderio di portare “anche in Europa e in Italia la brezza leggera del diritto alla vita di ogni bambino”[2].
A settembre, a seguito della caduta del governo Draghi, si sono tenute in Italia le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Con la schiacciante vittoria della coalizione di centro-destra, guidata dalla leader del partito Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, le preoccupazioni di chi ha visto nella caduta della Roe v. Wade un inquietante cambio di rotta si sono intensificate. D’altra parte, la stessa Presidente del Consiglio si è sempre mostrata contraria alla lettura dell’IVG come un diritto di autodeterminarsi della donna, preferendo parlare di un vero e proprio “diritto a non abortire”, oltre ad aver firmato, già nel 2019, il “Manifesto per la vita e la famiglia in Europa” dell’estesa associazione ProVita & Famiglia[3]. Dall’insediamento del governo Meloni, il tema dell’interruzione volontaria di gravidanza non ha mai abbandonato i tavoli di discussione.
A oggi, dopo poco più di tre mesi di legislatura, sono state presentate quattro proposte di legge di carattere antiabortista. La più recente, avanzata il 13 gennaio 2023[4] dal senatore di FdI, Roberto Menia, preme per il riconoscimento della personalità giuridica dell’embrione dal momento stesso del concepimento. Se accettato, questo provvedimento di fatto impedirebbe l’accesso alle pratiche abortive, che sarebbero da considerarsi alla stregua di veri e propri omicidi. Non dissimile è stata la prima iniziativa, addirittura antecedente l’effettiva presa di potere del nuovo governo e presentata da Maurizio Gasparri (Forza Italia), per vedere riconosciute le capacità giuridiche del concepito. Le rimanenti, avanzate rispettivamente da Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, e da Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia, richiedono il riconoscimento del concepito come membro effettivo del nucleo familiare e l’istituzione di una Giornata dedicata alla “tutela della vita nascente”. Tali iniziative rimangono proposte inattuate, disegni di legge che non hanno sostituito in alcun modo la 194, né si prefiggono di attaccarla direttamente. Per il momento, la legge del 22 maggio 1978, n. 194, recante le Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria di gravidanza, rimane intoccata. Il rischio che tali proposte si traducano in azioni non sembra essere vicino, ma sarà il futuro a darne conferma. Noi ci siamo rivolti ai nostri intervistati e intervistate per scoprire quale sia la situazione dietro le quinte del dibattito pubblico.
Negli episodi del nostro podcast, attiviste, ginecologi e ginecologhe, studenti/esse e professori del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia prenderanno parola per fare il punto della situazione nella città di Bologna e per svelare, in ultima battuta, lo stato di salute della legge 194 nel capoluogo emiliano. Oltre alle criticità legate alla legge stessa, verranno esplorati temi come l’obiezione di coscienza, il fallimento dello Stato nel fornire dati aperti, utili e aggiornati, la colpevolizzazione morale e l’attività delle cellule “pro-vita” (o “anti-scelta”).
I problemi della l.194/78
Ciò che è certo è che la legge 194 presenta dei problemi su diversi livelli. C’è chi la considera una norma ormai datata, da rivedersi in virtù del periodo storico in cui ci troviamo; chi riscontra delle criticità nella formulazione del testo stesso della norma; e ancora, c’è chi evidenzia l’inadeguatezza dei dati forniti annualmente dal Ministero della Salute, come richiesto proprio dalla 194. Infine, è opinione diffusa che il problema principale della legge sull’accesso all’aborto sia l’obiezione di coscienza.
È tendenza comune, fra le voci raccolte nel corso di questa indagine, credere che la 194, seppur generalmente funzionante, possa e debba essere migliorata. Del resto, se Bologna si distingue come modello virtuoso per l’applicazione di suddetta legge, resta il fatto, testimoniato anche dai dati del Ministero, che nel resto dello Stivale l’accesso all’IVG rimanga disomogeneo e incerto, distribuito “a macchia di leopardo”.
Esistono degli elementi controversi della legge 194/78 che hanno ricevuto larga attenzione anche nella letteratura sul tema. Nelle nostre interviste abbiamo interrogato i rispondenti per sondare il loro pensiero e la loro percezione di tali controversie. Ammesso che nel capoluogo emiliano la situazione sia ottimale rispetto ad altre città italiane, abbiamo registrato un tendenziale accordo con le problematiche evidenziate dagli esperti in materia, in particolare per quanto riguarda l’inquadramento dello stesso diritto di abortire. Sin dal suo concepimento, infatti, tale diritto è da ricondursi nell’alveo del diritto alla salute e non a quello di autodeterminazione della donna[5]. In particolare, è stato osservato come il legislatore negli anni ‘70 sia stato fortemente influenzato dalle radici patriarcali della sessualità, che all’epoca non riconoscevano la libertà sessuale e riproduttiva delle donne. L’aborto è stato immaginato quindi, necessariamente, come uno scontro fra i diritti di due soggetti[6], piuttosto che come una delle pratiche cui la donna può fare ricorso per esercitare il proprio diritto di autodeterminarsi. Ne deriva che la donna debba giustificare la sua scelta di fronte ai medici incaricati e possa, teoricamente, ricorrere alle pratiche abortive solo ove queste siano necessarie per tutelare la salute e la vita della gestante stessa.
In aggiunta, come osservato dall’ex Vicepresidente del Comitato europeo dei diritti sociali Petros Stangos, quello della legge 194 appare essere un testo parziale, fazioso[7]. Nelle disposizioni che avvallano l’ingerenza diretta di consultori e strutture sociosanitarie al fine di aiutare la donna “a rimuovere le cause che la porterebbero all’interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e madre” (legge 194/78, art. 5), infatti, emerge l’inclinazione a sfavorire l’aborto, optando piuttosto per una serie di azioni persuasive nei confronti della gestante. Di fatto, l’articolo 4 e, in particolare, il sopracitato articolo 5 disciplinano l’accesso all’aborto prevedendo un insieme di iniziative atte a eliminare le motivazioni che potrebbero portare al ricorso all’IVG. Così i consultori familiari vengono investiti del compito di neutralizzare i problemi economici portati a giustificazione di un aborto e i giorni d’attesa imposti alla soggettività che avanzi richiesta di IVG sarebbero un ulteriore mezzo persuasivo per promuovere l’abbandono del desiderio di abortire. Questa lettura trova un riscontro concreto nelle testimonianze dei nostri intervistati, in particolare fra le attiviste. Ci si chiede, infatti, che scopo abbia l’ulteriore prolungamento dei tempi di attesa per procedere all’IVG se non quello di far scadere il limite massimo di 90 giorni, dopo cui abortire legalmente diventa impossibile.
L’obiezione di coscienza
Ovviamente, il problema “principe”, emerso con forza in tutte le nostre interviste, resta quello dell’obiezione di coscienza, previsto dall’articolo 9 della legge 194/78. La possibilità per il personale sanitario orbitante attorno alle pratiche abortive di rifiutarsi di operare, previa presentazione di un’apposita dichiarazione, può condizionare fortemente la scelta della donna. In taluni casi, come si evince dalle numerose testimonianze condivise tanto dalla stampa quanto dalle associazioni transfemministe[8], dietro la maschera dell’obiezione si nasconderebbe un vero e proprio tentativo di sabotaggio, fatto gravissimo eppure molto difficile da provare. È certo che, nonostante le dichiarazioni del governo italiano, gli alti livelli di obiezione finiscano per determinare un’effettiva discriminazione fra le soggettività residenti in determinate zone del nostro Paese. È di questo avviso anche il Comitato europeo dei diritti sociali, che ha segnalato una violazione dell’articolo 11 della Carta dei Diritti Sociali in quanto il servizio sanitario italiano non sarebbe organizzato in modo tale da garantire senza eccezioni la disponibilità del personale medico e ausiliario non obiettore, considerando che la quantità e la tempistica delle richieste di IVG non possono essere conosciute in anticipo[9].
Di riflesso, viene alimentato il fenomeno del cosiddetto “turismo abortivo”, nato proprio per aggirare la difficoltà di accedere tempestivamente – o comunque in tempo utile – ai servizi di interruzione volontaria di gravidanza sul proprio territorio. A sua volta, l’accumulo di richieste rivolte a una singola struttura (per esempio, nel caso in cui fosse l’unica in città a offrire servizi di IVG) andrebbe a esacerbare il problema delle liste d’attesa ed è credenza comune nei circoli di medicina che un’alta percentuale di obiettori in struttura pregiudichi le possibilità di carriera dei professionisti non obiettori, che sarebbero relegati a svolgere unicamente le mansioni collegate alle interruzioni di gravidanza.
E i problemi legati alla 194 non sono ancora finiti.
La legge 194 in numeri: i (non) dati
Se un’azione di modifica sull’articolo 9 della legge 194 è difficile a immaginarsi – almeno nel breve termine – un aiuto alternativo e sostanziale per le persone gestanti può essere quello di avere una mappatura chiara, in costante aggiornamento e completa dell’ubicazione e del numero di obiettori di coscienza per singola struttura. Purtroppo, con i dati che il Ministero della Salute fornisce ogni anno sull’andamento dell’applicazione della l. 194/78 si può fare ben poco: le informazioni condivise con il pubblico sono perennemente in ritardo (basti pensare che la Relazione depositata a giugno 2022 si riferisce ai dati dell’anno 2020), derivano da dati chiusi e spesso aggregati, e non sono pertanto in grado di rispecchiare la reale capacità del servizio sanitario nazionale di garantire il fondamentale diritto all’IVG. Inoltre, i dati sono caricati in rete in formato PDF, che ne rende impossibile la facile estrazione ed elaborazione. Anche le singole regioni, altrettanto incaricate di presentare i dati inerenti le interruzioni volontarie di gravidanza nel rispettivo territorio, risultano perlopiù manchevoli e incapaci di fornire informazioni esaustive.
Oltre alla mappatura aperta, limpida e attuale di cui sopra, il governo italiano dovrebbe anche essere in grado di riportare il numero di non obiettori che effettuano le pratiche abortive; se e in quali strutture che non prevedono il servizio venga comunque assicurato il percorso di aborto, come richiesto dalla normativa vigente; e di indicare numero e ubicazione delle strutture in cui non si svolgono interruzioni volontarie di gravidanza.
Per tentare di sopperire alle mancanze statali, reti di associazioni sparse sul territorio italiano sono attive già da tempo per realizzare mappe più complete, utili e funzionali. Anche grazie a queste, e in particolare basandoci sui lavori “dal basso” del collettivo bolognese Mujeres Libres, dell’associazione Luca Coscioni e di Obiezione Respinta, abbiamo potuto valutare un’immagine, se non reale, quantomeno più realistica dell’attuale situazione in fatto di IVG nel capoluogo emiliano e in Italia.
Di aborto, legale o illegale, doloroso o liberatorio, negli ultimi mesi si è parlato molto. Se ne parla quasi ogni giorno e in svariati termini: l’aborto è un diritto, l’aborto è una lotta sociale, l’aborto è un terreno fertile su cui politica e opinione pubblica si dividono, si scontrano e uniscono continuamente. Noi, studentesse, aspiranti giornaliste e, soprattutto, donne abbiamo scelto di parlarne attraverso i racconti di chi, in un modo o nell’altro, a Bologna è entrato in contatto con il servizio di interruzione volontaria di gravidanza. Innumerevoli le voci interpellate: attiviste da diversi collettivi della città, alunni/e e professori di ginecologia impiegati all’Università di Bologna, membri dell’AUSL bolognese e medici operanti in reparto si sono resi disponibili per aiutarci a disegnare un quadro più completo possibile. Ciò che è emerso è confortante, ma la strada verso la conquista di un diritto di autodeterminazione della soggettività gestante è ancora lunga e tortuosa.
Se non avete ancora un’opinione sul tema, se pensate che la “questione aborto” non vi tocchi o se, al contrario, l’avete particolarmente a cuore: ascoltate questa inchiesta.
Trovate gli episodi sul canale Spotify Compassunibo.
Buon ascolto!
A cura di Giulia Barnabò, Martina Bernardini, Chiara Bernini, Serena Convertino e Giorgia Manfé.
[1] Gli Stati in cui l’IVG è stato dichiarato illegale sono Alabama, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Oklahoma, South Dakota, Tennessee e Texas.
[2] Per queste e altre reazioni dai leader italiani e internazionali, si veda l’articolo di SKY TG24 al link: https://tg24.sky.it/mondo/2022/06/24/aborto-usa-corte-suprema-reazioni
[3] Anche Matteo Salvini (Lega) e Silvio Berlusconi (Forza Italia) hanno sottoscritto la Carta valoriale dell’associazione. Per i dettagli si legga l’articolo dell’Espresso al link: https://espresso.repubblica.it/politica/2022/09/29/news/giorgia_meloni_matteo_salvini_e_silvio_berlusconi_pro_vita_aborto-367814306/
[4] Il testo, non ancora disponibile pubblicamente, è stato annunciato nella seduta n. 29.
[5] Di Masi, M. (2014) Obiezione di coscienza e interruzione volontaria di gravidanza: il Consiglio d’Europa ammonisce l’Italia.
[6] Brunelli, G. L’interruzione volontaria della gravidanza, cit., p. 835. Cfr. Mancini, S. Un affare di donne. L’aborto tra libertà eguale e controllo sociale, Padova, Cedam, 2012, p. 15
[7] Di Masi, M. (2014) Obiezione di coscienza e interruzione volontaria di gravidanza: il Consiglio d’Europa ammonisce l’Italia. Pag. 5
[8] Si vedano, per degli esempi, la mappa degli obiettori di coscienza dell’associazione Obiezione Respinta e i racconti raccolti nell’ambito della campagna “Abortisco e non mi pento” del collettivo transfemminista bolognese Mujeres Libres.
[9] Di Masi, M. (2014) Obiezione di coscienza e interruzione volontaria di gravidanza: il Consiglio d’Europa ammonisce l’Italia. Pag. 3